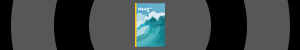Economia
Da Davos al Mercosur, il mondo ha smesso di credere al libero mercato. L’Italia deve ancora decidere se farlo
Il commercio diventa una scelta politica tra ritorno dello Stato, filiere strategiche e una leadership europea ancora incerta

Donald Trump Davos
L'analisi
L’economia globale non è più neutrale. Continuare a far finta che lo sia rischia di diventare, per l’Italia, non solo un errore analitico ma un limite politico. Il World Economic Forum di Davos, anche quest’anno, è stato raccontato come il luogo del dialogo globale. In realtà, sempre più apertamente, funziona come uno spazio di presa d’atto: il mondo economico è entrato in una fase strutturalmente diversa, in cui scambi, investimenti e filiere rispondono a logiche politiche prima ancora che di mercato.
Non si tratta di stabilire se la globalizzazione sia finita. È un dibattito superato. La questione vera è che governi, imprese e mercati hanno già interiorizzato il cambiamento e stanno agendo di conseguenza. La narrativa pubblica, soprattutto europea, fatica invece a stare al passo.
Gli Stati Uniti lo dimostrano con chiarezza. Al di là delle dichiarazioni più rumorose di Donald Trump, ciò che emerge è una continuità strategica ormai consolidata: l’economia come strumento di potenza. Dazi selettivi, politiche industriali aggressive, incentivi interni, controllo delle tecnologie critiche non sono più eccezioni temporanee, ma parti strutturali dell’arsenale politico americano. Washington non si percepisce più come garante di un ordine neutrale, bensì come attore che utilizza il mercato per rafforzare sicurezza, consenso interno e posizione internazionale.
Questo approccio, che piaccia o no, ha il merito della coerenza. Costringe gli altri attori a fare i conti con una realtà meno ipocrita, ma anche più esigente. L’Europa, invece, resta sospesa tra l’adesione formale al libero scambio e la crescente difficoltà a governarne gli effetti politici e sociali.
Il dibattito sull’accordo UE–Mercosur è, in questo senso, emblematico. Presentato spesso come uno scontro tra apertura e difesa, in realtà riflette una tensione più profonda: quella tra una visione ancora astratta del commercio e la realtà concreta delle filiere produttive. Negli ultimi giorni, anche alla luce delle analisi che circolano tra operatori e associazioni di settore, emerge un dato meno raccontato: ampie parti del sistema industriale europeo, incluse filiere manifatturiere, della trasformazione e del comparto conserviero, guardano con favore all’accordo, a condizione che sia accompagnato da regole chiare, standard condivisi e strumenti di riequilibrio.
Non si tratta di ingenuità o di cieca fiducia nel mercato. È la consapevolezza che, in un mondo frammentato, l’accesso a grandi spazi economici integrati può rappresentare un vantaggio competitivo, soprattutto per chi opera lungo catene del valore complesse, dove la trasformazione industriale conta quanto – se non più – della produzione primaria. Continuare a leggere il Mercosur esclusivamente attraverso la lente delle marginalità settoriali, pur legittime e importanti, rischia di perdere di vista il quadro complessivo: la capacità di tenere insieme filiere, occupazione, investimenti e posizionamento internazionale.
Questo non significa apertura indiscriminata. Significa riconoscere che il commercio, oggi, è una scelta politica e va governato come tale: con clausole, tempi, compensazioni e politiche di accompagnamento. Ma rifiutarlo in blocco equivale spesso a rinunciare a strumenti di influenza in un mondo che non aspetta.
Davos 2026 ha mostrato con chiarezza che questa consapevolezza è ormai diffusa. Nessuno parla più seriamente di ritorno all’ordine economico pre-2020. Le catene del valore vengono accorciate, regionalizzate, ridisegnate. L’efficienza pura cede il passo alla resilienza. La crescita resta necessaria, ma viene subordinata alla stabilità politica e sociale. La finanza, molto più avanti della politica, ha già incorporato questa realtà: la geopolitica non spaventa più, viene prezzata.
In questo scenario, anche il ritorno dello Stato nell’economia non è vissuto come un’anomalia, ma come una condizione strutturale. Investimenti pubblici, strumenti misti, politiche industriali mirate diventano elementi ordinari del sistema, non eccezioni emergenziali. Non per ideologia, ma per necessità.
Ed è qui che la questione italiana diventa centrale. L’Italia non è marginale in questo nuovo assetto. Dispone di grandi attori energetici, industriali e finanziari, di una posizione geografica strategica e di una tradizione manifatturiera che attraversa filiere lunghe e sofisticate. Eppure, troppo spesso, fatica a trasformare questi asset in una narrazione politica coerente.
Il problema non è l’assenza di una linea ideologica forte. È l’assenza di un raccordo stabile tra dimensione economica, dimensione sociale e collocazione internazionale. Negli ultimi anni, l’Italia ha spesso separato ciò che oggi dovrebbe essere tenuto insieme: mercato e consenso, competitività e coesione, politica interna e politica estera economica. Il risultato è una gestione reattiva, più che strategica, delle trasformazioni in corso.
Il mondo che emerge da Davos, dagli Stati Uniti, dal Mercosur pone invece una richiesta chiara: politiche economiche che sappiano assumersi la responsabilità delle conseguenze sociali e politiche delle scelte di apertura, senza per questo rifugiarsi nella chiusura. Non tutto può essere lasciato al mercato, ma nemmeno tutto può essere bloccato in nome della difesa di equilibri che non esistono più.
Per l’Italia, questa fase rappresenta più un’opportunità che una minaccia. A patto di smettere di inseguire categorie del passato e di iniziare a costruire una politica economica consapevolmente politica, capace di scegliere, di spiegare e di accompagnare. Meno slogan, meno riflessi difensivi, più architettura strategica.
L’economia globale non tornerà neutrale. La domanda, per l’Italia, non è se opporsi a questa realtà, ma come abitarla senza perdere coesione, competitività e credibilità. In fondo, è questa la vera sfida politica dei prossimi anni.