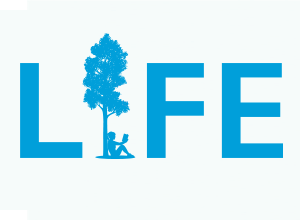Milano
"Non si può morire per una partita": Heysel, il dolore che non passa
L’Heysel non fu una tragica fatalità. Fu il frutto di incuria, superficialità e irresponsabilità a ogni livello. Oggi, ricordare l’Heysel non è solo un atto di pietà. È un dovere civile

"Non si può morire per una partita": Heysel, il dolore che non passa
30 maggio 1985. Ho visto mio padre piangere due volte nella sua vita. La prima quando è morta sua madre. La seconda, quella mattina di fine maggio, mentre leggeva il Corriere della Sera al tavolo della cucina. Avevo otto anni. Mi prese in braccio, mi strinse forte. «Non si può morire per una partita di calcio!», sussurrò con la voce spezzata. Gli occhi vitrei, lo sguardo altrove. Aveva appena letto il nome di un suo ex compagno di liceo, tra i 39 morti della sera precedente, allo stadio Heysel di Bruxelles. Quel momento – l’abbraccio, il dolore, la rabbia muta di un uomo cresciuto con il mito del calcio romantico – è rimasto inciso nella mia memoria come una fotografia. Quarant’anni dopo, sembra ieri.
Una finale trasformata in tragedia
Il 29 maggio 1985 si giocava la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, due delle squadre più titolate d’Europa. Doveva essere una festa del calcio. Si trasformò in un incubo.
Allo stadio Heysel – struttura già allora obsoleta, con muri di contenimento fragili e settori mal divisi – migliaia di tifosi si accalcarono, tra tensione, improvvisazione e disorganizzazione totale. Il settore Z, che avrebbe dovuto ospitare tifosi neutrali, finì per contenere centinaia di juventini, circondati da tifosi inglesi, molti dei quali violenti e alterati dall’alcol. Poco prima del fischio d’inizio, un gruppo di hooligan del Liverpool sfondò le barriere e assaltò il settore Z. La folla italiana, terrorizzata, cercò scampo schiacciandosi verso un muro pericolante, che crollò.
Trentanove morti, la maggior parte italiani. Centinaia di feriti. Tutto prima che la partita iniziasse. Ma la partita si giocò ugualmente, nel tentativo disperato delle autorità di evitare un’ulteriore esplosione di violenza. Vinse la Juventus. Ma quella coppa, ancora oggi, pesa come una croce.
Le responsabilità di una strage annunciata
L’Heysel non fu una tragica fatalità. Fu il frutto di incuria, superficialità e irresponsabilità a ogni livello: da parte della UEFA, che scelse uno stadio indegno per una finale europea; della polizia belga, impreparata e assente nei momenti decisivi; delle tifoserie violente, in particolare gli hooligan inglesi, mai realmente arginati.
I processi non resero mai giustizia pienamente ai morti. Alcuni tifosi inglesi furono condannati per omicidio colposo. Ma le ferite rimasero, spesso ignorate. In Italia, la memoria dell’Heysel è stata a lungo rimosso o scomoda, forse perché disturbava il racconto epico di una vittoria.
I nomi, non i numeri
Oggi, a distanza di quarant’anni, ricordiamo non solo la tragedia, ma le vite spezzate. Erano padri, figli, fratelli, amici. Tra loro Giancarlo, l’ex compagno di liceo di mio padre. C’era anche Andrea Casula, 11 anni, il più giovane. E tanti altri, uniti da una stessa passione, quella per la Juve e per il calcio.
Ma non si può morire di calcio. Non si può uscire di casa per una partita e non tornare più. Non si può accettare che la violenza, l’incompetenza e l’avidità prendano il sopravvento sullo sport e sull’umanità.
In memoria, per davvero
Oggi, ricordare l’Heysel non è solo un atto di pietà. È un dovere civile. È dire ai più giovani che lo sport non vale una vita umana. È chiedere ai dirigenti, alle istituzioni, ai media, di non voltarsi mai più dall’altra parte. È dire, con le parole di mio padre: «Non si può morire per una partita di calcio.»
Mai più.