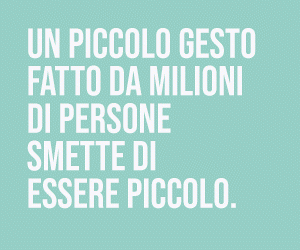News
Testa Bappenheim: "Le nomine lampo di Pechino? Svelano la partita segreta tra Vaticano e Cina”
L'intervista a Stefano Testa Bappenheim, canonista ed ecclesiasticista presso l’Università di Camerino

Testa Bappenheim: "Le nomine lampo di Pechino? Svelano la partita segreta tra Vaticano e Cina”
Perché due vescovi cinesi sono stati nominati poco dopo la morte di Papa Francesco? Uno sgarbo al Vaticano, un messaggio? “Possiamo ipotizzare sia stata prevista una qualche forma di consultazione tra Santa Sede e Governo cinese in merito alla nomina dei Vescovi, cosa peraltro abbastanza comune sia nei secoli passati in Europa che nei concordati di inizio Novecento”.
Del resto, a Pechino la religione interessa: “è possibile che le autorità cinesi si siano rese conto che il fattore sociale e religioso non è causa di instabilità sociale, e può invece, da un lato, instillare un'etica anticorruzione, e dall'altro colmare quel vuoto spirituale che non può essere soddisfatto dal puro e semplice consumismo”. Il professor Stefano Testa Bappenheim, canonista ed ecclesiasticista presso l’Università di Camerino, conosce il tema della libertà religiosa in Cina e parla con Affaritaliani.it mentre i cardinali si apprestano a entrare in Conclave.
Il tema della Cina è stato sollevato nel corso delle Congregazioni generali dei cardinali, e questo ha portato a notevoli polemiche specie sull’atteggiamento della Santa Sede: apertura o chiusura? Che cosa dovrà fare il prossimo Papa: per Testa Battenheim bisognerà andare avanti nel dialogo perché “il rispetto e l'attenzione della Chiesa, della Santa Sede, verso la Cina è costante nel corso dei secoli. Perché, come dice il canone 1752 del Codice di diritto Canonico, salus animarum suprema lex (la salvezza delle anime è la legge suprema, N.d.R.) e alla Chiesa e alla Santa Sede interessano le anime dei cinesi a prescindere dal sistema politico”. E questo è il vero punto cardine del tema Cina.
Ho il piacere di parlare con il professor Stefano Testa Bappenheim, che è docente di diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Camerino, ed è tra l'altro uno dei principali esperti nel nostro paese dell'accordo tra la Cina e la Santa Sede. Lo voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità, anche perché naturalmente in questi giorni il tema appunto della Cina è molto presente nelle discussioni dei cardinali in pre-conclave. Professore, dagli anni ‘50 la Cina, anzi precisamente nel 1958 ha creato questa chiesa autocefala, che non riconosce quindi l'autorità del Papa di Roma, l'Associazione patriottica. Poi dopo lunghi anni, grazie a Papa Francesco, abbiamo avuto l'accordo con Pechino, accordo che è stato mediato dall'attuale segretario di stato Pietro Parolin. Come funziona questo accordo a grandi linee?
La ringrazio per quest’intervista: mi occupo dal 2004 della normativa sulla libertà religiosa in Cina, ma questo accordo è segreto. Quello a cui abbiamo assistito in questi ultimi vent'anni, e che è sotto gli occhi di tutti, è un fortissimo avvicinamento della Cina nei confronti dei vari protagonisti della scena internazionale, con l'ingresso nel WTO, i giochi olimpici, eccetera. In questa prospettiva, già nel 1999, con il documento 26, il Comitato centrale del Partito comunista cinese decise di procedere verso la normalizzazione delle relazioni fra Repubblica Popolare Cinese e Santa Sede.
Anche grazie alla maggiore internazionalizzazione dei rapporti, peraltro, è possibile che le autorità cinesi si siano rese conto che il fattore sociale e religioso non è causa di instabilità sociale, e può invece, da un lato, instillare un'etica anticorruzione, e dall'altro colmare quel vuoto spirituale che non può essere soddisfatto dal puro e semplice consumismo, a seguito forse di un certo intiepidimento del materialismo scientifico di impronta marxista.
Per quanto ricordi, il nodo di questo accordo è sempre stato la nomina dei Vescovi e in particolare l'approvazione da parte di Roma, perché ricordiamo pure a chi ci sta leggendo che Pechino ha sempre rimproverato a Roma di essere sostanzialmente una potenza straniera, il Papa, un capo di stato straniero, e quindi Pechino non accetta che ci siano delle decisioni prese sul proprio territorio da un capo di una potenza straniera. Allora, questo accordo, insomma, tra la Cina e Roma, che viene molto criticato e molto attaccato anche perché è ritenuto molto generoso, molto largo verso i cinesi, e lo stesso cardinale Joseph Zheng Zekiu, l'ex arcivescovo di Hong Kong, è sempre stato contrario e l'ha sempre criticato. C'è una limitazione quindi della libertà della Chiesa? E se sì, dove?
Ma l'accordo purtroppo è segreto. Possiamo ipotizzare sia stata prevista una qualche forma di consultazione tra Santa Sede e Governo cinese in merito alla nomina dei Vescovi, cosa peraltro abbastanza comune sia nei secoli passati in Europa che nei concordati di inizio Novecento. Sarà infatti solo il decreto di Paolo VI, Christus Dominus del 1965, a dire al numero 20 che in avvenire non sarebbero più stati concessi alle autorità civili diritto, privilegi di elezione, nomina e presentazione dei Vescovi, e a pregare le autorità civili che ancora li avessero, per ragioni concordatarie, di rinunziarvi. Immagino che l'obiettivo della Santa Sede resti quello, con tempistiche però che non si possono prevedere.
Xi Jinping parla di sinizzazione dei riti, delle fedi. Questa cosa si può, diciamo così, conciliare con il cattolicesimo? Viene in mente Matteo Ricci con i cosiddetti riti cinesi, mi verrebbe da citare lo stesso Franco Battiato, i Gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi in attesa di entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. È ancora così?
Guardi, il più grande apostolo della Cina moderna, il cardinale Celso Costantini, veneto, diceva che il grande problema della Chiesa Cattolica in Cina potesse venire risolto solo con una maggiore sinizzazione, perché inizialmente tutta la gerarchia ecclesiastica era europea e veniva percepita come un'organizzazione straniera. Questo primo ostacolo venne superato grazie alla nomina dei primi sei vescovi cinesi nel 1926, fatta da Pio XI, e poi della gerarchia episcopale in Cina istituita da Pio XII con la Quotidie Nos del 1946.
A Costantini si deve forse la prima formulazione compiuta della necessità di sinizzazione della Chiesa, perché Costantini parte dal presupposto che Cristo ha fondato la Chiesa con carattere cattolico, cioè i lavori francesi in Francia, americani in America, cinesi in Cina. Il prelato veneto teorizza la sinizzazione della Chiesa, dal momento che ogni popolo ha il proprio carattere, e dice che bisogna fare in Cina quello che fu fatto in Occidente, cioè piantare la Chiesa con la sua gerarchia indigena e con forme esteriori meno occidentali.
Peraltro il presidente Xi Jinping in gioventù ha vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti, quando era ancora un funzionario in carriera, e ha avuto modo di sperimentare, perché non visse nella bolla diplomatica di Washington o in qualche comunità cinese, ma visse nell'America rurale, ospite di una famiglia americana. Visse dal vivo il principio del rule of separation che c'è negli Stati Uniti, quindi uno Stato che è autonomo e indipendente dalle confessioni religiose, ma non è aggressivo verso le confessioni religiose, come invece abbiamo altri esempi in giro per il mondo. Penso che questa constatazione del fatto che Stato e confessioni religiose possano convivere pacificamente, abbia certamente influenzato la sua formazione e le sue opinioni in questo campo.
Morto il Papa il 21 di aprile, dopo nemmeno due giorni il governo di Pechino ha nominato due vescovi: che cos’è, un messaggio alla Chiesa?
Certamente il tempismo è stato molto infelice, però non sappiamo di preciso il procedimento di nomina dei vescovi concordato nell'accordo segreto. Può darsi che l'iter si fosse ormai avviato e non abbiano potuto o voluto fermarlo, nemmeno per un fatto d'immensa rilevanza come la morte del Papa.
Oltretevere, il Segretario di Stato Pietro Parolin e il cardinale Tagle vengono criticati in questo periodo per il dialogo con la Cina, ma è possibile che la Chiesa si sia dimenticata dell’Ostpolitik degli anni 70?
L’Ostpolitik del cardinal Agostino Casaroli degli anni 70 era appunto nel senso che bisogna tenere presente che non siamo più negli anni 70 con tutti i loro terribili drammi. Il fattore sociale e religioso ha subito un'evoluzione precisa nel quadro politico-istituzionale cinese.
Se possiamo riassumere brevemente, abbiamo un primo periodo del presidente Mao con la religione vista nell'ottica del materialismo dialettico, quindi un retaggio del passato destinato a scomparire per via naturali. Nel secondo periodo della Rivoluzione culturale, cattolicesimo e protestantesimo vengono visti come al servizio degli imperialisti, mentre buddismo, taoismo e Islam al servizio delle forze che volevano il ritorno del feudalesimo: la religione in quanto tale, qualunque essa fosse, era un nemico della lotta di classe e andava perciò combattuta. Il terzo periodo, quello di Deng Xiaoping, vede prioritario unire le forze per lo sviluppo e la modernizzazione del paese e quindi la religione diventa qualcosa da tollerare perché è necessaria la cooperazione di tutti, credenti e non credenti.
Nell'ultimo periodo, quello attuale, abbiamo visto un certo capovolgimento del ruolo della religione, purché sempre nel rispetto della Costituzione, delle leggi e sul controllo dello Stato e del partito, può essere un fattore positivo che può instillare una maggiore etica nei lavoratori, aiutare a combattere la corruzione e fungere da collante sociale nei momenti di crisi generale come la recente pandemia del Covid-19.
Professore, ma allora il prossimo Papa come dovrà gestire i rapporti con Pechino? Come li dovrà impostare secondo lei?
Guardi, dovrà semplicemente fare quello che fecero i suoi predecessori: già nel 1245 infatti, Papa Sinibaldo Fieschi, Innocenzo IV, nel quadro del Concilio di Lione, aveva inviato un legato pontificio, il Francescano Giovanni da Pian del Carmine, al Can dei Tartari, per favorire la conversione al cristianesimo e dissuadere dall'invadere l'Europa. Dopo la missione di Marco Polo, Papa Girolamo Masci, Niccolò IV, il primo pontificio francescano, inviò il confratello Giovanni da Montecorvino, giunse in Cina nel 1294 e tradusse il Salteri, il Nuovo Testamento e il Messale in Tartaro. Clemente V ne dispose poi la consacrazione come arcivescovo di Pechino.
Secoli dopo il testimone venne raccolto dal gesuita Matteo Ricci, che è originario di Macerata, che è una città a pochi chilometri di distanza da Camerino, fino al blackout provocato dalla questione dei riti. All'inizio del Novecento abbiamo avuto un nuovo Matteo Ricci, cioè il vescovo veneto, poi cardinale Celso Costantini, che è davvero un nuovo apostolo della Cina. E quindi il rispetto e l'attenzione della Chiesa, della Santa Sede, verso la Cina è costante nel corso dei secoli. Perché, come dice il canone 1752 del Cogito Canonico, salus animarum suprema lex (la salvezza delle anime è la legge suprema, N.d.R.) e alla Chiesa e alla Santa Sede interessano le anime dei cinesi a prescindere dal sistema politico.
Per concludere: e la Chiesa clandestina quella che si riunisce nelle campagne, nei garage, e che a quanto pare viene perseguitata da Pechino eppure mantiene questa fedeltà a Roma, tanto che Papa Ratzinger nel 20’7 scrisse per loro parole piene di affetto?
Già la lettera di Benedetto XVI ai Cattolici Cinesi nel 2007 abrogava le disposizioni speciali del 1988 sui rapporti fra Chiesa patriottica e Chiesa clandestina, sottolineando che la clandestinità può essere una fase transitoria di uno sviluppo ecclesiale, non può essere una condizione permanente, e Benedetto XVI invitava sempre a superare questa dolorosa divisione col tempo, le preghiere e l'impegno comune. E penso che la speranza di Benedetto XVI abbia ancora indubbiamente una sua validità, formulata con la grande lucidità che quel Papa ha mostrato nei suoi documenti.