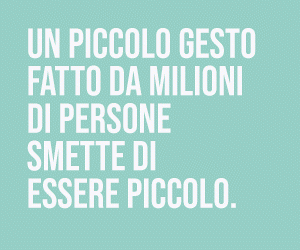Culture
Natale in casa Cupiello, il sogno impossibile di un uomo mite



di Antonio Magliulo
Da acuto osservatore della realtà quale era, Eduardo de Filippo seppe cogliere, forse più d'ogni altro artista, il sentimento che il Natale suscita nel cuore della gente mite. Nato in una città, dove tale ricorrenza è sempre stata oggetto di un culto forte, avvertito, finanche eccessivo, trovò quasi inevitabile descriverlo. Ovviamente, lo fece a modo suo, da drammaturgo, creando una delle sue commedie più apprezzate e conosciute: Natale in casa Cupiello.
La trama è fin troppo nota, dunque non c'è bisogno di riassumerla. Appare invece più utile sintetizzarne la storia.
Rappresentata per la prima volta, come atto unico, al teatro Kursaal di Napoli, nel 1931, Natale in casa Cupiello subì, nel tempo, diversi rimaneggiamenti, perdendo a poco a poco la sua marcata impronta umoristica e assumendo il carattere di una storia completa, realistica e "impegnata". Il segreto del suo enorme successo sta, infatti, proprio nella sapiente miscela agrodolce, che unisce il sentimento del comico col tragico, una capacità che appartiene da sempre alla gente partenopea, come fosse una risorsa sua propria, un bene inestimabile, atto a mitigare le contrarietà e a sorreggere gli uomini di fronte alle sciagure.
Eduardo, oltre a scrivere la commedia, la portò pure in scena, con inimitabile maestria. Tutti ricorderanno la sua superba interpretazione di Cupiello. Le scene più gustose ed ironiche si rinvengono nel primo e secondo atto, ma le più incisive sono quelle finali, dove l'artista dà prova delle sue formidabili capacità attorali. Nel terzo atto, infatti, il sipario si leva e Luca Cupiello, da sano ed alacre cinquantenne, è diventato infermo, vecchio, stravolto nei lineamenti; è seduto nel letto matrimoniale, sorretto da due cuscini e avvolto in uno scialle. I suoi capelli sono spettinati, arruffati sul capo e sembrano persino più bianchi. La bocca è evidentemente distorta e gli disegna in faccia un strano sorriso, come il ghigno sardonico di un pupo siciliano. Gli occhi sono asimmetrici e ripropongono la medesima disarmonia labiale. Anche uno dei sopraccigli è sollevato rispetto all'altro. Il braccio sinistro è fermo, bloccato dalla paresi. La sua parlata è lenta, affannosa, farfugliata e somiglia un po' a quella di un bambino. Attorniato da un nugolo di gente, che sembra riprodurre una scena di gruppo presepiale, Luca racconta confusamente aneddoti del proprio passato.
Nelle didascalie che corredano il copione, Eduardo spiega cosa è successo esattamente al protagonista della storia: "La realtà dei fatti ha piegato come un giunco il provato fisico dell'uomo che per anni aveva vissuto nell'ingenuo candore della sua ignoranza". E, grazie al prodigio mimico-espressivo, compiuto a perfezione da Eduardo, tal'è esattamente il personaggio che si vede in scena. A un tratto, mentre la vicenda si avvia a conclusione, si diffonde nell'aria il tipico suono delle ciaramelle. È evidente che il povero Cupiello è moribondo. Con l'ultimo briciolo di energia rimastagli, scambia un'ultima battuta col figlio, domandandogli, accoratamente: "Te piace 'o presepio?" e questi, con gli occhi lucidi, risponde finalmente: "Sì". Soddisfatto, Luca cade in una sorta di trance. I suoi occhi si volgono altrove, sembrano persi nelle "luminarie", fra le stradine di trucioli, le grotte di sughero e le casette di carta, immerse nel morbido muschio. Si comprende benissimo che lì è andato, Luca Cupiello, a cercare fra le immote e rassicuranti figure dei pastori quella pace che aveva tanto agognato.
Nel 1977, Eduardo cambiò alcune, significative, battute dell'opera e in un'intervista esplicitò il perché della sorte toccata al personaggio: "Luca Cupiello muore e deve morire anche se suscita pietà...". E aggiunse: "Egli è vittima perché si è prestato a un giuoco di illusioni infantili. Il presepe che costruisce è una specie di droga, che paralizza la fantasia e distoglie dalla realtà del vivere quotidiano", come a dire, insomma, che in un mondo dove alberga il male non possono esserci innocenti, ma si è tutti, in qualche misura, corresponsabili, colpevoli.
Ma, francamente, questa spiegazione disorienta un po'. Sembra dettata da un ripensamento, da una sorta di autorevisione ideologica, intervenuta successivamente. Seppure sacrosanta e legittima, perché mossa dallo stesso autore, questa "accusa" d'ignavia oppure di sprovvedutezza grava eccessivamente su Cupiello. Egli, in fondo, non rimane impassibile di fronte ai problemi familiari e, per quanto maldestramente, si adopera per aggiustare le cose.
Il fatto è che in principio, Eduardo volle rappresentare un sognatore sopraffatto, schiacciato dalla cruda realtà intorno a lui. E tale esso è rimasto nell'immaginario collettivo, suscitando, proprio per questa sua ingenuità, tanta comprensione e simpatia. È noto che, una volta creati, i personaggi vivono di vita propria, indipendentemente dalla volontà del loro autore. D'altra parte, il contenuto della vicenda è chiaro e non ha bisogno di commenti: la casa dei Cupiello riflette le sfaccettature, spesso dolorosissime, della realtà. Il presepe, di contro, è quel luogo di pace nel quale si confida ingenuamente, dimenticando, a volte, che è solo un artificio.
C'è, tuttavia, una dignità nei sogni, che non andrebbe mai disconosciuta. In un mondo difficile, funestato da miseria, morbi e sanguinosi conflitti, sul quale vegliano inattendibili angeli di metallo e dove le comete, nel cielo, somigliano, terribilmente, ai bagliori dei razzi e delle bombe, la scena di cartapesta può divenire, per un momento (ma solo per un momento) il rifugio degli uomini miti. Molti ne subiscono il fascino, in tanti guardano al presepe, aspettando un improbabile prodigio. La sera della Vigilia, uniti da un comune sentire, secondo un rito antico, struggente e irrazionale, ma bello come soltanto i sogni sanno essere, uomini e donne, grandi e piccini, credenti ed atei si ritrovano lì, dinanzi alla Capanna. A mezzanotte.