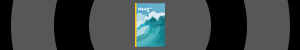Culture
Una microlingua "protagonista" del romanzo d'esordio di Tony Saccucci, presentato a "Libri Come"

Tra i sette miliardi di abitanti della Terra si parlano 7.000 idiomi. Mille di questi sono sull’orlo dell’oblio. I pochi custodi di queste microlingue continuano a morire e, con essi, scompaiono anche vocaboli, storie, modi di dire, identità. L'Italia, uno dei paesi europei con maggiore diversità linguistica, riconosce e protegge una dozzina di lingue minoritarie. Fabrizio De André sosteneva che il dialetto serve a reinventare la lingua nazionale: “nei paesi piccoli, dove si parlano i dialetti, c’è lo spazio, c’è il tempo per riuscire ancora ad inventare la lingua”.
Tony Saccucci, già autore de L’estetica del fungo, fa suo il compito di proteggere una delle identità microlinguiste dialettali e la usa per il suo romanzo d’esordio, Opera d’Arco (Edizione Estemporanee), intarsiandone la vicenda. Con un italiano crudo e pulito, arricchito da incisi dialettali, Saccucci costruisce la storia di unidici ragazzi alle soglie dell’adolescenza alle prese con un “fattaccio” che cambierà la loro vita.
Il dialetto di Opera d’Arco non è affidato alle reminiscenze dell’autore, ma segue le regole del dizionario del novantenne Angelo Tiberi, impegnato da oltre quarant’anni a decodificare la struttura di quel vernacolo. La “lingua” in questione è oggi usata solo da alcune centinaia di persone. Eppure è rimasta inalterata nella sua morfosintassi, anche se, come tutte le lingue vive, ha continuato a evolversi. Saccucci lascia questo paesino avvolto nel mistero, quasi come se invece di un posto reale, questo dialetto nato in un punto preciso della carta geografica fosse in realtà un luogo dell’anima.
Il libro - Rocchetto e Tonino Occhio di Falco la vita l’hanno imparata tra la piazza e la chiesa, tra la scuola e l’osteria. Seguono un codice, quello della montagna. Un codice tutto diverso, legato alla terra e al sangue in cui nessuno, nemmeno Dio e il suo rappresentante in terra, Don Carmine, può entrare. Poi il “fattaccio” cambia la vita di tutto il paese, ma soprattutto quella di Rocchetto e Tonino.
L’autore – Tony Saccucci vive a Roma, dove insegna filosofia nei licei. Per Edizioni Estemporanee ha pubblicato L’estetica del fungo, quello che Gianni Mura ha definito un “divertissement filosofico”: ora alla seconda ristampa, sta per essere tradotto in Francia. Opera d’Arco è il suo esordio letterario.
“In un'era di giovani esordi spesso fin troppo facili e accattivanti, un'opera prima intensa, aspra, severa come la montagna dove si svolge. E una scrittura forte e coraggiosa, che non tradisce ma accompagna il lettore nel cuore umano della storia”
Luca Briasco
LA PRESENTAZIONE A LIBRI COME:
Libri Come, sabato 16 marzo, ore 14
Auditorium Parco Della Musica, Garage Officina 3
Con l’autore ci sarà Giuseppina Torregrossa
LEGGI SU AFFARITALIANI.IT UN ESTRATTO
(per gentile concessione dell'editore)
1. LE BANDE
Il Tiglio La Quercia
Tonino Occhio di Falco Marco Frustone
Claudio Becco d’Aquila Dino Fischietto
Rocco Rocchetto Fabrizio Gliu Mutaréglio
Peppe Rapacciu Pierpaolo Pugnetta
Mario Mancinèlla Ugo Ugaccio
Francesco Franchittu
Tonino Occhio di Falco si vantava che ce l’aveva più lungo di tutti e undici. Pure i peli erano lunghi, e ricci. A quattordici anni guidava la vecchia Fiat 1100 grigia coi sedili di pelle, rossi, sbiaditi dal sole e consumati dai pantaloni. Nascondeva una copia di Playboy e una de Le Ore alla capanna di legno che stava sul grande Tiglio. Quella casetta la banda dei cinque l’aveva ereditata, costruita qualche anno prima da quelli più grandi che si rintanavano tra quelle quattro tavole a spararsi le seghe di gruppo. Erano mezze palanche fissate sui rami coi chiodi del dieci, la misura più grossa, seconda solo agli chiói da cattèllo. C’avevano messo pure la stufetta a legna con la canna fumaria che sputava il fumo fuori dal tetto. Per non far passare l’acqua tra una tavola e l’altra, sopra al tetto avevano aggiunto l’eternit. Ancora non si sapeva che faceva venire una brutta malattia. C’era un unico spiovente sufficiente per i cinque metri quadrati, che a fare una casa su un albero te fa’ un guru còme un zìcchiu. La stufetta era un bidone da 25 litri dell’olio del motore che Claudio s’era fregato da Ròta, un amico e mezzo socio del padre che si arrangiava a fare il meccanico in una specie di casolare adattato a officina fuori dal paese.
Claudio ce l’aveva che girava a destra, con meno peli di Tonino, e però ce li aveva lisci. I ragazzi più anziani lo avevano soprannominato Becco d’Aquila, per il naso con una gobba spigolosa e tutto storto da una parte, la parte opposta di dove gli pendeva il pisello.
Tonino Occhio di Falco e Claudio Becco d’Aquila facevano vedere a tutti come tirarsi le pippe, che gliel’avevano insegnato gli inquilini precedenti. Questa cosa le generazioni se la tramandavano con una certa perizia. Ma per tutti gli altri spelacchiati e cazzettini mosci restava un rito misterioso, e dalla vergogna non ze caléanu gli cazuni mangu pe’ ppisciàne. Quando Peppe s’era spogliato la prima volta sicuro che lo avrebbero apprezzato anche i più dotati aveva già fatto le prove. Ne sapevano qualcosa le pecore di Zi’ Perzèta. Invece di farsi le pugnette, andava ad aiutare il vecchio pastore a toccà le pècora pe’ mmógne, e quando quello si allontanava gliele scopava.
Peppe aveva tredici anni, tre in più di Mario il cugino. Mario era un lanciatore di sassi da olimpiade, mancino che tutti lo prendevano per il culo quando faceva ogni cosa al contrario. Aveva sempre il dorso della mano strisciato d’inchiostro, che quando scriveva poi ci ripassava sopra. Lo chiamavano Mancinèlla, e la madre non voleva perché pensava che era un nome da femmina. Ma quando calciava con l’interno e il pallone girava come un boomerang per arrivare dove aveva deciso, lo ammiravano e basta, che nessuno era capace di tirare in quel modo. Senza Mancinèlla non si potevano battere i sei dell’altra banda, neanche quando gli mancava qualcuno. Era un fuoriclasse. Però era pure cocciuto come un mulo, a scuola era il peggiore e non sapeva le tabelline.
Il meglio era Rocco, battezzato così perché era nato due giorni dopo la morte dell’omonimo padre del padre. E però i genitori lo avevano chiamato da subito Rocchetto, per distinguerlo dallo scopino del paese vicino che portava una barba schifosa, e non si capiva dove finiva e cominciavano i capelli. Rocchetto come tutti gli altri non studiava niente ma prendeva i voti più alti. Insegnava la storia a Tonino e Claudio che facevano la terza media per la seconda volta. A pallone era il più scarso. Non gli piaceva correre dietro al pallone. Ci giocava perché bisognava battere quei sei, e lui l’unica cosa che sapeva fare bene era dare zampate alle caviglie degli avversari. Che pure quello serviva.
Rocchetto, undici anni compiuti, si sarebbe presto trasformato in un peccatore vero, e per questo in un aspirante suicida. Non si spogliò mai davanti a nessuno nemmeno quando scoprì che Tonino a guardarlo nudo si sarebbe vergognato della sua appendice da strapazzo. Ma anche a volerlo fare, non avrebbe potuto, che quando mise i peli pure lui le cose erano cambiate parecchio.