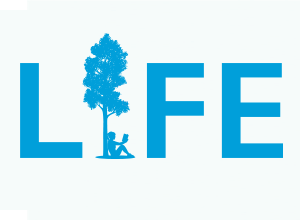Milano
Quando Shostakovich festeggiò la morte di Stalin
Il concerto di Manfred Honeck con la Filarmonica della Scala

Manfred Honech (Foto Giovanni Hänninen/Filarmonica della Scala)
Quando Shostakovich festeggiò la morte di Stalin
Il 5 marzo 1953 muore Josif Stalin (scherzi del caso: lo stesso giorno se ne va anche Sergej Prokof'ev). E Dmitri Shostakovich, bullizzato per quasi vent'anni dal dittatore sovietico, festeggia. Lo fa tornando al genere sinfonico, abbandonato da otto anni, e disegnando nel secondo movimento della 10^ sinfonia – il violento e selvaggio “Allegro” – proprio il profilo del dittatore: parossistico, demoniaco, frenetico, incalzante, lacerante.
Così almeno affermano autorevoli musicologi, secondo i quali è indubbio che la sinfonia sia figlia della “liberazione” dal tiranno che esigeva dai compositori musiche facili, comprensibili dalle grandi masse, invece di quelle decadenti e borghesi, complicate e dissonanti tipiche della produzione di artisti come appunto Shostakovich e Prokof'ev. Questo secondo, breve, movimento, viene dopo uno dei punti più alti della produzione di Shostakovich e, potremmo dire, dell'intera musica del Novecento: il “Moderato” dalle ampie dimensioni (oltre 22 minuti), dalle atmosfere livide, cupe, introverse.
E qui dobbiamo parlare di Manfred Honeck, che lunedì sera ha guidato la Filarmonica della Scala a scalare questo impervio Ottomila, e lo ha fatto con risultati eccezionali. Il primo movimento, con la sua tormentata e angosciosa lentezza, dà l'idea di un Bruckner che si sia perso nelle steppe gelate della Grande Russia e non riesca a trovare la strada di casa. Ma non c'è solo Bruckner: in questo magma musicale si ritrovano echi tardoromantici di Brahms, Ciajkovskij e Sibelius, e in certi passaggi deformati compare anche Mahler. Honeck riesce a far creare dai contrabbassi e dai violoncelli il cupo, densissimo tappeto su cui emergono gli interventi del clarinetto, del flauto, dell'ottavino, in un continuo percorso di tensione e distensione.
Honeck tra Ravel e Strauss alla Scala
Il direttore austriaco che da 18 anni è alla guida della Pittsburgh Symphony Orchestra e ha diretto tutte le più importanti compagini del mondo, ha un gesto netto, chiarissimo, una quasi cartesiana precisione negli attacchi - a prova di strumentista distratto - e riesce a generare un suono opaco, rude, denso e compatto, esaltando come meglio non si potrebbe i forti contrasti dinamici dell'ardua partitura. Grande prova del direttore e orchestra in stato di grazia.
Meno convincente, invece, il Concerto in sol di Ravel, dove il pianista inglese Benjamin Grosvenor dà prova di grande virtuosismo (confermato anche dallo strepitoso bis dei “Jeux d'eau” sempre di Ravel), ma manca di quel senso magico, ipnotico che questo capolavoro richiede. Un'interpretazione più analitica che poetica, verrebbe da dire; anche se il dialogo tra pianoforte e corno inglese del secondo movimento è stato sublime, gli interventi delle percussioni secchi ed elettrici comme il faut, e i richiami jazz del terzo movimento gioiosi in tutta la loro sfrontatezza.
Il concerto era stato aperto dalla gioiosa ouverture del “Fledermaus” di Johann Strauss, dove Honeck ci ha fatto capire cosa si intende quando si parla di “rubato” e di “anticipi” nel valzer viennese, musica che il direttore ha nel proprio dna avendo iniziato la carriera come violinista proprio nei Wiener Philharmoniker, che di quel repertorio sono assoluti “kaiser”.