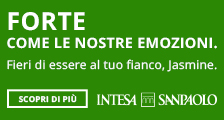Palazzi & potere
L’ultima verità sul “caso Moro”: intervista all’Onorevole Giuseppe Fioroni

Voce al Presidente della Commissione Bicamerale d’inchiesta sul rapimento e sulla morte dello statista democristiano.
di Ernesto Bruno
Il Finanziere (mensile della Guardia di Finanza)
A distanza di 38 anni dalla strage di Via Fani la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul caso Moro da Lei presieduta sta per presentare in Parlamento la relazione finale. È soddisfatto dei risultati ottenuti?
Non spetta a me dirlo, ma credo che
la Commissione abbia lavorato bene e ci siano le premesse per una relazione ampia e condivisa, che consenta al nostro Paese di cogliere un’occasione storica, forse l’ultima, di fare luce su una vicenda che ne ha così profondamente segnato la storia recente. Allo stesso tempo, però, riconosco
che c’è ancora molto lavoro da fare, e da completare in fretta, per giungere a una completa rilettura dei molteplici aspetti della vicenda, alla luce dell’imponente documentazione raccolta.
Siete ripartiti dalle indagini avviate dalla Commissione stragi guidata dal Senatore Giovanni Pellegrino tra il 1996 e il 2000. Quali aspetti meritavano ancora di essere approfonditi?
In realtà, la Commissione ha tenuto
presente non solo i lavori della Commissione stragi, ma anche quelli della prima Commissione Moro, creata nell’ottava legislatura, che accumulò una straordinaria quantità di documenti, e, per alcuni
aspetti, anche di altre Commissioni di inchiesta. Gli aspetti da approfondire sono tuttavia numerosi.
Le precedenti Commissioni hanno potuto
lavorare molto sulle testimonianze,
ma non hanno avuto a disposizione in maniera piena documentazione che è stata via via desecretata con le direttive Prodi (2008) e Renzi (2014). Inoltre, l’evoluzione
tecnologica consente oggi di compiere esami, anche di tipo balistico, e analisi che precedentemente erano impossibili.
Ciò consente di affrontare molti aspetti rimasti in ombra. Tra i principali ricordo:
la ricostruzione puntuale della scena del crimine di via Fani; Il numero e l’identità dei killer presenti la mattina del 16 marzo 1978; gli allarmi lanciati su un evento terroristico che avrebbe coinvolto l’Italia e la consapevolezza che ne ebbero
il Governo italiano e lo stesso Moro; i rapporti tra brigatisti e criminalità organizzata, in particolare la ‘ndrangheta; I luoghi dove venne tenuto prigioniero Moro durante i 55 giorni del sequestro; il rapporto tra la vicenda Moro e la politica
mediorientale dell’Italia; le vicende
della drammatica giornata del 18 aprile 1978, quando fu scoperto il covo di via Gradoli e comparve il falso comunicato del lago della Duchessa; gli ultimi giorni del sequestro, con l’improvviso fallimento di una trattativa che sembrava a buon punto e il misterioso trasporto di Moro al
centro di Roma.
Ma si potrebbero aggiungere molti altri aspetti meno noti. Penso ad esempio ad un tema sul quale la Commissione ha molto lavorato ultimamente, quello delle fonti di polizia in vario modo “infiltrate”
nelle brigate rosse o che diedero notizie su di esse. O ancora ai traffici di armi che in quel periodo attraversavano l’Italia, forse con la consapevolezza di apparati dello
Stato.
E quali le principali difficoltà incontrate nell’incarico?
Le difficoltà sono state numerose. Anche se la Commissione ha lavorato con impegno
e costanza, essa può disporre di mezzi molto limitati, specie se paragonati con quelli di precedenti inchieste parlamentari.
Ciò ha obbligato i parlamentari e i
collaboratori, che non sono retribuiti e continuano a svolgere le loro attività professionali, in particolare nelle Forze dell’Ordine
e nella Magistratura, a compiere un
grande sforzo. In questo ambito mi piace ricordare l’impegno dei Marescialli della Guardia di Finanza addetti all’archivio della Commissione, che gestiscono con
grande perizia una massa imponente di documentazione digitalizzata.
A livello politico e culturale, la Commissione comprende sensibilità diverse, che hanno portato a un confronto molto
aperto. Tuttavia, l’approvazione all’unanimità della relazione sul primo anno di lavoro e la proroga dei lavori fino alla fine della legislatura dimostrano che stiamo
facendo un lavoro utile su una vicenda estremamente complessa.
Infine, devo dire che, nonostante la
grande collaborazione delle diverse Istituzioni a cui ci siamo rivolti, dai Ministeri, ai Servizi, alla Magistratura, permane spesso una difficoltà a far emergere dall’ombra carte e documenti che sono
stati oggetto per anni di una tutela gelosa all’interno delle Amministrazioni di provenienza
e delle quali talora non è facile
accertare l’esistenza o i luoghi di conservazione.
All’atto della Sua nomina disse: “Si cambia solo se si chiudono i conti con il passato. Ci sono le condizioni per scrivere la verità”. Dopo due anni di indagini, audizioni e l’acquisizione di centinaia di documenti non più coperti da segreto, è possibile parlare di una verità su quel tragico evento?
È indubbio che oggi, in tutti i gruppi
parlamentari, c’è la consapevolezza della grande occasione che abbiamo davanti.
E, d’altra parte, molti elementi di blocco legati alle culture politiche degli anni ’70 sono progressivamente venuti meno, anche se si riscontrano ancora forti reticenze, e non solo tra gli ex brigatisti o i brigatisti ancora latitanti.
Confido che riusciremo a raggiungere la verità. Sul termine “verità” voglio però fare alcune precisazioni. L’interpretazione complessiva della vicenda Moro all’interno della crisi degli anni ’70 potrà essere sicuramente approfondita nel dibattito
culturale e storiografico. Del resto, è una vicenda che ha segnato la storia del nostro Paese condizionandone a lungo lo sviluppo ed è bene che ci si continui a interrogare su questo tema.
La Commissione ha un mandato più delimitato ma non meno importante, come precisato nella legge istitutiva: accertare
eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni Parlamentari
d’inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull’assassinio di Aldo Moro e accertare eventuali responsabilità riconducibili
ad apparati, strutture e organizzazioni.
Dentro questo perimetro, c’è la possibilità di acquisire una “verità” che finora è mancata. Già ora possiamo dire che sono
state spazzate via molte “mezze verità” date per acquisite, come quelle contenute nel cosiddetto “memoriale Morucci”. Si
tratta ora di comporre gli elementi che vanno emergendo dentro un’analisi complessiva, che è stata già abbozzata nella prima relazione sull’attività svolta.
Nelle nostre scuole insegnare la storia degli anni ’70 è complicato. Non pensa, al contrario, che le giovani generazioni potrebbero trarre vantaggio dallo studio di quel periodo per quanto disseminato di ombre e di misteri irrisolti?
È questo un tema che ho molto caro. Presentando il lavoro della Commissione, mi sono sempre più reso conto della difficoltà
di comunicarlo alle generazioni più
giovani, alle quali manca spesso una reale conoscenza degli elementi fattuali della
vicenda. Ciò non deriva solo dai tanti anni trascorsi, ma anche da un certo appiattimento sulla quotidianità che, purtroppo, i mezzi di comunicazione e i social
network tendono a produrre. Recuperare la memoria della vicenda Moro e degli
anni ’70 è però fondamentale, se si vuole capire la storia dell’Italia recente, con le sue luci e le sue molte ombre, e se si vuole acquisire una prospettiva consapevole su
problemi dell’oggi, come quello del terrorismo internazionale. Solo per fare un esempio, non credo sia inutile oggi ricordare la sanguinosa strage dell’aeroporto di Fiumicino del 17 dicembre 1973, che
gettò una lunga ombra sugli anni successivi e sulla stessa vicenda del rapimento Moro. Consapevole della necessità di lavorare
sul tema della consapevolezza
delle giovani generazioni, la Commissione ha avviato, insieme al Ministero dell’Istruzione, un programma destinato alle scuole secondarie, che ha il suo punto
qualificante in approfondimenti, svolti da me e dagli altri parlamentari membri della Commissione, presso istituti scolastici di ciascuna Regione italiana.