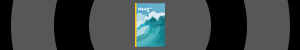Economia
Difesa al 2% (o oltre): il paradosso economico della spesa militare italiana
Rispettare i patti internazionali di sicurezza rischia di drenare risorse vitali da settori ad alto moltiplicatore

Difesa al 2% (o oltre): Il Paradosso Economico della Spesa Militare Italiana
Mentre il dibattito politico si infiamma sulla necessità di adeguare la spesa militare italiana ai parametri richiesti dalla NATO — con l'obiettivo del 2% del PIL da raggiungere entro il prossimo decennio — emerge una questione economica di fondo spesso ignorata: quale sarà il reale impatto sul nostro sistema produttivo? Se le regole classiche dell’economia vedono nella spesa pubblica un volano per la crescita, nel caso degli armamenti il rischio è quello di un "investimento a fondo perduto" per il PIL nazionale.
L’obiettivo 2% e la realtà del mercato
L’impegno di portare la spesa per la difesa a circa 40 miliardi di euro l'anno (rispetto ai circa 28-30 attuali) rappresenta uno sforzo fiscale imponente. Tuttavia, la natura stessa di questo investimento solleva dubbi sulla sua efficacia come stimolo macroeconomico. Se l'Italia decidesse di procedere massicciamente all'acquisto di mezzi di ultima generazione — aerei da caccia, sistemi missilistici, automezzi blindati e tecnologie radar — la maggior parte di questi ordini finirebbe inevitabilmente fuori dai confini nazionali.
Il nodo delle importazioni: ricchezza che esce
L’analisi economica è impietosa: quando uno Stato acquista beni prodotti all’estero, si verifica un fenomeno di "importazione netta". Nel caso di velivoli come gli F-35 statunitensi o di sistemi d'arma di produzione estera, i capitali italiani fluiscono direttamente verso le casse di aziende straniere.
A differenza di un investimento in infrastrutture civili (ponti, ferrovie, digitalizzazione) o in incentivi per l'industria manifatturiera locale, l’acquisto di armamenti stranieri non genera:
1. Nessun aumento della produttività interna: Le aziende italiane non vengono coinvolte nel processo creativo o produttivo, restando escluse dal know-how tecnologico.
2. Zero impatto sull'occupazione: Non si creano nuovi posti di lavoro nelle fabbriche italiane, poiché la produzione avviene negli stabilimenti dei fornitori internazionali.
3. Assenza di gettito fiscale aggiuntivo: Se un'azienda italiana non produce e non vende, non versa tasse (IRES, IRAP) né contributi sui lavoratori allo Stato italiano. Il moltiplicatore economico, in questo caso, è vicino allo zero.
Un investimento senza ritorno diretto
Secondo le normali regole economiche, la spesa pubblica dovrebbe generare un "effetto moltiplicatore": ogni euro speso dovrebbe generare più di un euro di PIL attraverso il consumo e l'investimento derivato. Ma quando la spesa si traduce in un mero trasferimento di valuta verso l'estero per l'acquisto di beni "finiti" (e spesso con manutenzioni costose anch'esse delegate ai fornitori), l'operazione si trasforma in una passività pura.
L’Italia si trova quindi di fronte a un paradosso: rispettare i patti internazionali di sicurezza rischia di drenare risorse vitali da settori ad alto moltiplicatore (come la scuola, la sanità o la transizione energetica) per alimentare l’industria di altri Paesi.
In conclusione se la spesa militare non verrà accompagnata da una strategia di "offset" (compensazioni industriali) che obblighi i fornitori stranieri a produrre o investire in Italia, o da un rilancio della nostra industria della difesa nazionale (Leonardo, Fincantieri), l'aumento del budget militare sarà vissuto dai conti pubblici come un puro costo. Un investimento che, pur rispondendo a logiche di geopolitica e sicurezza, dal punto di vista economico non genera alcun vantaggio diretto per i cittadini e per le imprese del territorio.