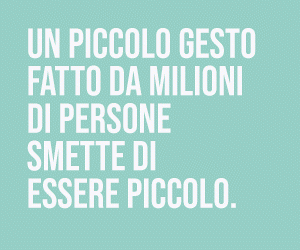Economia
Panetta: “La fiducia è la vera moneta d’Europa. Da Firenze all’euro digitale, un filo lungo otto secoli”
L'intervento del governatore della Banca d'Italia davanti al Consiglio direttivo della Bce

Fabio Panetta
Panetta: “La fiducia è la vera moneta d’Europa"
Il palazzo che oggi ci accoglie – Palazzo Vecchio – è un simbolo straordinario della storia e della continuità delle istituzioni. Attualmente sede del Comune di Firenze, tra il 1865 e il 1871 ospitò il Parlamento nazionale, quando la città fu capitale del giovane Regno d’Italia.
Le sue radici affondano però molto più indietro nel tempo: fu costruito oltre sette secoli fa per accogliere la Signoria della Repubblica fiorentina, l’organo di governo cittadino che riuniva i rappresentanti delle Corporazioni delle arti e dei mestieri, un vero e proprio Consiglio direttivo dell’epoca, espressione di una città autonoma, prospera e vitale.
In quei secoli Firenze conobbe uno sviluppo eccezionale, affermandosi come capitale economica, culturale e finanziaria d’Europa. Un’esperienza lontana nel tempo, ma ancora capace di ispirarci nell’affrontare le sfide del presente.
Il fiorino: stabilità e prestigio internazionale di una moneta
Firenze divenne la maggiore piazza finanziaria internazionale anche grazie alla creazione, nel 1252, della sua moneta: il fiorino. Fu la prima moneta d’oro sovrana coniata in Occidente dopo la caduta dell’Impero romano2. Il suo successo si fondò sulla stabilità: per tre secoli peso e composizione rimasero invariati: 3,53 grammi di oro puro a 24 carati. Tale stabilità testimonia che la Signoria seppe resistere alla tentazione di finanziare le proprie spese con l’inflazione. Questa disciplina contribuì alla fortuna di Firenze e della sua moneta.
Il fiorino conquistò fiducia universale – condizione indispensabile per ogni moneta stabile – e divenne il mezzo di pagamento per eccellenza negli scambi europei, assicurando a Firenze oltre due secoli di supremazia economica. Col tempo, divenne il simbolo della forza, della credibilità e dell’autorità della città, contribuendo a definirne l’identità.
A sua volta, la prosperità di Firenze rafforzò il ruolo internazionale del fiorino: un circolo virtuoso tra economia e finanza che ritroviamo in ogni valuta internazionale – dall’aureo di Cesare alla lira di Carlo Magno, dalla sterlina al dollaro.
Oggi l’euro è per l’Europa ciò che il fiorino fu per Firenze: un simbolo di stabilità, che accompagna lo sviluppo economico e trae da esso nuova forza. Ma è anche qualcosa di più: un simbolo di unità, che sostiene la coesione politica tra gli Stati membri.
L’Unione europea è nata, infatti, per rendere la guerra «non solo impensabile, ma materialmente impossibile», cementando gli interessi e la visione di popoli che per secoli si erano combattuti. Da questo punto di vista, l’integrazione europea è stata un successo senza precedenti, che ci ha garantito ottant’anni di pace.
Ma in un mondo in rapida trasformazione – segnato da tensioni geopolitiche e da accelerazioni tecnologiche – per continuare a raccogliere i frutti di questo successo l’Europa deve consolidare e rafforzare il proprio ruolo, completando l’unione economica e finanziaria e realizzando con decisione e tempestività le riforme necessarie a sostenere la crescita.
La prosperità di Firenze rese possibile una fioritura culturale senza pari. Le ricchezze dei mercanti-banchieri, a partire dai Medici, alimentarono un mecenatismo illuminato che generò un patrimonio ineguagliabile di architettura e di arte. Ne scaturì una stagione creativa straordinaria, animata da figure illustri come Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Leonardo, Michelangelo e molti altri.
Il Rinascimento fiorentino, cuore di quello italiano, trasformò la ricchezza materiale in un’eredità artistica e culturale che resta tra i doni più grandiosi che l’Italia abbia offerto all’Europa e al mondo.
Firenze come laboratorio di innovazione finanziaria
Le fortune finanziarie di Firenze non si fondarono soltanto sulla stabilità del fiorino, ma anche sulla straordinaria capacità di innovare, creando istituzioni e strumenti destinati a plasmare la finanza nei secoli successivi.
I mercanti-banchieri fiorentini nacquero come compagnie familiari. Con il commercio e le manifatture accumularono ricchezze, affinarono competenze contabili, acquisirono dimestichezza con le diverse monete e costruirono solide reti di relazioni internazionali.
All’inizio operarono con capitali propri. Ben presto, tuttavia, iniziarono a raccogliere fondi fuori corpo – cioè al di fuori del patrimonio familiare – sotto forma di depositi. Con essi finanziavano mercanti e sovrani, aprendo filiali nei principali centri economici d’Europa, affermandosi così come precursori della banca moderna.
Un’altra innovazione decisiva fu lo sviluppo delle lettere di cambio. Tali strumenti nacquero nelle fiere internazionali per regolare le transazioni evitando i rischi del trasporto di oro e argento e divennero rapidamente un mezzo di pagamento sicuro e, al tempo stesso, una forma di credito. I banchieri fiorentini ne furono i principali artefici e diffusero un modello destinato a trasformare in profondità gli scambi commerciali e finanziari internazionali.
Innovazione finanziaria e istituzionale nell’Italia premoderna
Nell’Italia premoderna l’innovazione finanziaria non si limitò a Firenze. Dal XII secolo anche Venezia, Genova e Napoli sperimentarono strumenti come i depositi, il credito e le lettere di cambio, riducendo progressivamente l’uso della moneta metallica. Questo sviluppo richiese istituzioni pubbliche capaci di garantire fiducia e stabilità.
L’Italia divenne così una fucina di innovazioni che, nel tempo e con il contributo di altri popoli, aprì la strada ai moderni sistemi finanziari e, infine, alle banche centrali. Vorrei ricordare alcuni esempi significativi.
A Venezia, già alla fine del Duecento, lo Stato introdusse il giro, un sistema di regolamento dei pagamenti mediante trasferimenti da un deposito all’altro, senza impiego di moneta. I suoi depositi divennero un mezzo di pagamento diffuso, utilizzato per transazioni di ogni dimensione. Nel Cinquecento nacque il Banco di Rialto, che nel tempo divenne una banca pubblica: i suoi depositi furono dichiarati moneta legale e resi obbligatori per le operazioni rilevanti.
I banchieri genovesi svilupparono un sistema di fiere dedicate al regolamento delle lettere di cambio, una forma di compensazione dei pagamenti ante litteram, assistita da operatori con funzioni paragonabili a quelle delle moderne controparti centrali. Il Banco di San Giorgio, fondato già nel 1407, divenne la più importante banca pubblica di deposito d’Europa: raccoglieva depositi, trasferiva denaro, offriva servizi di compensazione e concedeva scoperti di conto corrente. I suoi depositi acquisirono lo status di moneta legale; le quote societarie che emetteva (denominate luoghi) erano negoziate in un primitivo mercato dei capitali, antesignano delle borse moderne.
Le banche semipubbliche di Venezia e Genova furono un modello per istituzioni simili sorte successivamente ad Amsterdam e Amburgo. Rafforzarono la solidità del sistema dei pagamenti, diffondendo su larga scala la tecnologia del giro, basata sull’utilizzo esteso della moneta scritturale con valore liberatorio.
A Napoli, nel Seicento, i banchi pubblici introdussero le fedi di credito: certificati di deposito trasferibili e pagabili a vista, fondati sulla fiducia nell’emittente, che circolavano come mezzi di pagamento quotidiano. Questi strumenti sono stati spesso assimilati alle banconote convertibili in metalli preziosi emesse dalle prime istituzioni poi divenute banche di emissione e, in seguito, banche centrali.
La storia dei banchi pubblici e dei giro segnò l’avvio del percorso che avrebbe condotto, secoli più tardi, alla nascita delle banche centrali: istituzioni pubbliche responsabili dell’emissione di banconote, incaricate di garantire la stabilità dei pagamenti e, in ultima analisi, di custodire la fiducia collettiva nella moneta.
Nei secoli successivi, l’Italia non seppe valorizzare il suo splendore rinascimentale. Rimase politicamente ed economicamente frammentata, appesantita da norme inadeguate e da corporazioni che soffocavano l’innovazione. La lezione per l’Europa di oggi è chiara: per preservare il proprio peso economico e contare nel mondo, deve superare le rigidità istituzionali, investire in innovazione e completare il mercato unico.
Uno sguardo al futuro
Oggi viviamo una fase di innovazione finanziaria non meno profonda di quella che vide protagoniste le città italiane secoli fa, ma assai più rapida e di portata globale. La rivoluzione digitale mette in discussione la stessa idea di moneta, oramai lontana dalle sue forme storiche – dall’oro alle fedi di credito, fino alle banconote.
È un processo naturale, ma che richiede comprensione e vigilanza. Alcune innovazioni digitali rischiano paradossalmente di rappresentare un arretramento: la proliferazione di pseudo-monete digitali private, sottratte alla supervisione, può generare instabilità, trasferire il signoraggio a pochi attori e favorire attività illecite.
Il ruolo delle banche centrali è cruciale: devono assicurare che la tecnologia ci spinga in avanti – verso un sistema monetario più integrato ed efficiente – e non indietro, verso un ordine frammentato e fragile. Perché ciò accada, esse devono assumere un ruolo attivo nell’evoluzione tecnologica della finanza e dei pagamenti.
In questa direzione si muove l’impegno della Banca centrale europea, della Banca d’Italia e delle altre banche centrali nazionali: garantire che, anche nell’era digitale, i cittadini possano contare su servizi finanziari affidabili, fondati su una moneta pubblica, nei pagamenti tanto al dettaglio quanto all’ingrosso. È questo l’obiettivo che guida i progetti sull’euro digitale e sull’integrazione del sistema TARGET per i pagamenti all’ingrosso con la tecnologia a registri distribuiti (distributed ledger technology, DLT).
Conclusioni
Dal fiorino d’oro di Firenze alla moneta unica europea, fino alle sfide della finanza digitale, il cammino della moneta ha attraversato secoli di innovazioni tecniche, istituzionali e culturali. Dopo l’abbandono dell’oro come ancoraggio, la moneta fiduciaria è divenuta il fondamento dei sistemi economici moderni. Ma proprio perché basata sulla fiducia, essa richiede istituzioni solide, credibili e soprattutto indipendenti: le banche centrali.
Oggi, in Europa, il compito di custodire questa tradizione e proiettarla nel futuro spetta all’Eurosistema. In un mondo attraversato da rivoluzioni tecnologiche, tensioni geopolitiche e nuove incertezze, la BCE e le banche centrali nazionali sono chiamate a garantire stabilità e sovranità monetaria, preservando la fiducia collettiva.
Nell’epoca delle grandi trasformazioni, la moneta pubblica resta un bene pubblico, un presidio della democrazia economica, un simbolo della fiducia condivisa. È stata definita «il sistema di mutua fiducia più universale e più efficiente che sia mai stato concepito».
La moneta pubblica non è soltanto uno strumento economico: è il patto di fiducia che contribuisce a tenere unita ogni comunità. Da Firenze, origine di tante innovazioni monetarie e istituzionali, rinnoviamo l’impegno dell’Eurosistema a custodire, rafforzare e tramandare questa fiducia, affinché ogni generazione la riceva intatta e la trasformi in risposta alle sfide del proprio tempo.