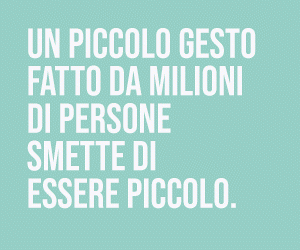Economia
Sergio Marchionne, 7 anni fa l'addio al manager che ha rivoluzionato la Fiat
Un outsider con una visione pragmatica che ha salvato un gigante in crisi, trasformandolo in un colosso globale

Dieci anni senza Marchionne
Sergio Marchionne è morto il 25 luglio 2018. Sono passati sette anni, e ancora nessuno, dentro o fuori dal Lingotto, è riuscito a prenderne davvero il posto. Non solo per la poltrona, ma per il peso. Perché Marchionne non è stato un amministratore delegato come tanti: è stato l’uomo che ha salvato la Fiat da un destino che sembrava segnato e l’ha portata in giro per il mondo a testa alta, sfidando sindacati, governi e pure qualche legge della logica industriale. L’ha fatto a modo suo, senza cravatta e senza mai girare attorno alle parole.
Quando arriva al vertice del gruppo, nel 2004, Fiat è una barca che imbarca acqua da ogni parte. Le fabbriche italiane sono impantanate, la famiglia Agnelli è in ritirata, il titolo in Borsa è zavorrato da debiti e sfiducia. Lui è un outsider: canadese d’adozione, torinese di nascita, lauree in filosofia, economia e legge, passato per la finanza internazionale e poi per la SGS svizzera, che aveva già salvato. Lo mettono al comando ma in pochi ci credono.
Rivolta tutto. Accorpa piattaforme, riduce la burocrazia, riorganizza i vertici e si mette a studiare ogni singolo dossier. Dorme poco, fuma troppo, non si concede mai un vestito elegante. Ma i conti tornano: già nel 2005 Fiat torna in utile. E nel 2007, quando presenta la nuova 500 a Torino, lo fa da protagonista, con un sorriso a metà tra la soddisfazione e la sfida. Poi arriva il 2008, e con lui la crisi globale. In quel momento Marchionne fa la mossa più audace della sua carriera: va negli Stati Uniti, mentre Chrysler è in ginocchio, e convince Obama, i sindacati e il Tesoro americano che Fiat può salvarla. Nessuno ci avrebbe scommesso un dollaro bucato. Ma lui ci riesce, pezzo dopo pezzo, fino a fondere Fiat e Chrysler in un unico gruppo globale, FCA. E a riportare Jeep al centro del gioco, trasformandola nel marchio che farà volare i profitti.
La visione è chiara: snellire, integrare, produrre dove conviene, e vendere dove si fa margine. Marchionne non è un romantico dell’industria, è un pragmatico. Quando chiude Termini Imerese o spinge per cambiare i contratti collettivi a Pomigliano, i sindacati lo accusano di cinismo, lui risponde parlando di numeri e competitività. Per molti è brutale, ma è coerente. Crede in un’industria che regge solo se fa profitti.
Non tutto però funziona alla perfezione. I lanci di prodotto spesso slittano, l’elettrico resta ai margini fino alla fine, l’innovazione è più finanziaria che tecnologica. “Non mi interessa vendere auto in perdita solo per dire che facciamo l’elettrico”, ripeteva. Ma il mondo andava in un’altra direzione, e su questo fronte è stato costretto a rincorrere. A compensare c’è la strategia finanziaria: separa CNH, porta Ferrari in Borsa (facendola valutare più di FCA), taglia il debito fino a portarlo a zero. Rende la galassia Fiat un asset moderno, appetibile, solido. Un colosso da 100 miliardi di fatturato. E lo fa senza dimenticare di restituire potere e centralità a Exor, la cassaforte di casa Agnelli, che con lui torna protagonista.
Poi, all’improvviso, l’estate del 2018. Un’operazione alla spalla, complicazioni inattese, il coma, la morte. Il gruppo resta spiazzato. La successione è frettolosa, le redini passano a Mike Manley e poi, nel giro di due anni, a Carlos Tavares dopo la fusione con PSA. La Fiat come la conoscevamo non c’è più. Eppure, dieci anni dopo, il fantasma di Marchionne è ancora lì. Ogni volta che si parla di Jeep, di Ferrari, di sindacati, di fabbriche da difendere, spunta il suo nome.
Ogni volta che Stellantis annuncia nuovi piani industriali, si cerca l’eco delle sue scelte. Antonio Filosa, l’attuale CEO, lo ha appena citato in un post su LinkedIn: “La mediocrità non vale il viaggio”. Una frase che Marchionne ripeteva spesso. Insomma ha lasciato un gruppo che poteva camminare sulle proprie gambe. E un’industria che, nel bene e nel male, ha dovuto imparare a pensare come lui.