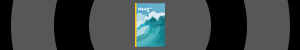Esteri
Stati Uniti in declino. Tutta la verità. L'analisi

Di Paolo Sensini
Si dice che viviamo in un "eterno presente", ma a volte il tempo prende delle accelerazioni imprevedibili. È il caso di ciò sta accadendo in questi giorni nel Vicino Oriente, che presto avrà effetti piuttosto consistenti anche alle nostre latitudini.
Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e del suo Commonwealth nel biennio 1989-1991, gli Stati Uniti hanno ritenuto di essere gli unici depositari dei destini del mondo. Si sono quindi sentiti investiti dell'autorità di procedere a loro insindacabile giudizio su tutti gli scenari internazionali. Tanto da frazionare l'intero mondo in 6 "Comandi" (USNORTHCOM, USSOUTHCOM, USEUCOM, USCENTCOM, USAFRICOM, USPACOM), come solo una potenza che si percepisce come un Impero può stimare legittimo e opportuno fare. Hanno iniziato con la Jugoslavia nel 1999, dove il peso della loro forza militare si è abbattuto contro la piccola Serbia. Era la prima guerra combattuta sul suolo europeo dopo la Seconda Guerra mondiale, frutto di uno stallo dovuto alla spartizione continentale sortita da Jalta. Ma anche in questo caso gli Stati Uniti hanno ottenuto i loro "effetti di ritorno", poiché nella nuova enclave kosovara ritagliata dai bombardamenti hanno costruito la più grande base militare dei Balcani, Camp Bondsteel.
L'Italia era allora governata da un esecutivo guidato dal primo "ex-"comunista della storia repubblicana, quel "Baffino" D'Alema che si sarebbe barcamenato al potere giusto il tempo per dare una copertura istituzionale a un'operazione bellica americana del tutto fraudolenta. Ma la vera e propria escalation di violenza militare doveva ancora arrivare. Il punto di svolta è stato l'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono dell'11 settembre 2001, uno shock generale che le élite anglo-sioniste hanno utilizzato per muovere guerra dovunque essi volevano.
Da quel momento non c'è stato più limite all'interventismo militare statunitense e, in rapida sequenza, si sono avvicendate le campagne in Afghanistan, Iraq, Somalia, Etiopia, Sudan, Libia, Mali, Siria, Yemen, Ucraina. È stato posto fine, per dirla con altre parole, a un ordine politico-giuridico internazionale che, bene o male, aveva retto le convenzioni internazionali dalla Pace di Westfalia del 1648. Parliamo di un vero e proprio "terremoto" del concetto di "sovranità nazionale" perché quelle operazioni belliche non avevano alcun tipo di legittimità sul piano del diritto internazionale e nemmeno erano giustificate da ragioni di sicurezza o autorizzate dall'ONU. Si trattava semplicemente "forza che si fa legge". Punto.
Molti, soprattutto nelle provincie oltreoceano, hanno ritenuto a torto che tutta questa ostentazione muscolar-militare fosse un segno di grande salute e vigore degli Stati Uniti. E dunque che, da bravi servi, bisognasse solo ubbidire e assecondare docilmente questo modus operandi. Ma la situazione in realtà non stava affatto in questi termini, e tutto ciò era prodromico di una manifesta debolezza. La Storia, in realtà, è andata sempre allo stesso modo fin dai tempi dell'Impero romano: più si allargava il limes per cercare un respiro che incominciava a mancare all'intero dei propri confini, più si ponevano le basi di un incipiente declino. Nessuno è sfuggito a questa "regola aurea", anche se i corifei inebriati da un tale delirio di onnipotenza pensavano di rappresentare una felice eccezione.
Naturalmente tutto questo ha avuto un contraltare pubblico anche sul piano dei rappresentanti che si sono via via avvicendati sulla scena politico-militare americana, ossia i protagonisti che hanno dato un volto mediatico alla deriva militarista dell'ultimo ventennio. Finita dunque l'èra della grande diplomazia che, volente o nolente, aveva caratterizzato tutto il periodo della Guerra fredda, da quel momento abbiamo visto susseguirsi personaggi arroganti e incapaci di qualsiasi mediazione diplomatica, buoni solo a minacciare e impartire diktat a chiunque osasse frapporsi alla loro marcia vittoriosa. In altre parole incarnavano lo "spirito del tempo", stimando che ogni contenzioso internazionale potesse essere risolto con l'uso della forza bruta. Non a caso le coordinate teoriche di questi condottieri da tavolino, i cosiddetti "neocons", si rifanno a due maestri apparentemente inconciliabili ma in realtà convergenti su molti aspetti: Leo Strauss e Trockij.
Digiuni di qualsiasi nozione concreta in campo storico, diplomatico o socioeconomico sui "tempi lunghi" degli imperi, essi ritenevano e ritengono tuttora dell'avviso che solo l'ostentazione della forza e il machiavellismo esercitato su vasta scala possono fare ottenere tutto ciò che si desidera. E che, soprattutto, quello stato di cose si sarebbe protratto per sempre. Ma si sbagliavano di grosso. In primo luogo perché anche una potenza come gli Stati Uniti non poteva permettersi di imbastire guerre e occupazioni militari senza pagare prima o poi dazio. Alludiamo ai costi stratosferici stimati in decine di trilioni di dollari, e anche disponendo della Federal Reserve per stampare carta moneta o pixel a piacimento prima o poi si raggiunge un limite non più sostenibile. Ma questo i burocrati appollaiati sulla tolda di comando della portaerei a stelle e strisce non l'avevano messo in conto. In secondo luogo perché non siamo giunti alla "fine della Storia", come qualche imbonitore di regime aveva con troppa faciloneria teorizzato, ma ci troviamo dentro al suo flusso inarrestabile.
Per descrivere il clima di cui stiamo parlando non ci sono parole più eloquenti di quelle utilizzate da Karl Rove, già capo dello staff presidenziale di George W. Bush e stratega del partito Repubblicano, che ha descritto quel milieu in cui egli stesso ha vissuto per molti anni nei seguenti termini: "Ora noi siamo un Impero e quando agiamo creiamo la nostra realtà. E mentre voi state giudiziosamente analizzando quella realtà, noi agiremo di nuovo e ne creeremo un'altra e poi un'altra ancora che potrete studiare. È così che andranno le cose. Noi facciamo la storia e a voi, a tutti voi, non resterà altro da fare che studiare ciò che facciamo".
Ecco che però, giunti a cozzare contro il "muro dei fatti" descritto più sopra, gli strateghi da tavolino sio-americani hanno pensato che la scappatoia per proseguire il "Grande Gioco" fosse quella d'innescare delle proxy wars, ossia delle guerre per procura fatte da altri. Si credeva così di evitare i costi esorbitanti e lo sfibramento delle proprie forze armate ritenendo - erroneamente - di poter far rientrare dalla finestra ciò che si era dovuto, per forza di cose, far uscire dalla porta.
Lo si è visto in maniera chiara con le ultime guerre in Libia e Siria, segnatamente in quest'ultima, dove però le cose sono andate decisamente peggio di quanto gli Stranamore del Pentagono avevano vaticinato. Un disastro che non ha conseguito alcun risultato effettivo e che ha ulteriormente eroso il già residuo deficit di credibilità degli Stati Uniti e dei loro cavalier serventi a livello internazionale.
Diversi elementi hanno concorso alla determinazione del nuov status quo. Innanzitutto l'incapacità dei mercenari islamisti dislocati nel Levante di ottenere alcun risultato tangibile, ma soprattutto l'entrata in scena della Russia - su richiesta del legittimo governo siriano - che ha posto fine alle scorribande dei mercenari jihadisti. Il mondo ha così preso atto che in un anno d'intervento la coalizione capeggiata dagli Stati Uniti non aveva centrato alcun obiettivo. Anzi, giorno dopo giorno si è assistito a un continuo avanzamento delle posizioni dei combattenti takfiri che sono riusciti addirittura a proclamare il Califfato. Insomma si è assistito in diretta televisiva che, come si suol dire, "il Re è nudo".
Intervenuti sul finire di settembre, l'aviazione russa ha distrutto in Siria dopo solo un mese più di 1.600 obiettivi dell'ISIS in quasi 1.400 missioni, come ha reso noto due giorni fa il generale dello Stato Maggiore russo Andrej Kartapolov.
Per quanto riguarda le varie parti coinvolte nel conflitto siriano, i curdi si sono resi disponibili a collaborare con la Russia e Assad, mentre la Giordania ha dichiarato che "coordinerà azioni militari con i russi e che un centro di comando speciale sarà approntato per tale scopo ad Amman". L'Iraq ha esplicitamente chiesto a Putin di iniziare operazioni di bombardamento dell'ISIS sul proprio territorio per sradicare la presenza dei jihadisti. E anche l'Egitto ha fatto sapere che è disposto a unirsi alla coalizione guidata da Russia, Siria, Iran, Iraq ed Hezbollah. Israele, massimo fattore d'instabilità nell'area mediorientale e da sempre magna pars in tutte le imprese militari statunitense, pur non dichiarandosi a fianco dei russi ha fatto trapelare che quantomeno non gli lavorerà contro. I risultati, al momento, sembrano dunque essere questi: indipendentemente dalla sincerità dei soggetti in campo, tutti i maggiori player della regione hanno compiuto uno sforzo significativo per non sembrare almeno contro l'operazione dei russi. Il che, rebus sic stantibus, è un grande risultato ottenuto dalla diplomazia di Putin.
A tutto ciò bisogna aggiungere, come ciliegina sulla torta, la visita di Bashar al-Assad a Mosca nell'ultima settimana di settembre dove è stato ricevuto con tutti gli onori dalle massime autorità politiche, militari e dei servizi di sicurezza del Paese. Una visita che suggella ancora una volta l'impotenza degli Stati Uniti. I messaggi che vengono fuori da questo summit sono almeno tre: 1) la volontà di schiacciare i terroristi presenti in Siria e Iraq è la strada su cui tutti gli interlocutori sono decisi a proseguire la loro azione; 2) la sorte politica ed esistenziale di Assad, soprattutto dopo quello che è avvenuto in Libia, può essere decisa solo dal suo popolo e non da ingerenze straniere; 3) la Siria e il Levante non devono cadere sotto la sfera d'influenza degli Stati Uniti e dei loro vassalli del Golfo.
Gli americani hanno quindi dovuto prendere atto della mutata situazione e adeguati al "nuovo corso" inaugurato nelle relazioni internazionali. L'auspicio è dunque che stia per finire il tempo in cui un ristretto "Direttorio" si arroghi il diritto di decidere chi è autorizzato o no a governare un determinato Paese.
Nei giorni scorsi si è aperto a tale proposito l'incontro di Vienna (30 ottobre) sul futuro della Siria, che ha visto la partecipazione di 17 delegazioni. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha ribadito che solo al popolo siriano deve essere permesso di decidere il futuro del presidente Bashar al-Assad: "Il futuro di Assad deve essere deciso dal popolo siriano", ha ribadito Ban in un'intervista con i giornalisti spagnoli. Il segretario dell'ONU ha aggiunto che i partecipanti ai colloqui sulla Siria avrebbero dovuto concentrarsi su questioni diverse da quella riguardante il futuro del presidente Assad: "È assolutamente ingiusto e irragionevole che il destino di una persona prenda l'intero processo politico di negoziazione in ostaggio. È inaccettabile". Secondo le dichiarazioni del "Wall Street Journal", che ha citato una fonte del governo statunitense, sembra che anche gli Stati Uniti abbiano cambiato la loro posizione sulla questione e che ora Washington desideri una risoluzione che preveda un cessate il fuoco in Siria "senza sollevare la questione della partenza di Assad". Sull'argomento è intervenuto anche il quotidiano francese "Le Figaro", che ha lanciato un sondaggio dal quale è emerso che quasi il 72% dei lettori è contrario alla richiesta di allontanamento di Bashar al-Assad dal potere da parte delle potenze occidentali.
Ma le divergenze sulla partenza del presidente siriano, soprattutto tra i governanti delle feudo-teocrazie del Golfo, rimangono immutate. Infatti, intervistato a margine dei lavori da "Sky News", il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir ha ribadito che Russia e Iran devono accettare di fissare un termine e le condizioni per la partenza del presidente siriano Bashar Assad oltre al ritiro di tutte le forze straniere dalla Siria: "I due temi su cui le nostre opinioni divergono sono in primo luogo - ha intimato al-Jubeir - la data e le modalità della partenza di Assad e, in secondo luogo, la data e le modalità del ritiro delle forze straniere, in particolare iraniane. Si tratta di due punti fondamentali senza i quali nessuna soluzione sarà possibile". E se lo dice un'autorità in fatto di "democrazia" e "rispetto dei diritti umani" come il rappresentante dell'Arabia Saudita, non ci resta che prenderne religiosamente atto e adeguarci ai voleri dei rappresentanti terreni di Allah.
È ciò che ha fatto subito il mellifluo ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni, secondo cui all'incontro di Vienna "non si sono superate le differenze e si è convenuto sul punto che la via non è militare ma di una transizione politica che per noi porti all'uscita di Assad, un processo che inevitabilmente andrà in quella direzione. Ma restano da decidere modalità e tempi". Una posizione, quella espressa da Gentiloni, che rivela una volta di più il livello di sudditanza e vassallaggio politico-economico che caratterizza i circoli governativi italiani.
Una novità rilevante è stata invece diffusa dall'agenzia iraniana "Irna", secondo la quale il prossimo incontro sulla Siria che si terrà in tempi brevi a Vienna vedrà anche la partecipazione di rappresentanti del governo siriano e dei gruppi dell'opposizione. Un fatto significativo che non mancherà certamente di avere effetti di rilievo.
La speranza insomma è che il caos mediorientale abbia almeno come conseguenza, dopo tante macerie e distruzioni, l'inizio di un'inversione di tendenza per gli Stati Uniti così com'è accaduto dopo il 1991 per il regime sovietico. Che diventi, in altre parole, un Paese "normale" come tutti gli altri. Nessuno può può arrogarsi di essere l'"unica potenza egemonica al mondo" e di poterlo rimanere per sempre. Ma c'è chi lo ha creduto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Adesso, tuttavia, il combinato disposto di crisi economica, perdita d'egemonia e credibilità internazionale sembrerebbero portare verso un ridimensionamento geopolitico degli Stati Uniti, ma se guardiamo alla rosa dei nomi in lizza per le presidenziali americane del 2016 un tale esito non sembra essere proprio dietro l'angolo. Non a caso dopo la momentanea débâcle in Siria, pare che in questi giorni consistenti gruppi di miliziani jihadisti stiano premendo verso il confine meridionale della Russia. Il che, visti i trascorsi, non promette nulla di buono. La strada per la distensione dell'agenda internazionale, che piaccia o meno, è comunque segnata, ma i colpi di coda della bestia ferita ci accompagneranno ancora a lungo.