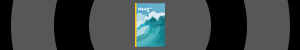Esteri
Etiopia nel mirino degli Usa: il Paese africano accusato di crimini di guerra e genocidio. Come cambiano i rapporti con Sudan ed Emirati
Sudan, Etiopia ed Emirati nella competizione per il Mar Rosso

Donald Trump e Mohammed Bin Salman

Al-Fashir, nella regione del Darfur, nel Sudan nordoccidentale, ospita oltre 1,8 milioni di residenti e sfollati, ed è l'ultimo fronte di una guerra tra l'esercito sudanese e le Forze paramilitari di supporto rapido, iniziata nell'aprile 2023. AFP/Getty Images
Usa ed Etiopia, la fine dell’immunità politica
Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche statunitensi, il 10 dicembre 2025 il Congresso degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione (H.Res. 937) che accusa il governo etiope di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio nelle regioni Amhara e Oromia, sollecitando l’applicazione di sanzioni individuali ai sensi del Global Magnitsky Act, che colpisce singoli responsabili e non gli Stati.
Si tratta di una risoluzione dal forte valore politico, che interviene nella complessità dei conflitti interni all’Etiopia e segna una svolta nel giudizio statunitense sul governo del premier Abiy Ahmed, dall’inizio del suo mandato nel 2018. Una risoluzione che, pur non riguardando direttamente il Sudan, risulta cruciale per comprendere il ruolo regionale dell’Etiopia nella guerra sudanese.
Washington, tuttavia, non sembra intenzionata a isolare Addis Abeba, un tempo alleato strategico degli Stati Uniti nel Corno d’Africa. La crescente vicinanza agli Emirati Arabi Uniti, l’aggravarsi dei conflitti interni e una posizione ambigua nella guerra scoppiata in Sudan nel 2023 rendono però l’Etiopia un partner sempre più problematico, da osservare con sospetto.
La guerra in Sudan e il ruolo delle RSF
Dietro le quinte dell’ingarbugliata crisi sudanese, caratterizzata da una molteplicità di attori locali e regionali, l’Etiopia gioca un ruolo tutt’altro che marginale. Il conflitto interno tra l’esercito regolare sudanese (Sudanese Armed Forces, SAF), fedele al generale Abdel Fattah al-Burhan, e le milizie paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) rappresenta una tragedia umanitaria di proporzioni enormi che in due anni ha causato circa 40 mila morti e lo sfollamento di oltre 12 milioni di persone.
La crisi ha raggiunto uno dei suoi momenti più drammatici il 26 ottobre scorso, con il sanguinoso assalto delle RSF a El Fasher, capoluogo del Darfur settentrionale.
Atrocità di massa, violazioni sistematiche dei diritti umani e genocidio sono le accuse mosse dalle organizzazioni umanitarie contro il leader delle RSF, il generale Mohamed Hamadan Dagalo. Le milizie paramilitari sarebbero sostenute sul piano militare, finanziario e logistico dagli Emirati Arabi Uniti. Un appoggio che Abu Dhabi nega ufficialmente, ma che emerge con chiarezza in numerosi rapporti delle Nazioni Unite e di organizzazioni non governative. Tali documenti ricostruiscono una rete articolata che coinvolge Puntland e Somaliland, il saccheggio dell’oro del Darfur, il sostegno etiopico, l’appoggio emiratino e l’ingaggio di mercenari stranieri, in particolare colombiani, a supporto delle RSF.
In questo contesto, fonti sudanesi hanno riferito all’emittente Al Jazeera che le autorità di Addis Abeba avrebbero aperto campi di addestramento militare nei quali operano mercenari stranieri, soprattutto colombiani. Dopo mesi di sostanziale silenzio internazionale sulla brutalità del conflitto, sembra ora profilarsi una svolta.
Gli Stati Uniti
Il 20 novembre il presidente statunitense Donald Trump, dopo un incontro alla Casa Bianca con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ha dichiarato che gli Stati Uniti si impegneranno per fermare la guerra in Sudan, dove stanno accadendo cose “orribili”.
Successivamente, in un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha ribadito l’intenzione di intervenire nella regione: “I leader arabi di tutto il mondo, in particolare dell’Arabia Saudita, mi hanno chiesto di usare il potere e l’influenza della presidenza per porre fine a ciò che sta accadendo in Sudan”. Il Presidente ha aggiunto che Washington collaborerà con “l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e altri partner mediorientali” per fermare le atrocità e stabilizzare il Paese.
Trump sembra dunque proporsi come mediatore tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, attori regionali schierati su fronti contrapposti nel conflitto sudanese. Da un lato, le RSF godono del sostegno degli Emirati e, indirettamente, dell’Etiopia, dall’altro l’esercito regolare SAF è appoggiato da Egitto e Arabia Saudita.
La posizione americana si chiarisce ulteriormente il 3 dicembre, quando il Dipartimento del Tesoro pubblica un comunicato su X annunciando sanzioni contro quattro individui e quattro entità per il loro ruolo nella guerra in Sudan. Il post fa riferimento a una rete bellica di origine colombiana, composta da persone e società impegnate nel reclutamento di ex militari per combattere al fianco delle RSF contro il governo di Khartum e per addestrare giovani e persino bambini.
Etiopia ed Emirati, l’asse nascosto
Oltre ai mercenari stranieri, le RSF sarebbero appoggiate anche dalla vicina Etiopia, legata a doppio filo agli Emirati Arabi Uniti. Dalle proprie postazioni militari nel nord-ovest del Paese, Addis Abeba introdurrebbe rifornimenti bellici in Sudan. Secondo fonti sudanesi citate da Al Jazeera, in Etiopia sarebbero addestrati oltre 10 mila combattenti sotto la supervisione del generale Getachew Gudina, mentre le forniture logistiche transiterebbero attraverso i porti di Berbera, in Somaliland, e di Mombasa, in Kenya.
Fin dall’inizio del conflitto sudanese, l’Etiopia ha mantenuto una posizione ambigua. Pur dichiarando ufficialmente di sostenere l’integrità territoriale del Sudan e invocando un cessate il fuoco, nei fatti Addis Abeba ha favorito le RSF, avverse al governo centrale e all’esercito regolare. Emblematica, nel 2023, la decisione di invitare le milizie paramilitari al vertice dell’IGAD (Autorità intergovernativa per lo sviluppo), che provocò la protesta e l’abbandono della delegazione ufficiale sudanese.
Il paradosso è evidente: da un lato Addis Abeba ospita la sede dell’Unione Africana, che condanna mercenari e milizie; dall’altro, gli stessi attori non sono più stigmatizzati se combattono per una causa sostenuta dall’Etiopia. Si tratta di un doppio standard politico, mercenari e milizie vengono condannati solo quando non coincidono con gli interessi strategici etiopici.
Gli interessi comuni tra Etiopia e RSF sono infatti molteplici. Storicamente Addis Abeba è in conflitto con il Sudan per la regione di al-Fashaga, una fertile area agricola in territorio sudanese coltivata da agricoltori etiopici. Un Sudan frammentato e indebolito risulterebbe meno minaccioso per l’Etiopia. Questa sembra essere la logica politica che guida il sostegno alle RSF.
Nodo centrale resta l’alleanza tra Etiopia ed Emirati Arabi Uniti, principali sponsor regionali delle milizie paramilitari. Oltre al controllo delle rotte dell’oro proveniente dal Darfur, nel 2023 Addis Abeba ha firmato 17 accordi bilaterali con Abu Dhabi in settori chiave come commercio, investimenti, dazi doganali, industria, energie rinnovabili e infrastrutture. Gli Emirati hanno inoltre investito in Etiopia nella diga GERD e nel progetto agricolo “Wheat for UAE”.
Porti, Mar Rosso e competizione regionale
Bab el-Mandeb e il Mar Rosso rappresentano un punto fondamentale per la geopolitica degli Emirati Arabi Uniti, che attraverso DP World hanno investito miliardi di dollari in infrastrutture portuali nel Corno d’Africa. I porti sono dunque un elemento nevralgico di questa strategia.
L’Etiopia, tuttavia, non dispone di sbocchi al mare e dipende in larga misura da Gibuti per i propri traffici commerciali. Questa condizione ha alimentato la pressante campagna del premier Abiy Ahmed per ottenere un “essenziale” accesso al mare. Nel 2024 Addis Abeba ha firmato un accordo, poi rimasto in sospeso e mediato dagli Emirati, per ottenere un porto dal Somaliland in cambio del riconoscimento ufficiale del Paese.
Parallelamente, Abiy Ahmed e la stampa governativa hanno intensificato una narrativa che rivendica la necessità di un porto per l’Etiopia, giustificandola di volta in volta con argomenti storici, come il riferimento ad Assab, o con esigenze di sicurezza marittima. Argomentazioni respinte dai Paesi rivieraschi coinvolti, Somalia, Eritrea e Gibuti, che non hanno mai negato all’Etiopia l’uso commerciale dei porti, ma difendono la propria integrità territoriale e nazionale. In questo quadro, gli accordi tra Etiopia ed Emirati hanno trasformato il Mar Rosso in un elemento ad alta tensione, creando schieramenti contrapposti nella regione.
Durante una recente visita in Egitto, il presidente eritreo Isaias Afwerki ha dichiarato alla televisione di Stato che la vera posta in gioco della guerra in Sudan è il controllo del Mar Rosso, che non si tratta di un semplice conflitto interno. “Se il Sudan, con oltre 750 chilometri di costa, collassa, collassa la sicurezza del Mar Rosso”, ha affermato il presidente Isaias, che ha aggiunto che il Sudan è preso di mira da attori interessati a ottenere porti e basi militari. Ma il Mar Rosso, ribadiscono i Paesi del Corno d’Africa, non è in vendita.
Abiy Ahmed, la politica estera come fuga dalla crisi interna
In questo scenario, l’unica voce realmente dissonante è quella del premier etiope Abiy Ahmed. Non è da escludere che dietro l’alleanza con le RSF e con gli Emirati Arabi Uniti vi sia anche una strategia di sopravvivenza politica personale. In un Paese segnato da crisi economica, repressione e frammentazione sociale, la proiezione esterna e la rivendicazione di un accesso al mare diventano strumenti di legittimazione interna. Una fuga in avanti che rischia però di trascinare l’intero Corno d’Africa in una pericolosa spirale di instabilità.