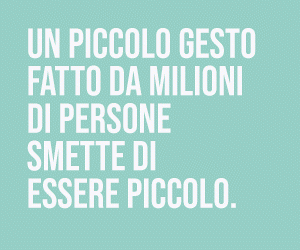Cronache
Covid, la normativa emergenziale e i pericoli per la giustizia

Ciò significa una riforma dell’ordinamento giudiziario aperta al contributo di tutti e l’abbandono di certi tic autarchici come, tanto per prendere il più recente degli esempi, la recente bocciatura di tutti i 17 avvocati selezionati per l’ufficio di consiglieri della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 106 della Costituzione. E di certo non agevola l’uscita dal guscio, e quindi dalla crisi, che tutti ci auguriamo, la paura quasi viscerale di riconoscere il diritto di tribuna ai componenti non togati dei Consigli Giudiziari. Cosa che tradisce non solo il sospetto verso i “laici”, ma anche il retropensiero che i pubblici ministeri al cospetto dei giudici non siano parti processuali poste sullo stesso piano degli avvocati.
Se Sparta piange, Atene non ride: sicuramente, anche noi avvocati dobbiamo fare di più e di meglio. La crisi dell’avvocatura ricorda quella medievale dell’Età dei Comuni, quando un florilegio di entità fu collettivamente inaridito dall’incapacità di costituire insieme un’espressione unitaria. Questo ci impedisce di fare sintesi dentro un corpo sociale che nel volgere di pochi decenni ha perso omogeneità, divaricandosi in figure economiche e a tratti culturali distanti tra loro. Un problema che sentiamo maggiormente e prima in una città come Milano, con salde radici nel passato e volitivi rami protesi verso il futuro.
Al netto di questa doverosa autocritica, rimane gravemente patologica la rarefatta presenza di avvocati nelle commissioni ministeriali, là dove si cucinano le riforme. Si aggiunga che l’avvocatura è tanto assente nei decreti attuativi del PNRR per la giustizia quanto presente in ogni antro di tribunale. Se, invece, a dispetto dell’oblio normativo, la si vede contribuire fattivamente al miglioramento delle prassi territoriali, questo è grazie alla buona volontà dei singoli capi degli uffici, ed alla loro intelligenza. A Milano è così.
Qui magistratura e avvocatura sanno anche essere complementari e consapevoli di lavorare insieme nella e per la giurisdizione, con soluzioni che travalicano i nostri confini. Ad esempio, in materia di diritto di famiglia, le linee guida volte alla ricognizione ed alla discussione di prassi organizzative e interpretative in tema di redazione degli atti, le indicazioni operative per la Ctu su famiglie e minori ed il protocollo sull’ascolto del minore hanno di recente trovato riconoscimento in sede legislativa con le recente legge di riforma n. 206/2021.
I giovani. In un recente articolo, il Prof. Natalino Irti ha notato come le Università stiano abbandonando le materie speculative, fondamentali per la loro missione di formare giuristi, a favore invece delle materie pratiche di formazione professionalizzante. Saggia considerazione. Forse è proprio questo il brodo di coltura dell’inerzia ministeriale e dell’arrendevolezza delle istituzioni forensi che da dieci anni, data di approvazione della legge professionale, ci impediscono di consegnare ai nostri giovani avvocati la possibilità di conseguire una formale specializzazione.