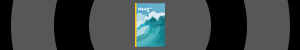Culture
"Acquanera", il nuovo romanzo di Valentina D’Urbano, narratrice degli ultimi

|
LA RECENSIONE Valentina D'Urbano, un esordio che rapisce. La recensione di Alessandra Peluso L'INTERVISTA
Scrittori, editori, editor, interviste, recensioni, librerie, e-book, curiosità, retroscena, numeri, anticipazioni... Su Affaritaliani.it tutto (e prima) sull'editoria libraria |
A 28 anni, Valentina D’Urbano torna in libreria con Acquanera, un romanzo che conferma la sua vocazione: confrontarsi con il racconto degli ultimi. E se ne Il rumore dei tuoi passi al centro della trama c'era una storia d'amore tormentata, nella seconda prova la giovane scrittrice è alle prese con tre generazioni di donne: le "ultime" in un paesino di ultimi.
Si parla di amore materno, amicizia tra donne, solidarietà tra ultimi della vita, e naturalmente anche di odio.
Nel nuovo libro l'atmosfera cambia solo in parte. In Acquanera, infatti, la premessa è sì noir, ma la morte fa da sfondo su cui si stagliano le passioni dei vivi.
LA TRAMA - È un mattino di pioggia gelida, che cade di traverso e taglia la faccia, quello in cui Fortuna torna a casa. Sono passati dieci anni dall’ultima volta, ma Roccachiara è rimasto uguale a un tempo: un paesino abbarbicato alle montagne e a precipizio su un lago, le cui acque sembrano inghiottire la luce del sole. Fortuna pensava di essere riuscita a scappare, di aver finalmente lasciato il passato alle spalle, spezzato i legami con ciò che resta della sua famiglia per rinascere a nuova vita, lontano. Ma nessun segreto può resistere all’erosione dell’acqua nera del lago. A richiamarla a Roccachiara è un ritrovamento, nel profondo del bosco, che potrebbe spiegare l’improvvisa scomparsa della sua migliore amica, Luce. O forse, a costringerla a quel ritorno, è la forza invisibile che ha sempre unito la sua famiglia: tre generazioni di donne tenaci e coraggiose, ognuna a suo modo…

L'AUTRICE - Valentina D’Urbano nasce il 28 giugno 1985. A nove anni manifesta la vocazione di diventare anatomopatologa, grazie alle riviste che trova e legge a casa di sua zia. Arriva l’adolescenza e la nostra eroina passa le sue giornate con la bombetta sulle ventitré, chiedendosi se Schopenhauer fosse maschilista, femminista o metalmeccanico. Questa è la sua espressione d’arte. Qualche anno dopo scrive un romanzo intero, tutto in stampatello e senza figure. Da grande vuole fare la scrittrice, l’illustratrice, l’anatomopatologa, la necromante, la serial killer e il vampiro.
Valentina D’Urbano, illustratrice per l’infanzia, così rappresenta il suo nuovo romanzo:

(per gentile concessione di Longanesi)
Dormono, non li svegliate
inseguon le orme di un sogno lontano.
Non li svegliate, dormono.
INCISIONE SU UNA TOMBA AL CIMITERO
MONUMENTALE DEL VERANO, ROMA
La morte verra` all’improvviso
avra` le tue labbra e i tuoi occhi
ti coprira` di un velo bianco
addormentandosi al tuo fianco...
FABRIZIO DE ANDRE
Oggi, 12 marzo 1992
Dieci anni senza mai tornare.
Quando arrivo è quasi mattina e piove, una pioggia di traverso, gelida, che ti taglia la faccia.
A Roccachiara è sempre così. Fa freddo e piove, oppure l’umidità è talmente densa che fa lo stesso, è come se piovesse.
Mi incammino per la via principale del paese e tutto e` uguale a come mi ricordavo, sembra una fotografia, non cambia mai.
Le case costruite una addosso all’altra, le inferriate dei negozi ancora chiusi, le stesse insegne di trent’anni fa. Le strade strette e desolate, i vicoli con le fioriere appese accanto alle porte.
Non c’è nessuno, solo la pioggia.
Tutto il resto è il silenzio.
Dicono che tutto questo silenzio provenga dal lago. Si solleva come nebbia, si spande per il paese, soffoca tutti i rumori.
Attraverso l’intero abitato senza incontrare anima viva e arrivo fino alle ultime case in fondo. Lì c’è uno sputo di piazzetta
a picco sulla valle e sul lago. È il Belvedere degli eroi. Lo ricordavo spoglio e malandato, una manciata di metri quadri strappati allo strapiombo.
Adesso è molto diverso. Lo spiazzo lastricato, le panchine di metallo con la vernice bianca e scrostata. Una brutta fontana ornamentale, le targhe alla memoria dei caduti. Una balaustra in ferro battuto ha sostituito il vecchio muro di mattoni da cui ci si affacciava per vedere il lago.
Quel lago nero, che non ha vita.
Ci sono anche dei gradini scavati nella pietra che, dal belvedere, scendono giù verso il sentiero che si inoltra nel bosco. Prima non era che l’abbozzo di una scalinata malmessa e poco praticata. Negli anni Quaranta e Cinquanta la usavano soltanto le lavandaie e i pescatori, adesso è roba per turisti, con i corrimano in legno e le indicazioni per raggiungere la stradina sul lungolago.
Un cartello segnala che alla fine del percorso c’è un chiosco che vende gelati, è aperto solo d’estate.
Mi siedo sulla panchina con la vista migliore e per un po’ rimango a guardare lo spiazzo deserto e lucido di pioggia, le case con le imposte ancora chiuse, il lago calmo tra le montagne.
C’è un bel panorama, da qui.
Dicono che sia un bel posto, questo. Lo dicono sulle guide turistiche, nei manifesti della pro loco, qualche volta l’hanno detto anche in tv.
Quando non ci hai abitato, e sai anche che non ci abiterai
mai, perfino questo ti sembra un bel luogo in cui vivere. Aspetto un po’, fa molto freddo, dopo tre minuti già fatico a sentirmi i piedi.
Una volta, quando ero piccola e la piazza ancora non era stata ristrutturata, trovarono il cadavere di un ubriaco proprio lì, su una di quelle panchine. Si era sdraiato, si era addormentato ed era morto assiderato durante la notte.
Era un vecchio avvinazzato che viveva da solo. Tutti in paese
lo conoscevano, io lo ricordo seduto ai tavolini di plastica del bar. Si chiamava Abner. La notizia della sua morte non mi fece effetto, non era un mio amico.
Non fece effetto a nessuno, a dire il vero, la sua morte passò
quasi inosservata.
Tranne che per Luce.
Luce si dispiaceva per tutti, qualche volta addirittura piangeva. Era una sorta di rito. Anche se non li conosceva e non gliene fregava niente, lei cercava di sentirsi triste lo stesso. Per dare consolazione all’anima del defunto, diceva.
Come se le lacrime di una sconosciuta potessero consolarti
del fatto di essere morto stecchito.
Seduta sulla panchina, ripenso al vecchio Abner e all’espressione affranta di Luce, ma i ricordi non scaldano e il gelo mi sta salendo rapido su per le gambe. Mi alzo. Al posto dei piedi ho due pezzi di ghiaccio.
Guardo in alto. Nell’unica casa affacciata sulla piazza c’è una luce accesa, quella della cucina.
Lo so perché quella, una volta, era casa mia.
Avvolta in una vestaglia blu che deve avere almeno un secolo, mia madre Onda sta ferma sulla porta. Ha la faccia piena di rughe, dimostra il doppio dei suoi anni e mi scruta con un’espressione interrogativa.
Mi accorgo che e` invecchiata male, ma anche io devo essere cambiata.
I miei occhi sono sempre gli stessi, di un grigio incerto che
cambia colore a seconda del tempo, e le lentiggini sul viso sono
rimaste tutte al loro posto, eppure, in qualche modo che non
mi so spiegare, sono diversa da come lei mi ricorda.
E, per un momento, ho l’assurda certezza che non mi riconoscerà.
«Fortuna?» chiede, inarcando un sopracciglio.
«Sì.»
« Ah, ecco. Sei tu », dice alla fine, senza cambiare espressione.
«Che hai fatto ai capelli?»
Mi afferro una ciocca, la liscio con le dita. Ho i capelli neri, ma non è il mio colore naturale.
«Li ho tinti», rispondo.
Sembra accontentarsi.
«Allora, entri o no? Non posso mica stare tutto il giorno qui a perder tempo.»
Faccio un passo in avanti e lei ne fa uno indietro.
Poi, come se non fossero anni che non ci vediamo, mi volta le spalle e se ne torna in cucina.
«Se hai fame preparati la colazione, io ho già mangiato.»
«Mi faccio solo un caffè. L’avrei preso al bar, ma era ancora chiuso.»
«Non aprirà fino all’estate. Stanno facendo dei lavori di ristrutturazione.»
«Capisco», dico. Non mi interessano le sorti di quel bar. Mi guardo intorno.
La casa dove sono nata e cresciuta è identica a come la ricordo, quasi che insieme al paese abbiano congelato anche lei. Le cornici d’argento annerito con le fotografie antiche, i vasi decorati, le statue dei santi e i rosari della nonna, e quegli orribili, decrepiti centrini all’uncinetto che avranno più di un secolo e che stanno a prendere polvere sui mobili. Erano di Clara Castello, la vecchia strega da cui mia nonna aveva ereditato quella casa, e nessuno ha mai avuto il coraggio di buttarli via.
Anche le riviste appoggiate sul televisore sembrano di almeno dieci anni fa.
Eppure, anche se è tutto uguale a prima, lì dentro io mi sento un’estranea.
«Sei in ritardo. Ti aspettavo per ieri sera», dice mia madre all’improvviso.
«Mi aspettavi? E come facevi a sapere che stavo tornando?»
C’è l’ombra di una smorfia compiaciuta sulla sua faccia, o forse me lo sto solo immaginando.
Credo che mia madre abbia tirato a indovinare. Credo che
sappia che e` stata la notizia apparsa sul giornale a spingermi a
venire fin qui, io che in questo posto avevo giurato di non tornarci mai piu`.
«Anche tu l’hai letto sul giornale?» le chiedo.
Apro la borsa, tiro fuori il quotidiano. di ieri, è tutto spiegazzato.
Nel bosco che si estende tra il lago e il paese hanno trovato delle ossa umane. Erano in una forra profonda, semisepolte dal fango e coperte dalle piante, e sembra fossero lı` da un pezzo. Le ha trovate un turista a passeggio col cane. Sono ossa di donna, altro non si sa. Non c’erano documenti o segni particolari, niente. Solo ossa grigie e scalcinate ricoperte da stracci irriconoscibili, e neanche due capelli attaccati al cranio. La natura segue il suo corso, consuma tutto, l’ha fatto anche con quel corpo di cui ora rimangono solo dei pezzetti.
Seduta al tavolo della cucina, leggo l’articolo di giornale ad alta voce. Mia madre non dice nulla, sembra quasi che non ascolti. Si muove da una parte e dall’altra, sposta piatti e barattoli, soffia via della polvere immaginaria. Sembra nervosa.
Quando finisco di leggere finalmente si gira e, per la prima volta da quando sono entrata in casa, mi guarda negli occhi.
«Non serve mica che mi leggi il giornale. Io lo sapevo già daprima, Fortuna.»
«E come facevi a saperlo?»
«L’ho sognato la notte scorsa.»
Un brivido di freddo mi striscia su per la schiena e mi morde
la nuca, ma faccio finta di niente. Mia madre non e` tanto normale, qui lo sanno tutti.
«E che cosa hai sognato?»
«Eravamo sul lago, alla radura dei pescatori. C’eri tu e c’era anche Luce, eravate ancora bambine, ma non vi ho visto in faccia. Guardavate l’acqua e non volevate voltarvi. E poi c’era la voce di Luce, veniva fuori da qualche parte, non capivo da do-
ve.»
Scuoto la testa, cerco di non darle importanza.
Vorrei che mia madre fosse normale. Vorrei una madre con
la testa a posto.
«E che cosa diceva quella voce?»
«Che tornavi. Che c’è una cosa che sai solo tu, e che la devi dire.»
Ci sono tantissime cose di Luce che so soltanto io e che non
dirò mai. Un milione di cose. Alcune le ho volute dimenticare.
«Onda...»
«Che vuoi?»
Conosce già la domanda che sto per farle.
«Secondo te, lo scheletro nel bosco... Si tratta di Luce?»
Ci fissiamo a lungo, in silenzio. Cerca di leggermi dentro e
intorno, ma non ci riesce.
Non ci e` mai riuscita con me. E ` per questo che mi odia.
«Solo tu lo puoi sapere » dice alla fine, con la voce che trema
un po’. « per questo che sei tornata, no?»