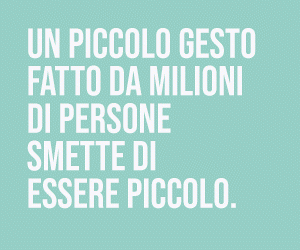Culture
Come un soffio di vento
I pazzi e i sognatori credono in ciò che è falso, scriveva Platone.' "Il sogno è l'infinita ombra del Vero", esclama Alessandro Magno, nel poemetto che gli dedica Giovanni Pascoli; dopo aver marciato con i suoi soldati fino alle sponde dell'Oceano Indiano, riflette sulla coincidenza imperfetta tra sogno e realtà: senza limiti il primo, circoscritta e parziale la seconda. Meglio fermarsi al di qua dalle montagne e toccare, nella profondità del mondo interiore, orizzonti che dal primo valico non si possono scorgere.
Sogno e follia sono percorsi di conoscenza alternativi ai procedimenti consueti della razionalità. E sono forme diverse d'illusione, dal momento che chi è folle, al pari di chi sogna, scavalca i confini della ragione ed esprime modi d'essere fondati sul dissolvimento del senso comune, traducendo il rapporto tra l'io e il mondo in una riscrittura deformata, eccessiva, si direbbe quasi teatrale.
A differenza della follia, però, il teatro del sogno ha un solo spettatore: la persona che sogna. E davvero in questo caso di teatro bisogna parlare in senso proprio, perché le fantasie oniriche drammatizzano attraverso scene e azioni una realtà psichica che non potrebbe emergere in altri modi, ma può rendersi percepibile solo attraverso le sfuggenti trame che si compongono e sí disfano da sole davanti ai nostri occhi addormentati.
Eppure sembra che accadano cose che in realLI uon esistono".'
Ma davvero non esistono? Quello del sogno non è uno spazio vuoto; piuttosto, è uno spazio aperto in cui possono pene( l'a re persone lontane, o assenti. Talvolta due persone care s'incontrano lì, una viva e l'altra morta, e il sogno nuovamente le avvicina: il più antico esempio di questa vertigine dell'esistere e del non esistere è il sogno di Achille nell'Iliade, in cui il defunto Patroclo gli appare vicino, bello e misterioso. Una versione molto recente è quella del poeta americano Wendell Berry:
In un sogno incontro
il mio amico morto. Se n'è andato,
lo so, molto lontano, eppure è sempre lo stesso
perché immutabili sono i morti.
Non invecchiano.
Sono io che sono cambiato,
e quel che ero mi è diventato estraneo.
Ma io, quello cambiato, gli chiedo: "Come stai?". Lui sorride e mi guarda: "Ho mangiato pesche colte da alberi bellissimi".
Probabilmente questa poesia sarebbe piaciuta a un lettore antico, perché rovescia lo stato di due situazioni immutabili e non interscambiabili, la vita e la morte, come tanto spesso avviene nei sogni raccontati dagli autori classici.4 Il sogno lo può fare e i sognatori antichi lo sapevano bene, forse meglio di noi: per tutta l'epoca antica il sogno rimase il luogo per eccellenza in cui realtà improbabili s'incontrano, comunicano, e talvolta si scambiano di posto.
Ma i sogni non sono sempre così. Per il sognatore e per i morti del sogno il tempo scorre diversamente rispetto quello della veglia, e può scorrere nelle due direzioni, in avanti e all'indietro. I vivi invecchiano, i morti no; il tempo del sogno mescola questi due piani. Quando Enea sogna Ettore, la notte della presa di Troia, il sogno fissa la sua individualità temporale in un momento preciso del passato: non è l'Ettore armato e glorioso che inseguiva i Greci nella pianura di Troia, ma quello maciullato che Achille trascinava morto dietro il suo carro. Due volte lontano dal vero, dunque, questo Ettore: perché è un'immagine onirica e perché in sogno compare non come vivo ma come già morto, seppure parlante, però quantum mutatus ab illo. Eppure, entrambi sono Ettore, quello vittorioso e quello sconfitto, e tutti e due sono presenti nella memoria di chi sogna. Il sogno ne sceglie uno solo, secondo leggi che sfuggono al sognatore.
Se il sogno è una finzione, è una finzione che contiene verità. Una vita speciale, infatti, si apre quando la vita reale si spegne durante il sonno, e così se il sonno appare come una sorta di morte provvisoria, è una morte inquieta, pullulante di vita. Immaginiamo la morte — dice il Socrate di Platone nell'Apologia5 — come un sonno senza risveglio e l'eternità appunto come un sonno durante il quale non si fanno sogni. Già, ma invece il sonno porta con sé í sogni e dunque interrompe l'esperienza del non esserci; perciò esso certifica un certo tipo di esperienza vitale, seppure di natura diversa rispetto a quella che compone l'esistenza quotidiana.
A livello mitico la contiguità tra sonno e morte s'impone quasi naturalmente: per Esiodo,' Hypnos e Thanatos sono due tenebrosi fratelli, i figli che Notte buia generò per partenogenesi, e loro fratelli sono anche Chera e Moron (altre due personificazioni della morte) e insieme a loro "la stirpe dei sogni" che sciamano tra gli uomini, vicinissimi perciò alla Morte e al Destino. Hypnos e Sogni accompagnano l'uomo nell'alternanza di coscienza e non coscienza, sino ad arrivare alla non coscienza senza possibilità di ritorno alla coscienza, e quindi a Thanatos. Invece, la morte provvisoria che è il sonno si popola di forme e messaggi che emergendo dall'incoscienza si proiettano sulla memoria di chi si ridesta.
E se la realtà di chi è morto, e il suo modo di percepire le sensazioni nell'Aldilà, fossero di natura affine a quella che i viventi sperimentano durante i loro sogni?
Omero immagina che i morti racchiusi nell'Ade siano simili a un sogno; quando Odisseo incontra la madre Anticlea nel buio regno sotterraneo' si slancia verso di lei per abbracciarla, ma per tre volte il fantasma gli svanisce tra le mani volando via "come un ombra o un sogno". "Ah, figlio mio — gli dice poi dolente la madre — questo è il destino di ogni uomo, quando il fuoco dissolve le ossa sul rogo e la forza vitale vola via; da quel momento l'anima vaga nel mondo delle ombre, simile a un sogno (éute Oliar)".
Già, Odisseo non riesce ad abbracciarla, il fantasma vola via come si dissolvono i sogni al risveglio. La parola che Omero usa per definire l'entità che Odisseo tenta invano di stringere al petto diventerà poi fondamentale nella storia del pensiero occidentale: psyché, che solo con una certa forzatura si potrebbe tradurre con "anima", valore che questa parola assunse relativamente tardi nella lingua greca. Quella che appare a Odisseo nell'oltretomba non è veramente un'anima, quanto meno nel senso platonico (e poi cristiano) del termine; è piuttosto una sbiadita copia della persona, che però continua a provare emozioni e sentimenti, parla, ricorda; un morto è al di fuori del tempo, ma per un'ombra come quella di Anticlea il tempo continua in qualche modo, pur lentissimo, a scorrere.
Figure come questa sono indicate anche anche con un altro nome nella lingua greca: éidolon. Un éidolon non è qualcosa di reale, ma non è neppure una pura e semplice immagine priva di sostanza: è un'entità mista, un "doppio" della persona che pur conserva qualche forma di energia vitale.' Non lo si può toccare, fugge via, svanisce; eppure per qualche istante esiste, comunica, e la sua figura possiede una sua autonoma energia. I Greci attribuivano lo stesso statuto ai sogni e alle ombre dei morti, entrambe figure dell'immaginario, entrambe entità che vivono in uno spazio intermedio, lontane dai viventi ma non tanto da esserne completamente separate, designandole persino con l'identico nome; la stessa forma può essere Onar" sogno" ma anche psyché "soffio di vita" o "fantasma", e anche éidolon parvenza simile al vero".
Un passo dell'Iliade mostra come Omero percepiva la natura di questo sogno-fantasma. In questo stato Patroclo compare a Achille, poco dopo la morte e prima di essere definitivamente sepolto:
Lo ghermì il sonno, sciogliendogli le pene dell'animo, si riversò soave sopra di lui [...] ed ecco venne a lui l'ombra (psyché) dell'infelice Patroclo, che gli somigliava in tutto, in grandezza, bellezza, occhi belli e voce, e sul corpo indossava identiche vesti. Stette accanto al suo capo e gli disse: "Tu dormi, Achille, e ti sei scordato di me: mi amavi da vivo, ma mi trascuri da morto. Seppelliscimi, fa che io entri nelle case dell'Ade; da lì mi tengono lontani le ombre (psych di), fantasmi (éidola) dei morti, e non consentono che mi unisca loro oltre il fiume, ma devo vagare così, davanti alla dimora di Ade dalle ampie porte. Ora dammi la mano, ti prego, non tornerò più dall'Ade dopo che mi avrete affidato alle fiamme". (Iliade, 23, 62-76)
L'immagine onirica parla a lungo, piena di sofferenza e sembra avere una vita psicologica tutta sua. Possiede una memoria che travalica il momento circoscritto del sogno: rievoca i momenti belli in cui i due amici si facevano le loro confidenze in disparte dagli altri; è la memoria di un fantasma, proiettata verso un tempo finito per sempre, ma questo fantasma possiede pure la capacità di allungare lo sguardo su un tempo che ancora non c'è, quando predice a Achille la prossima morte in battaglia. Il sogno ha anche una sua autonomia volitiva, dato che prega l'amico di far seppellire, quando sarà venuto il suo momento, le proprie ossa nella stessa urna, in modo che quelli che erano stati amici da vivi possano dormire insieme per l'eternità.
Sin qui parla il sogno, un sogno ben strano e inquietante. Ma il sognatore non rimane passivo.
E rispondendo parlò Achille dai piedi veloci: "Perché, cara testa, sei venuto sino qui e mi comandi queste cose? Certo, farò tutto quanto, compirò ciò che comandi, ma vienimi più vicino, che per un attimo ci abbracciamo e possiamo godere del pianto amaro l'uno con l'altro".
Con queste parole tese le braccia, ma non lo raggiunse: l'ombra (psyché) come fumo sotto la terra fuggì stridendo. Stupito Achille balzò in piedi, batté le mani e disse meste parole: "Ah, allora esiste anche nelle case dell'Ade una vita (psyché) e un'ombra (éidolon) ma dentro non sta più la mente! Tutta la notte mi è stata accanto l'ombra (psyché) dell'infelice Patroclo, e piangeva, e gemeva, e molte cose mi ha raccomandato, e assomigliava a lui in modo perfetto". (Iliade, 23, 93-107)
Così infatti, spesso, finiscono i sogni: con un'azione interrotta a metà, nel momento culminante, e con un desiderio incompiuto nel passaggio dal sonno alla veglia. Proprio quando il sogno sembra vero e il sognatore cerca di penetrare ancora di più nella realtà dell'immagine onirica, allora qualcosa s'inceppa nei meccanismi di produzione del sogno e la scena si dissolve in un istante risucchiata dall'ombra da cui era arrivata; il sognatore si ridesta col sentimento di avere vissuto un'esperienza tanto vicina al vero da sembrargli reale, ed è ancora tutto preso dall'emozione che dal sogno trabocca nella veglia.
L'immagine che sí forma davanti agli occhi di Achille è certamente un sogno, dal momento che gli compare nel sonno, ma non si può dire che sia soltanto un sogno. L' éidolon che visita Achille non viene descritto come un prodotto della sua mente (infatti arriva da un altro luogo, superando le porte dell'Ade, e sparisce tornando lì); non è però neppure una realtà oggettiva, perché ha bisogno di una situazione particolare (il sonno) per manifestarsi e non possiede una sua autonomia al dí fuori dí esso, ma viene risospinto dalla realtà dei vivi a quella dei morti a cui appartiene, sicché non si potrebbe dire se l'immagine di Patroclo svanisce perché Achille sí risveglia o fugge via perché l'apertura che connette i vivi e i morti si è richiusa improvvisamente per qualche misteriosa ragione.
Questa figura è una terza forma di realtà, proprio come i sogni sono partecipi contemporaneamente del reale e del fantastico: non a caso la parola éidolon viene riferita in greco a fenomeni che a noi sembrano assai distinti tra loro come l'ombra, il fantasma, il sogno, la statua, tutti oggetti che assomigliano a una persona ma non sono lei davvero. Non è un'anima esterna, ma una proiezione dell'io, senza però possedere ciò che caratterizza l'io nella sua veste principale, cioè la certezza di esistere. Sembra tutto vero, però: voce, parole, ricordi, occhi belli. Eppure è un'illusione. Questa fessura tra i due mondi è il sogno ad aprirla. Achille vuole abbracciare il suo sogno: ma lo spiraglio, come si apre, così si chiude, certificando l'impossibilità di sovrapporre le due esperienze.
Questo famoso e commovente episodio è notevole anche per altri motivi. È una delle più antiche testimonianze nella cultura greca di una fede nella sopravvivenza dopo la morte dí qualcosa che prosegue l'esistenza. Lo dice infatti Achille: se un morto compare durante il sogno, che è un'esperienza vitale, in i nodi così chiari e distinti, allora quel morto deve dimorare insieme agli altri morti in qualche parte dove noi non possiamo penetrare coi sensi.
Attraverso le parole di Achille, Omero sembra anticipare l'opinione di coloro che, ai primordi dell'antropologia sociale, quando si andava a caccia dell'"anima primitiva" da ricostruire, hanno pensato che dal sogno si sia sviluppato l'embrione di t lila credenza relativa all'esistenza dell'anima: non dai fenomeni del sentire, del volere e dell'intendere nell'uomo desto e cosciente (scriveva Erwin Rohde, autore dello studio tuttora più importante sulla nascita del concetto di anima'°) ma da quelli del sogno, del deliquio e dell'estasi si è potuta dedurre l'esistenza di due esseri viventi nell'uomo e di un secondo io nell'interno dell'io di tutti i giorni, dal quale in certi momenti ci si può distaccare e vivere una vita autonoma in un mondo diverso, parallelo a quello reale.
Se Patroclo dopo la morte può ancora manifestarsi, anzi con poteri che in vita non possedeva come quello di penetrare nella mente di altri esseri viventi, allora chi lo vede, lo sente e vuole persino abbracciarlo come si fa tra viventi si trova davanti all'evidenza del fatto che deve esistere una forma speciale di vita dopo la morte.
Spesso infatti i morti compaiono in sogno e aprono per qualche istante le porte dell'Ade; morti afflitti o morti placati si comportano così come nel racconto dell'Iliade Patroclo si comporta con Achille. "Il solo fatto di sognare persone morte", dice Artemidoro," "indica che ci si troverà nella situazione che i morti avevano in vita nei confronti di chi ha visto il sogno. Se erano amabili e benefici annunciano del bene e un futuro piacevole, il contrario indica il contrario".
Una situazione del genere si raccontava a proposito di Simoníde. Mentre stava andando a Taranto per imbarcarsi, egli s'imbatté in un cadavere insepolto e piamente gli diede una tomba. La notte successiva il fantasma dello sconosciuto senza nome gli apparve in sogno e gli sconsigliò di salire sulla nave sulla quale Simonide aveva gíà deciso di imbarcarsi; il poeta diede ascolto alle parole della visione e rinunciò al viaggio. Infatti, la nave affondò.'2
Gli stoici spiegavano fenomeni di questa natura come la prova del legame dí affinità che unisce tra loro tutte le anime dell'universo, i vivi e i morti insieme.
Ogni essere umano sperimenta ogni giorno, attraverso quella provvisoria forma dí follia che è il sogno, l'alternanza di pensiero cosciente e impulsi irrazionali, di organizzazione volontaria dell'esperienza mentale e di stimoli incontrollabili che il sogno fa emergere da un apparente nulla: e questo pone ogni uomo davanti all'evidenza del suo sdoppiamento, e del fatto che egli si muove all'interno di due percorsi psicologici organizzati secondo categorie opposte e tuttavia compresenti ín ogni membro della specie umana, dal momento che nulla, forse, unifica l'umanità quanto l'esperienza del sogno.']
Per questo il sogno contribuisce a plasmare un'identità, sia individuale sia collettiva; l'autocoscienza si costruisce anche attraverso il confronto con l'io onirico che opera dentro ciascuno, trasmettendo una silenziosa corrente di messaggi proiettati sulla vita cosciente. Sarebbe un'esperienza estrema fondare la propria identità sul colloquio costante col proprio compagno segreto (come faceva Elio Aristide nella tarda Antichità, e come fanno mistici, profeti e sciamani di ogni epoca); tuttavia, escludere il sogno dalla propria esperienza per relegarlo in qualche angolo buio del non-senso significa galleggiare abbastanza in superficie sul mare della coscienza.
Significa perdere, in primo luogo, una parte del proprio bagaglio mitico, dato che il sogno e il mito usano le stesse strutture simboliche e narrative, al punto che lo stesso fondatore della psicoanalisi arrivò a dire che il sogno è il mito di un individuo, come i miti sono il pensiero sognante di un popolo ovvero "i sogni continuati per secoli della giovane umanità"."
Molto prima di Freud, Sinesio di Cirene (v secolo d.C.) aveva formulato l'idea che erano stati proprio i sogni a stimolare l'umanità a inventare i miti.'
Il sogno può essere una sorgente di creatività, può stabilire un contatto con zone segrete della mente, nelle quali l'esperienza diurna non riesce penetrare, come avveniva a Lucrezio, il quale assicura che nei sogni la sua parte notturna continuava a elaborare pensieri e a inventare versi per il suo poema, come una sorgente sotterranea di poesia ("naturam quaerere rerum semper et inventam patriis exponere chartis").
La cultura greca ha sviluppato un'antropologia del sogno centrata sull'individuo e sulla sua vita reale anziché sui poteri estatici dell'anima poiché il sognatore è saldamente ancorato a questo mondo, mentre le figure del sogno custodiscono la porta di quello invisibile nel quale vivono a modo loro e dalle quali possono talvolta uscire.
Altre culture immaginano scenari differenti. Per i Maori, per esempio, quando uno dorme la sua anima "si reca nel reinga", e lì prende contatto con i morti; il sogno è il veicolo di questo viaggio ín cui la realtà della veglia non è più vera o reale di quella del sogno, ma ha solo uno statuto differente. Dai morti e dagli spiriti capita di sentire consigli, pareri, ammonimenti, e attenersi alle indicazioni di chi vive nel reinga, e diventa un obbligo cogente per le persone che ricevono i sogni; capita persino che qualcuno venga ritenuto responsabile per azioni viste in sogno come se le avesse davvero compiute e che tuttavia per l'opinione comune non hanno meno valore di quelle compiute nella veglia. Così, il sogno di Achille trasmette un modello onirico alquanto arcaico, ín cui il sogno è considerato vero, sebbene chi sogna abbia la percezione di muoversi su un piano di realtà differente da quello delle sue esperienze abituali.
Ma se proviamo a vedere questo sogno secondo una prospettiva più strettamente psicologica, vale a dire analizzandolo come se fosse semplicemente il prodotto della mente di Achille e non un'apparizione giunta dal mondo dei morti, allora si può constatare che, come spesso accade in Omero, esso possiede una precisa plausibilità.
L'incontro notturno con Patroclo dà forma onirica ai sensi di colpa di Achille per non avere saputo proteggere il diletto amico morto in battaglia in vece sua, e per non essersi ancora preso cura dei suoi riti funebri. Dà luogo a una serie di timori e paure sulla morte e sul regno dei morti, dove agiscono presenze ostili, questi_ duri morti che scacciano l'ombra di Patroclo e non vogliono ammetterla tra loro sinché non sono state compiute le dovute cerimonie; contiene un frammento di cultura collettiva (cioè l'idea che senza sepoltura i morti vaghino infelici); dà forma al desiderio di rivedere una persona cara persa per sempre.
Infine, contiene aspetti fortemente emotivi: il rimpianto per i momenti passati insieme, che mai più torneranno, il desiderio di Achille di stare vicino al suo amico, l'angoscia di Patroclo. È un sogno pieno di pathos, e non soltanto perché a descriverlo è il principe dei poeti: come spesso avviene in Omero, i sogni costituiscono un veicolo di tensioni emotive complicate e intense.
Il sogno di Achille suggerisce un altro aspetto specifico del meccanismo onirico: il dislivello tra il tempo del sogno e quello del sognatore. Pochi giorni sono passati da quando Patroclo è morto, e Achille lo immagina del tutto simile al vivente, nelle vesti, negli occhi belli, nella voce, nelle vesti. È fotografato in un attimo senza tempo: non è il Patroclo armato di bronzo che insegue i Troiani, neppure quello nudo e coperto di polvere e piaghe che Achille ha raccolto dalla battaglia. È un alter ego depurato dal tempo e trasferito in un immaginario astratto, come se Achille volesse sottrarlo al fiume del tempo che scorre, e che tra poco inghiottirà anche lui.
Invece, talvolta il sogno può recuperare il tempo perduto. " Penso che chi muore in tarda età ritrovi la sua giovinezza nel reinga", racconta la vecchia donna Maori, "Io sono stata nel reinga la notte scorsa, e ho trovato la mia vecchia amica Kiriwera: aveva un'aria molto giovane e piacente"."
Questa vecchia Maori ha un antecedente illustre. In uno dei più sorprendenti episodi onirici dell'Odissea,' Odisseo, dopo avere incontrato Penelope sotto mentite spoglie, e in attesa, il giorno seguente, di chiudere i conti con i pretendenti, si sta agitando sul suo giaciglio, incapace di prendere sonno, e si gira da una parte e dall'altra "come un uomo rivolta sul fuoco una salsiccia che sta cuocendo, molto bramoso che sia cotta" (commenta estrosamente Omero). Gli compare Atena che lo rimprovera dolcemente: perché amico mio ti agiti così, incapace di prendere sonno? Molti altri (prosegue la visione) hanno avuto fiducia in amici meno forti di me; tu fidati, nessuno domani ti potrà colpire, neppure se avessi davanti cinquanta nemici, perché io ti proteggerò. Ora dormi, perché domani ti attende una giornata decisiva. Con un tocco lo fa cadere nel sonno.
In quello stesso momento Penelope sí ridesta e ricorda un sogno appena terminato: ho visto — dice turbata — accanto a me lo sposo, bello e giovane come quando era partito per Troia; il tempo per lui non sembrava passato, e abbiamo fatto l'amore. Lo sposo in carne e ossa giace a pochi metri da lei, anziano e ancora più invecchiato dal suo travestimento di mendicante; forse Penelope lo desidera comunque, forse una corrente di emozioni si è mossa la sera prima quando i due stavano seduti l'uno accanto all'altro, parlandosi di tante cose intime, e sebbene Odisseo non si fosse rivelato, forse Penelope aveva capito, e gli aveva anche raccontato un proprio sogno pieno di desideri inespressi.''
Poco dopo il tempo scorre in avanti: l'eroe, quello reale che dorme sul pavimento dell'atrio avvolto di coperte come un barbone, si ridesta sentendo piangere Penelope e nel dor m iveglia ha l'impressione che la moglie si stia chinando sopra di lui. Un'immagine, come quelle che sembrano reali, nel momento in cui la mente ondeggia tra sonno e veglia. Forse anche Odisseo aveva appena finito il sogno di fare l'amore con Penelope, giovane e bella, come quando vent'anni prima l'aveva seguita con gli occhi sulla riva, mentre la sua nave stava allontanandosi da Itaca alla volta di Troia.