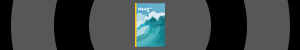Culture
Eternità, durata, stabilità: l'ideale dell'uomo
Gli uomini non accettano che la vita sia dominata da quella che Giordano Bruno chiamava la vicissitudine, e tendono al-l'eterno. Come tutti gli altri esseri viventi, sono abitati da qualcosa di eterno, la vita, e tendono a identificarsi con essa nella sua eternità. Ciò riesce in pratica finché essi sono in grado di servire la vita che li abita e che si svolge attraverso di loro secondo la propria legge di realizzazione e incremento: non riesce più quando, per vecchiaia o altri impedimen-ti, essi non sono più in grado di servirla.
La vita allora si ritira da loro, abbandonandoli a se stessi come spoglie svuota-te. Sapendo comunque di non essere essi stessi eterni, gli uo-mini inseguono l'eternità con ogni mezzo possibile. In pri-mo luogo con le religioni. Queste promettono infatti l'eter-nità, se si vive secondo i loro canoni, i quali canoni tendono a loro volta, in forme diverse nei vari popoli e nelle varie epoche, a servire la vita. Le religioni promettono l'eternità o con l'immortalità delle anime, magari con l'aggiunta della resurrezione dei corpi, o con l'animismo, la metempsicosi e la reincarnazione, l'identificazione mistica con Dio, l'eterno ritorno di tutte le cose, o con altre escogitazioni ed espe-dienti, di cui è piena la storia del genere umano.
In mancanza dell'eternità, quelli che non sono credenti cercano e praticano, come in secondo luogo fanno pure i credenti (la fede arriva solo fino a un certo punto), tutto ciò
che assicura durata e stabilità: il culto dei morti, la ricerca della fama e della gloria (last disease of the noble mind),' an-chc nelle forme più basse e talvolta perfino col delitto, la creazione di opere, palazzi, regge (Versailles, Caserta), pira-midi, tombe, monumenti «immortali» e tutte le forme di continuazione del nome e delle tradizioni famigliari, oltre-ché delle istituzioni e tradizioni statali e sociali.
Tutti questi tentativi, di ampio o corto respiro che siano, sono tuttavia destinati a infrangersi contro l'opera distrutti-va della vita e del tempo: della vita, che è perenne trasmuta-zione e sempre di nuovo deve autosuperarsi e negare ciò che prima ha amato, come veracemente confessa a Zarathustra («Qualunque cosa io crei e comunque l'ami: ben presto so-no costretta a diventarle nemica, ad essa e al mio amore»),2 e del tempo, che cancella irrimediabilmente tutto ciò che esi-ste, anche le cose più durature. Dunque la ricerca degli uo-mini non può approdare, anche nel caso migliore, se non a un surrogato. Ciò nonostante, ossia pur sapendo ciò, l'uomo nen può fare a meno di insistervi, di continuare a cercare eternità, durata e stabilità, essendo fatto come è fatto e non potendo essere fatto diversamente. D'altra parte è innegabi-le che la vita umana e degli altri esseri viventi è possibile so-lo nell'enclave di stabilità che è loro concessa, in modo para-dossale, nel moto vorticoso dell'universo, moto che non si differenzia molto dall'esplosione iniziale del Big Bang.
Tentativi simili destinati al fallimento sono anche quelle operazioni con cui í filosofi cercano e trovano, o credono di trovare, il modo, il metodo, la regola zur Lebenswei sbei t: che consente cioè di condurre una vita saggia o di raggiungere acidi ri t tura un'eterna felicità. Tali sono per esempio il cogito ergo sum di Cartesio e l'amor dei intellectualis di Spinoza. Parleremo qui, per avvalorare la nostra tesi, di questi due ten-tai ivi, che sono depositati in due libri divenuti da allora fa-mosi: il Discorso del metodo e l'Emendazione dell'intelletto — il secondo molto meno conosciuto del primo, ma certamen- te non meno importante — per le considerazioni a cui si pre-stano circa quello che può essere il miglior modo di vivere per noi uomini.
Il Discorso del metodo sarebbe in realtà, da un punto di vista strettamente filosofico e metodologico, un calmo e as-sennato delirio, qualora si dovesse applicare agli altri e non all'autore stesso. Vale per esso quello che Nietzsche dice dei sistemi filosofici, i quali sarebbero dei mémoires involontari e inconsapevoli dei loro autori. Della pretesa di Cartesio che il cogito ergo sum sia una certezza immediata, Nietzsche par-la specificamente nell'aforisma 16 di Al di là del bene e del male. Qui dice fra l'altro: «Creda pure il popolo che il cono-scere sia un conoscere esauriente; il filosofo deve dirsi: se scompongo il processo che si esprime nella proposizione "Io penso", mi resta fra le mani una serie di asserzioni temerarie che è difficile, forse impossibile giustificare — per esempio che sono io che penso, che in genere debba esservi qualcosa che pensa, che il pensare sia un'attività e l'effetto di un esse-re che viene pensato come causa, che esista un "Io", e infine che sia già assodato che cosa si deve intendere per pensare — che io sappia che cos'è pensare. Giacché se io non mi fossi già deciso al riguardo per conto mio, in base a che cosa po-trei giudicare che ciò che sta accadendo non sia forse un "volere" o un "sentire"?», eccetera.
Quanto a noi, ci limitiamo a obiettare che quando ci po-iiiamo un problema, ce lo poniamo sulla base di un intreccio inestricabile di pensiero ed essere, di res cogitans e res exten-va , e solo con l'astrazione riusciamo a isolare l'una e l'altra. Ma il «guaio» è che le due res, una volta che siano state iso-late, non si ricongiungono più — perché noi stessi glielo ab-biamo impedito. Dunque anche per noi il cogito ergo sum non funziona e le due res non sono altro che due modi di percepire la realtà.
Abbiamo detto che il Discorso del metodo è filosofica-mente un delirio. Perché? Perché, soprattutto, è permeato di soggettività e tutto quanto vi è filosoficamente sostenuto è privo di fondamento o di rigore. Tuttavia proprio la sog-gettività, che ne mina la validità sul piano filosofico e meto-dologico, ne fa d'altra parte il valore. Esso è infatti la storia, di sapore faustiano, della formazione dell'autore, un'auto-biografia spirituale in cui si trovano cose generalmente im-portanti per la formazione filosofica e scientifica, ad esem-pio l'osservazione che si impara principalmente dalla vita e dall'esperienza e non dai libri, per quanto necessari, dal mondo in cui «il senno eterno ha scritto i suoi concetti», co-me dice Campanella, e che, d'altra parte, proprio quando si sono raggiunti i vertici della cultura si scopre, socraticamen-te, la propria ignoranza. In esso sono inoltre intercalate sot-tili osservazioni di tipo moralistico, che ne costituiscono un prezioso arredo. Il risultato è che tutto ciò che in esso è pre-gevole, lo è in quanto riferito al suo autore, ossia a un uomo dotato di uno straordinario potere di conoscere e affetto dal-la nobile passione che ne deriva, la passione della conoscen- za appunto. Come tale, egli è destinato a compiacersi delle sue creature e a cogliere quella soddisfazione, gioia e voluttà che l'esercizio di tale potere procura. Della voluttà di cono-scere, ipostatizzata da Aristotele, e non solo da lui, come ver-tice della vita umana trasfigurata, non si può pensare in ma-niera abbastanza alta: «Nel conoscere», dice Zarathustra, «io sento solo il piacere di generare e di divenire della mia volontà; e se nella mia conoscenza è innocenza, ciò accade perché è in essa volontà di generare».
E l'eroe del racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa non trova più senso nel vivere, una volta soddisfatta la Wissbegierde, una volta esaurita la messe di conoscenza raccolta in gioventù. In conclusione si applica qui di nuovo ciò che Nietzsche, nel-l'attaccare nell'aforisma 13 di Al di là del bene e del male il principio di autoconservazione della sostanza di Spinoza, predica come il vero metodo: l'economia dei principi. Non il metodo conta, non i principi, non i propositi e i fini che ci si propone di conseguire («i metodi vengono dopo»): contano soltanto il naturale potere di conoscere, la passione che ne deriva con le sue vicissitudini, e il compiacimento per le creature da essa generate.
Esattamente lo stesso è da predicare di Spinoza e del proposito espresso all'inizio della sua Emendazione dell'in-telletto. Si tratta di un secondo Discorso del metodo, benché quest'operetta incompiuta sia filosoficamente tutt'altra co-sa, quanto a fondatezza, rispetto al Discorso del metodo, e contenga una teoria della conoscenza, a correzione e inte-grazione di quella lasciata disperatamente aperta da Carte-sio, che, completata dal Trattato breve e dall'Etica, sfida quella, tuttora in auge, della corrispondenza dell'idea all'i-deato. Rileggiamone l'incipit: «Dopo che l'esperienza mi ebbe insegnato che tutte le cose che più frequentemente si incontrano nella vita comune son vane e futili, e quando vi-di che tutto quello che per me era causa o oggetto di timore non aveva in sé niente né di male né di bene se non in quan-to l'animo ne era turbato, decisi infine di cercare se non si
desse qualcosa che fosse un bene vero e capace di comuni-carsi a noi: un bene tale da appagare l'anima da solo, ab-bandonati tutti gli altri; anzi se non si desse qualcosa, tro-va 11(lo e possedendo il quale io godessi in eterno di una conitia e suprema felicità».
Questo qualcosa, questo bene supremo, Spinoza lo trovò o ritenne di trovarlo nell'amor dei intellectualiv, a cui si arri-va ductu rationis, con la guida della ragione. Per fornire a sé e agli altri questa guida, egli scrisse l'Ethica ordine geometri-co demonstrata, il suo potente capolavoro, che ha appunto, come fastigio, l'amor dei intellectualis. Ma era l'amor dei in-tellectualis la continua e suprema, eterna felicità che egli ave-va agognata, di cui aveva sognato? In un senso limitato, umano, molto umano — ossia con discontinuità, alterni e drammatici sviluppi e conquiste — lo era, come vedremo, mentre in senso proprio non lo era affatto. L'eterna felicità è una con tradictio in adjecto, non è cosa per gli uomini, e per capirlo basta il distico di Goethe: «Alles in der Welt ldsst sich ertragen,/Nur nicht eine Reihe von schanen Tagen».
Ma per rendercene chiaramente conto citiamo di nuovo lo Starenfried, il guastafeste Nietzsche: «Una volta i filosofi avevano paura dei sensi». Così comincia quella perfezione che è l'aforisma 372 della Gaia scienza, il quale ha come tito-lo: Perché non siamo idealisti. E così esso continua: «Abbia-mo noi forse — disimparato troppo questa paura? Oggi sia-mo tutti quanti sensisti, noi uomini del presente e dell'avve-nire in filosofia, non secondo la teoria ma secondo la prassi, la pratica... Quelli invece credevano di essere attratti dai sen-si fuori dal loro mondo, il freddo regno delle "idee", verso un'isola pericolosa più a sud, ove, come temevano, le loro virtù filosofiche si sarebbero sciolte come neve al sole. "Ce-ra nelle orecchie" era allora quasi la condizione del filosofa-re; un filosofo autentico non sentiva più la vita, in quanto la vita è musica, negava la musica della vita — è una vecchia su-pyrst i zioi le dei filosofi che ogni musica sia musica di sirene. I lbene, oggi potremmo essere inclini a giudicare esatta- mente in senso contrario (il che in sé potrebbe essere altret-tanto falso): cioè che le idee siano seduttrici peggiori dei sen-si, con tutto il loro aspetto anemico e neppure nonostante questo aspetto — esse hanno sempre vissuto del "sangue" del filosofo, hanno sempre consumato i suoi sensi, anzi, se ci si vuol credere, anche il suo "cuore". Questi vecchi filosofi erano senza cuore: il filosofare fu sempre una specie di vam-pirismo. Non sentite in certe figure, come anche in quella di Spinoza, qualcosa di profondamente enigmatico e sinistro? Non vedete lo spettacolo che si rappresenta qui, il costante impallidire, la desensualizzazione interpretata sempre più idealisticamente? Non avvertite nello sfondo una qualche lunga e occulta succhiatrice di sangue, che comincia con i sensi e che alla fine si ritrova soltanto con, lascia soltanto os-sa e scricchiolii? — voglio dire categorie, formule, parole (giacché, mi si perdoni, ciò che restò di Spinoza, l'amor tellectualis dei, è uno scricchiolio, niente di più! Che cos'è amor, che cosa deus, se manca loro ogni goccia di san-gue?...). In summa: ogni idealismo filosofico è stato finora qualcosa come una malattia, e quando no, come nel caso di Platone, la prudenza di una salute esuberante e pericolosa, la paura di sensi prepotenti, l'accortezza di un socratico ac-corto. Forse semplicemente noi moderni non siamo abba-stanza sani per aver bisogno dell'idealismo di Platone? E non temiamo i sensi perché [...l».
Bene dunque l'«idealismo», quando è «la prudenza di una salute esuberante e pericolosa, la paura di sensi prepo-tenti». Ma quanto all'amor dei intellectualils, esso, come ab-biamo visto, per Nietzsche non è più di uno scricchiolio. Ve-dremo che invece è ben di più, anzi è un'altra cosa. Ma in-tanto esaminiamo più precisamente come la pensa Nietzsche in fatto di passioni.
Alla fine Nietzsche iscrive questo aforisma nel capitolo «Morale come pusillanimità», ed è quest'ultima parola che fa capire che cosa egli intenda veramente, dato che l'ammis-sione della prudenza di una salute esuberante e pericolosa, che egli accetta, non sembra in contrasto con le cose che egli in questo aforisma condanna. Egli, cioè, che contro le astra-zioni diceva di sé: «Io amo il sangue», è contrario alle mora-li che vogliono tenere a freno le passioni quando sono pusil-lanimi e, come vedremo, ipocrite. Dunque non solo Hafis e Goethe si salvano, ma anche gli stoici e Spinoza e gli altri so-stenitori di dette morali, se i loro insegnamenti riescono bensì alla misura, ma non alla pusillanimità e all'ipocrisia. Invece tali morali non si salvano mai, se Nietzsche non cre-de affatto al freno delle passioni, se crede solo e sempre alle passioni senza freni. E così in effetti sembrerebbe, in base a quanto puntualizza in Wagner a Bayreuth 11 e ripete nella Gaia scienza 99, ossia «che la passione è migliore dello stoi-cismo e dell'ipocrisia, che l'essere sinceri, anche nel male, è meglio che perdere se stessi per l'eticità della tradizione, che l'uomo libero può essere tanto buono che cattivo, ma che l'uomo schiavo è un'ignominia della natura e non partecipa a nessuna consolazione celeste o terrena; che infine chiun-que voglia diventare libero lo deve diventare grazie a se stes-so, e che a nessuno la libertà cade in grembo come un dono miracoloso».
Ma è concepibile che un Nietzsche non ammetta alcun freno alle passioni, che le licenzi tutte indiscriminatamente, dando a qualunque di esse licenza di uccidere, cioè di con-trastare e sopprimere le altre con le quali contende, al pari di ciascun'altra, per il potere assoluto, come dice e ripete? No, secondo noi non è concepibile. Non avrebbe senso. Allora dobbiamo dire che qui Nietzsche si è spinto troppo in là, senza freni appunto, che anche a lui avrebbero fatto bene (e non solo in questo caso), in odio alla pusillanimità e all'ipo-crisia, odio che è la chiave di tutta la sua filosofia. Quanto a noi, non possiamo che seguire la plurimillenaria saggezza umana, che esalta le passioni nobili e condanna quelle igno-bili, sempre ammettendo, come Spinoza certamente ammet-te — è questo un suo punto di originalità e di eccellenza— che l'uomo è costituito da passioni e da nient'altro che passioni (affectus), che non vive se non di passioni e che dunque si tratta sempre e solo di sceglierne una o alcune rigettando le altre, con economia di principi e di garanzie.
In conclusione, nel caso di Cartesio e di Spínoza si tratta in realtà di una passione molto particolare, da cui vengono l'impegno e l'affanno di una vita, ma anche la più profonda soddisfazione, gioia, voluttà e realizzazione, sebbene non si possa mai parlare di una suprema e perpetua felicità (Spino-za morì tisico a quarantacinque anni): la passione della cono-.vcenza. Questa e solo questa, con tutti i suoi intrecci invasivi, con le sue sconfitte e le sue vittorie, è anche veramente, per Cartesio, la méthode, e questa e solo questa è, per Spinoza, l'amor dei intellectualis, che dunque non è uno scricchiolio (chiariamo infine), bensì un dramma e un destino di umana grandezza. Con questa passione dominante, alta, potente e munifica, Descartes e Spinoza hanno vissuto non diversa-mente da tutti gli altri uomini, seguendo la propria inclina-zione, in questo caso eccelsa; e questa passione stessa, perché ne vedevano il grande valore, hanno in sostanza insegnato, checché ne abbiano detto come metodo, come Dio e come imperativo per sé e per gli altri, ossia come trasfigura-zione filosofica. Ma gli altri, questi altri, possono accogliere il loro insegnamento soltanto se sono a loro volta partecipi del genio, e difatti lo accoglieranno soltanto coloro che saranno abitati a loro volta, posseduti dalla passione della conoscenza. Dell'amore paterno che portava alle sue teorie, parla lo stesso Cartesio.
Di quello che portava alle sue Spi-noza, parla ancora maliziosamente Nietzsche, alla fine del-l'aforisma 5 di Al di là del bene e del male, ove menziona «quell'abracadabra in forma matematica, con cui Spinoza mascherò e fasciò come con una bronzea corazza la sua filo-sofia — "l'amore della sua saggezza", L.] — per intimorire in tal modo fin dal principio il coraggio dell'attaccante che osasse gettare lo sguardo su questa invincibile vergine e Pal-lade Atena».