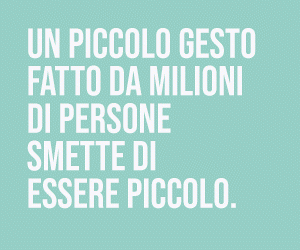Culture
Una filosofa tradita dal cinema: Hannah Arendt di Margarethe von Trotta
di Francesca R. Recchia Luciani
(filosofa dell'università di Bari)
Diffido dei film dedicati ai filosofi. È un'impresa ardua quella di raccontare la filosofia al cinema. Le strade percorribili sono almeno tre: la più impervia mette in scena il pensiero, talvolta in modo inconsapevole, e costruisce un cinema filosofico denso e concettualmente pregnante che instaura un rapporto indissolubile tra immagine e concetto, tra pensato e rappresentato. La seconda, anch'essa complessa e faticosa, si cimenta con l'esposizione di una visione del mondo, è il cinema autoriale, quello che ha segnato la storia della settima arte con indimenticabili opere di concetto, film di pensiero. La terza, la più agevole, racconta in immagini un pensiero e una vita filosofica. Quest'ultima è la strada scelta da Margarethe von Trotta per narrare la vicenda, umana, politica e intellettuale di una pensatrice gigantesca che ha sfidato con una potentissima capacità di comprendere e interpretare le spire velenose dei totalitarismi del Novecento: Hannah Arendt.
Eppure, malgrado la regista decida di percorrere sentieri già battuti (si pensi al Wittgenstein di Jarman, dotato peraltro di ben più acuta forza visionaria), il risultato è alquanto deludente. L'effetto è quello di uno sceneggiato televisivo, nel quale il racconto è affidato totalmente alle parole, in cui le immagini - la vera forza dell'opera filmica - non giocano alcun ruolo, nella scialba rappresentazione della vita di un'insegnante di filosofia decisamente snob. Non c'è traccia in questo film né dell'intelligenza poietica ed ermeneutica di una filosofa eccezionale, né del pathos necessario a coinvolgere lo spettatore nell'impresa altamente emotiva, coraggiosamente abbracciata da Arendt, di attraversare la più grande tragedia del secolo scorso, la Shoah, con una volontà indefessa di comprendere, di afferrare il senso dell'apparentemente insensato, di concepire l'inconcepibile.

Sfugge totalmente a questo racconto la possibilità di spiegare perché, per una filosofa ebrea appassionata e intellettualmente audace, diviene, dinanzi al nazista Eichmann in carne ed ossa, indispensabile comprenderne le ragioni, l'orizzonte di senso inafferrabile all'umana, normale comprensione. L'immagine alla fine consegnataci è quella di una donna molto egocentrica, un'intellettuale arrogante, chiusa dentro le proprie convinzioni, impermeabile alle critiche, indifferente persino alla dura disapprovazione delle persone a lei più vicine. Questa Hannah Arendt cinica e superba non convince delle sue ragioni, la sua altera immagine professorale non suscita simpatia nello spettatore, per lo più disarmato e ignaro, e ne disorienta il giudizio rendendo antipatica e distante una delle più grandi filosofe del secolo scorso.
Film privo di anima, "senza sentimenti" (etichetta affibbiata ad Arendt dai suoi critici), senza spessore né profondità, tutto giocato sul carattere del personaggio cui l'intelligenza e l'eccezionale padronanza del pensiero critico non restituiscono l'umanità dispersa in una raffigurazione tanto patinata quanto inutile. Un racconto che si ferma alla superficie degli eventi e che, pur deliberatamente concentrato su un unico fondamentale episodio della vita di Arendt, vale a dire la sua scelta di seguire il processo di Gerusalemme contro Eichmann e le polemiche pesantissime che seguirono alla sua elaborazione della teoria della "banalità del male" erroneamente scambiata per un'interpretazione giustificazionista, aiuta poco a inquadrare e a penetrare l'intensità dello sguardo politologico e della visione filosofica arendtiana.
Il suo contributo non si è limitato a consentire, per la prima volta nella storia, l'elaborazione del concetto di "crimine contro l'umanità", che ha reso operativa e incisiva l'azione dei tribunali e delle corti internazionali, ma consiste in un ripensamento radicale della politica come forma-base della vita collettiva, come ragione comune che fonda la sfera sociale, come anima di quel che lei stessa ha definito lo "spazio dell'infra", della convivenza civile, della comunità. Una lezione fondamentale e attualissima che, se restituita adeguatamente, avrebbe reso quest'opera preziosa e significativa.
Ora, se questa omissione mutila l'idea che della Arendt può farsi l'ignaro spettatore, il limite maggiore di questo film sta tuttavia nell'essere cinematograficamente piatto, vittima di una banalizzazione del linguaggio delle immagini che tradisce un intento puramente documentario. Il che rende quest'opera un prodotto freddo, un'algida fiction che se non la consegna alla storia del cinema, è inefficace anche nel riprodurre la forza di un'audace interpretazione filosofica del mondo.