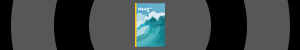Esteri
Abbiamo capito Trump. Ora, dopo un anno della sua presidenza, resta il problema di fermarlo
Ormai Donald Trump, a un anno dal suo insediamento, non è più un enigma da decifrare, né un’anomalia da osservare con curiosità... Il commento

Il commento
Ormai Donald Trump, a un anno dal suo insediamento, non è più un enigma da decifrare, né un’anomalia da osservare con curiosità. È un metodo, un sistema, una costante escalation. Ogni giorno che passa, il presidente americano alza l’asticella della forzatura politica, militare ed economica, spingendosi un po’ più in là rispetto al giorno prima. Non per errore, non per impulsività, ma solo per calcolo.
In questo primo anno di presidenza ne ha dette molte e fatte altrettante. Gli è stato persino riconosciuto, per un momento, il merito di aver forzato la mano (a ragione) sulla questione israelo-palestinese. Una forzatura che, letta col senno di poi, si è rivelata prodromica a tutt’altro: l’idea di una gestione della pace affidata a un club ristretto, discrezionale, su invito della presidenza americana e — dettaglio non marginale — a pagamento, un miliardo per sedersi al tavolo. Autocrati inclusi, purché utili. Più che diplomazia, una concessione privata del potere che va ben oltre la questione israelo-palestinese, come in Venezuela, dove la caduta di Maduro è stata salutata come una liberazione e tutti, a parte Landini, hanno gioito.
Ma al suo posto non è arrivata una transizione democratica, né un percorso verso elezioni libere. È subentrata Rodriguez, braccio destro di Maduro, che Trump ora guiderà a proprio uso e consumo, mentre la leader dell’opposizione — premio Nobel della pace — è stata per ora ignorata. Cambia il volto, resta il controllo.
E soprattutto resta l’interesse americano, che Trump continua a presentare come interesse nazionale, quando sempre più spesso coincide con il proprio. Anche l’economia diventa strumento di pressione politica. I dazi non sono più una misura di tutela industriale (se ma lo fossero stati), ma un’arma di ricatto. Vengono agitati contro alleati europei rei di scelte autonome, mentre sullo sfondo restano dossier inquietanti come quello groenlandese, trattato con la stessa brutalità negoziale di un affare immobiliare. Il messaggio è chiaro: chi non si allinea, paga. A questo punto è evidente che addolcire Trump, come ha fatto l’Europa (ma non la Cina), non serve. Ogni concessione diventa la base per una richiesta successiva, più rigida, più esigente.
La sua politica non conosce il concetto di equilibrio, ma solo quello dell’accumulazione di potere e visibilità. Le vie d’uscita sono poche, forse due. La prima passa dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti e dalla perdita della maggioranza. La seconda — conseguente — è un’azione di impeachment che richiederebbe un atto di responsabilità storica anche da parte di quella destra repubblicana che oggi lo sostiene per calcolo o paura. Sarebbe uno scenario traumatico, ma meno devastante della normalizzazione di questa deriva. Un po’ come accaduto in Francia più volte contro il Front National, anche negli Stati Uniti potrebbe diventare inevitabile un fronte trasversale di forze per salvaguardare il sistema.
Non contro un’idea politica, ma contro un presidente che sta destabilizzando il mondo e, prima ancora, il proprio Paese. E l’Europa? Qui la chiarezza è altrettanto urgente. Non c’è vera unità, ma esistono leader che scelgono apertamente di stare dalla parte di Trump. Anche su questo occorre decidere: i valori comuni non possono essere opzionali. Forse è arrivato il momento di dire che l’Unione Europea non può essere un club a cui si appartiene solo quando conviene. Abbiamo capito Trump. Ora resta il problema di fermarlo. E far finta che non sia necessario è, ormai, la scelta più irresponsabile di tutte.