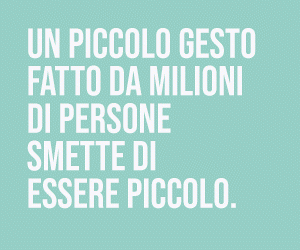Home
Le maschere della Sardegna sotto "La magia delle stelle"




Aperta al Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada, il paesino noto per i tradizionali mamuthones e issohadores, una bella e inusuale mostra
Di Raffaello Carabini
Mamoiada si trova nella parte più interna della Barbagia, proprio al centro della Sardegna, in un territorio in provincia di Nuoro che presenta le tracce di insediamenti umani risalenti fino al neolitico, pietre votive, nuraghe, menhir. Ma Mamoiada è famosa in tutto il mondo per il suo carnevale, manifestazione popolare antichissima, che vede la sfilata di maschere legate ai riti delle stagioni e alla pastorizia.
Si tratta dei “neri” (dal colore delle maschere di legno che portano sul volto) mamuthones con i tipici campanacci e dei “bianchi” issohadores dal rosso corpetto, più lievi e agili. Appaiono ogni anno il 17 gennaio alla festa di Sant’Antonio abate, quando, con l’accensione dei falò propiziatori per una buona annata, ha inizio il carnevale.
Il Museo delle Maschere Mediterranee è una meritoria istituzione del paese, che, oltre a queste, raccoglie altre maschere realizzate in vari periodi in tutto il territorio dell’isola, dai boes e merdules di Ottana ai thurpos di Orotelli, e richiami ai carnevali più significativi delle Alpi e delle penisole iberica e balcanica. Inoltre si è da pochi giorni dotato di un nuovo allestimento della sala multimediale di apertura, denominato Mascherarsi è un destino, che dichiara la particolarità delle maschere locali.
La stessa particolarità che esprime con forza prodigiosa la mostra aperta contemporaneamente e visitabile fino a metà novembre nel Museo della talentuosa fotografa Cristina Biccai. L’idea è che s’homine patit su destinu – “ogni uomo patisce il suo destino” -, viene preso dalla passione di mascherarsi. Perché, come dice lo studioso Bachisio Bandinu, “il mamuthone di Mamoiada non è individuo né un tipo, non appartiene al camuffamento carnevalesco, né alla commedia dell’arte; dietro la maschera non c’è un volto da scoprire, non nasconde la fisionomia o il carattere di una persona”.Come tutte le maschere sarde “è”. Ha valenza in sé; essenziale, rappresentativa e simbolica.
Bene emerge questo valore, quasi assoluto, nelle foto di Biccai, che sono dei ritratti “rinascimentali”, eterni, immersi nella notte e nelle rovine nuragiche e neolitiche. Esito di un’esposizione lunghissima, quasi senza luci artificiali, e di una stampa su tela, che ne rende omogenea ma non piatta la vista, queste immagini sono solide come la terra di Sardegna, dicono come le maschere, quasi consce della gratuità della condizione umana, diventino un’ancora di salvezza, un riparo dagli eventi, un annullamento nella consuetidine che è insieme affermazione di una storia, di una tradizione. Insomma di un’esistenza “altra”.
I mamuthones con i velli scuri addosso, carichi di campanacci, e i boes, simili a loro ma con velli bianchi e maschere bovinomorfe, i mostruosi merdules dai nasi allungati e gli scanzonati ma dominanti issohadores, bianchi in volto come nobili veneziani e rossi nelle giubbe da guardie canadesi, o i ciechi thurpos, con sai neri e facce annerite dal sughero carbonizzato oppure in bianco con i visi nascosti da una fasciatura rossa diventano immoti simboli di forza. Vicine a pietre immemori, dimore artificiali per chi vive nella folla dell’ordalia carnascialesca, e schiacciate dal peso insostenibile di una volta mai celeste sempre ostile, resistono alla minaccia del tempo e alla quotidianità della cronaca. Illusione di perpetuità ed elegia immutabile di un vivere che non merita rimpianto.