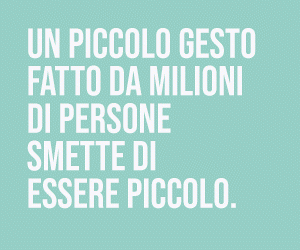Libri & Editori
Leggi l'intervista a Paolo Scaroni

L'intervista a Paolo Scaroni contenuta in 'Manager di famiglia'
Come è iniziato il suo rapporto con il capitalismo familiare?
Ho iniziato a lavorare in Techint, controllata dalla famiglia Rocca, dopo una lunga esperienza in Saint Gobain, dove entrai per caso. Prima di fare 1'MBA lavoravo alla Chevron, che aveva gli uffici a Milano in zona Lorenteggio. Quando stavo per finire l'MBA alla Columbia mandai una lettera alla Saint Gobain, di cui conoscevo l'esistenza perché era nell'ufficio vicino alla Chevron. Casualmente il capo della Saint Gobain USA era appena stato nominato capo dell'Italia. Nell'attesa di trasferirsi per il nuovo incarico, stava ancora a New York e fu semplice incontrarsi li. L'incontro andò bene e lui mi propose di andare a lavorare con lui in Italia.
Nel frattempo la McKinsey, che faceva recruiting in Columbia, mi aveva selezionato.
Preferii andare in McKinsey, ma continuai a tenere i rapporti con lui: dopo un anno di Mckinsey entrai in Saint Gobain, dove restai per dodici anni occupando varie posizioni in vari paesi del mondo dalla Francia al Venezuela.
Quando ero in Venezuela la famiglia Rocca, che conoscevo da tempo, mi chiese di entrare nel consiglio della Techint Venezuela. Dopo qualche tempo la famiglia mi propose di diventare amministratore delegato delle loro attività europee, che allora erano piuttosto ridotte. Decisi di accettare anche perché diventavo azionista, mi diedero delle azioni della loro holding e un pacchetto retributivo con il quale potevo ricevere azioni ogni anno. Passavo così da essere un manager ad essere un manager un po' imprenditore.
Sono entrato in Techint che avevo 36 anni e ci sono rimasto per dodici guidando la crescita europea dell'azienda. Tra le ultime cose che feci, ci fu l'acquisto della SIV dall'EFIM in liquidazione. La PiLldngton, che mi conosceva, mi contattò e propose di comprarla insieme. Così facemmo e io affiancai al mio ruolo di amministratore delegato di Techint, il ruolo di amministratore delegato di SIV.
Dopo due anni e mezzo, la Pilkington offrì di comprare anche il 50% della Techint offrendo un ottimo prezzo, che permise una rilevante plusvalenza.
Dopo sei mesi il chairman della Pilkington, che avevo conosciuto in SIV, chiese di incontrarmi a Milano, mi disse che aveva intenzione di cambiare il CEO e mi propose di prendere il suo posto. Accettai e lasciai la Techint.
Come fu l'esperienza in Techint?
Molto buona e positiva. Avevo rapporti eccezionali con Gianfelice Rocca e avevamo ruoli ben definiti e complementari. Io ero più operativo di quanto fosse Gianfelice, almeno in Italia. Io facevo l'amministratore delegato e lui il presidente, anche se questi ruoli nelle aziende familiari non sono chiaramente definiti come nelle public companies. Avevamo gli uffici uno a fianco all'altro e ci vedevamo tutti i giorni. Siamo coetanei ed amici. Insieme abbiamo: comprato l'Italimpianti, la Dalmine, la SIV, la Pomini Farrell, la CEI, siamo diventati azionisti della Falck, abbiamo comprato una quota importante della Mondadori poi rivenduta; insieme abbiamo fatto "un'ira di Dio di cose".
Negli ultimi due decenni, cambiare gli AD/CEO come "atto strategico" è un trend diffuso e crescente. Data la sua lunga esperienza di amministratore delegato quale opinione si è fatta delle cause?
Negli ultimi decenni i mercati sono diventati globali. Il sistema finanziario americano ed, in parte, quello inglese sono riusciti a creare delle "idrovore" che raccolgono denaro in tutto il mondo, lo prestano o lo investono, purché le aziende seguano le loro regole. Tra queste regole si prevede che l'amministratore delegato sia visibile, parli con frequenza al mercato, parli ai dipendenti, sia carismatico, lo si cambi quando le cose vanno male. In questo modo non c'è più spazio per delle regole locali, si sono create delle regole globali, perché la finanza lo è; così ci è stato "attaccato addosso" un meccanismo che esisteva già negli altri paesi.
Questo dimostra che il mercato si è aperto alle regole internazionali?
Non è che il mercato italiano si sia aperto; il mercato italiano, come tutti i mercati al mondo, compete per i soldi che sono "là", cioè nel sistema finanziario anglosassone. Può anche darsi che i soldi che le imprese italiane ricevono dai grandi fondi di investimento siano risparmi di italiani, ma sono transitati dal quel sistema finanziario e quindi impongono quel tipo di regole.
Cambiare un AD/CEO in un'azienda familiare è diverso rispetto a un'azienda ad azionariato diffuso?
Con i nuovi concetti di Corporate Governance, la presenza di amministratori indipendenti, una Consob che controlla, etc, la differenza tra un'azienda a proprietà diffusa e una familiare, entrambe quotate, si è attenuata.
L'unica vera differenza, che in qualche misura permane, è che l'amministratore delegato della public company ha un solo obiettivo nella vita la crescita a lungo termine del valore del suo titolo. Questo è l'unico meccanismo di valutazione della tua performance come AD: se dopo cinque anni da quando sei arrivato, il titolo della tua azienda, che valeva 10 come gli altri, vale 15 e gli altri 12: sei stato bravo. Se vale 12, mentre gli altri valgono 15, sei stato un fesso. In un'azienda a controllo familiare, l'amministratore delegato, quando è un membro della famiglia, può in alcuni casi anche non dare grande importanza al valore del titolo. Lui pure ha un interesse che l'azienda sia valutata di più perché ciò gli consente di fare acquisizioni, raccogliere denaro etc, ma, alla fine, non deve vendere o comprare azioni facendo un capital gain nel medio termine. Da questo punto di vista, io sono riluttante ad investire i miei soldi in un'azienda dove l'amministratore delegato ha il 51% del capitale, perché non sono sicuro abbia come primo obiettivo quello di far salire il valore del titolo.
Avrebbe lo stesso dubbio con un amministratore delegato non della famiglia, ma scelto da una famiglia nella sua qualità di azionista di maggioranza?
Già meglio.
Come va motivato e retribuito un AD/CEO? Quale è lo stimolo maggiore per un AD/CEO di successo? l'ambizione? il raggiungere una posizione ambita? il potere? il compenso?
Un po' la somma di tutte queste cose, come in tutti i mestieri. Una professione si fa perché si fanno cose interessanti, si ha visibilità, si cresce professionalmente, si guadagna bene, si hanno colleghi stimolanti, si hanno clienti con cui si lavora bene. Tutte le cose, insomma, vanno insieme. Quello che è certamente vero è che negli ultimi vent'anni le retribuzioni dei CEO delle grandi società in Italia, in Europa e nel mondo sono state molto più alte che nei vent'anni precedenti. Io, da parte mia, ne ho beneficiato avendo fatto l'amministratore delegato per diciotto anni nel periodo storico in cui il mestiere è stato, probabilmente, meglio pagato. Quando ero amministratore delegato di Techint ero pagato bene, più di molti altri, ma in media si guadagnava meno. Gli stipendi, in Italia, sono decollati a metà degli anni novanta. Negli Stati Uniti erano partiti prima, il che è logico perché è uno dei fenomeni generati dalle regole della finanza che dall'America si sono diffuse nel mondo.
Chi deve scegliere l'AD/CEO?
Lo coopta, per definizione, il consiglio di amministrazione e poi lo conferma l'assemblea. Questo non deve essere solo un processo formale, deve essere la base del processo di scelta.
Quale deve essere il ruolo del predecessore nella scelta del successore?
Penso che chiunque guidi un'azienda come amministratore delegato, deve occuparsi del succession planning delle prime posizioni manageriali, compresa la sua. Quando arriva il momento della successione, il CEO presenta il suo candidato interno, dopodiché, in un processo normale, si mette questo candidato a confronto con dei candidati esterni. Questo processo normale non è sempre seguito in Italia, tendiamo anche in questo ambito a voler essere un po' diversi. Il processo di confronto fra potenziali successori interni ed esterni deve essere ordinato, organizzato e supportato da un cacciatore di teste. È buona norma nominare, se non esiste già, un nomination committee che ha la responsabilità di governare il processo e di dare una prima indicazione al CdA. In questo modo è possibile fare una scelta razionale. Mi sembra giusto che chi sta dentro l'azienda prepari una successione interna; se poi è perdente va bene lo stesso: l'importante è averla preparata. In questo modo, chi lavora all'interno dell'azienda sa che, se lavora bene, non avrà preclusa l'opportunità di giocarsi le sue possibilità in un processo organizzato, chiaro e razionale.
Quale ruolo hanno le società di executive search?
Organizzano questa ultima fase. Organizzano il processo di individuazione delle caratteristiche che deve avere il nuovo amministratore delegato, quali esperienze deve aver vissuto, quale background deve avere. Si presentano poi ai decisori, sottoponendo loro una lista di candidati sia interni che esterni.
Come e quando parte il processo?
Non c'è un unico caso, dipende dalle circostanze. Può essere un atto di sfiducia verso l'attuale amministratore, come può essere che l'amministratore stesso dichiari di voler lasciare entro un determinato orizzonte temporale.
In genere si nomina, se non esiste già, un nomination committee; questo è guidato da una persona, che non è né il chairman né il CEO. Questo comitato svolge buona parte del lavoro e sovrintende l'intero processo, spesso affiancato dalla società di executive search. Quando il processo lo si struttura e non lo si fa guidare da una sola persona, si abbassa drasticamente la probabilità di fare errori, senza comunque annullarla.
Come si crea e fa crescere un CEO dall'interno?
Vi racconto la storia di Fulvio Conti all'ENEL, perché credo possa spiegare bene come ogni tanto accadono queste cose. Un giorno ero nel mio ufficio all'ENEL e ricevo una telefonata di Berlusconi, a quell'epoca Presidente del Consiglio, il quale mi chiese: "dott. Scaroni, darebbe la sua disponibilità per fare l'AD dell'ENI?", risposi di si. "Sarebbe in grado - continuò Berlusconi - di indicare un possibile candidato al suo attuale posto?" "Ci metterei Fulvio Conti che è l'attuale CFO" risposi. Pensai a lui, oltre che per le grandi doti manageriali, perché bisognava portare a termine l'ultima tranche della privatizzazione ed era necessario continuare sulla strada di focalizzazione che avevamo intrapreso.
Berlusconi non lo aveva mai visto in vita sua, ma accettò la mia idea. "Cosa faccio - chiesi - glielo dico?". "Glielo dica" mi rispose. A quel punto scesi dalla palazzina dove si trovava il mio ufficio per andare in quella di fianco dove si trovava Fulvio. Lui era davanti ad una di quelle ciabatte per la viva voce, e stava facendo la conference cali trimestrale con gli analisti. Entrai, presi un pezzo di carta e ci scrissi sopra: sei il futuro amministratore delegato dell'ENEL: poi me ne andai. Alla fine della conference cali lui venne da me, parlammo a lungo del futuro, dell'azienda, del suo ruolo; poi si avviò il processo strutturato interno ed esterno di cui abbiamo parlato e qualche mese dopo lui diventò l'amministratore delegato dell'ENEL.
Spesso sento parlare del peso ingombrante della politica e parlo con persone che si immagino ovattate stanze dei bottoni con gente intenta a macchinare chissà che: Fulvio fu nominato senza che un politico lo conoscesse e tanto meno lo sponsorizzasse.
Lei aveva il nome pronto, come si era preparato?
Io non solo avevo il nome, ma l'avevo formalizzato. Lo stesso è successo in ENI, dove utilizzavo un programma, Athena, su cui con Salvatore Sardo, responsabile HR, valutavamo le 150 posizioni di vertice. Ogni anno, l'ultima posizione ad essere analizzata era la mia e, ogni anno, dicevo, l'unico mio successore possibile è Claudio Descalzi. Questo non significa che sono stato io a nominarlo, il governo, nella sua qualità di azionista, avrebbe potuto scegliere chi voleva. Io mi sentivo responsabile nei confronti del consiglio e degli azionisti e la mia responsabilità era avere un nome interno credibile e preparato nel tempo.
Cosa faceva sulle 150 persone?
La domanda da porsi è chi metterei domani in questa posizione. Ci può essere una persona pronta, il signor Rossi, che domani mattina può essere un valido manager in quel ruolo. In questo caso il dilemma è: se può andare domani mattina, non c'è il rischio che si frustri nel suo ruolo attuale?
Può esserci, invece, il caso in cui, il signor Rossi per ricoprire quella posizione deve ancora crescere per tre anni. A questo punto bisogna chiedersi: cosa deve fare il sig. Rossi nei prossimi tre anni per acquisire quelle conoscenze e competenze necessarie a renderlo pronto.
Il succession planning deve essere il punto di partenza per costruire i percorsi formativi delle persone in azienda. È su questa base che ha senso mandare un manager alcuni anni all'estero per fargli apprendere diverse culture, o in una funzione specifica perché approfondisca alcune conoscenze, o a capo di un'unità per vedere come si comporta in un ruolo da leader etc.
Ho sempre fatto quest'analisi in prima persona per i ruoli più importanti investendo alcuni giorni all'anno e ho sempre costruito un sistema che assicurasse che per le altre posizioni venisse fatto a regola d'arte dai manager responsabili e dalle risorse umane.
Come faceva a valutarle?
Oltre all'attività di valutazione annuale, li vedevo in diretta a lavorare sul campo. Inoltre, prestavo molta attenzione alla reputazione che le persone si facevano in azienda, dove vale il detto: vox populi vox dei. Quando uno è apprezzato dai suoi collaboratori, dai colleghi di altre funzioni e dai capi, di solito è un indicatore rilevante.
Quando si inizia a crescere un potenziale futuro Amministrator Delegato?
From day one. È necessario perché uno può morire, andare da un'altra parte, essere cacciato ed è un processo che richiede tempo. Personalmente iniziavo dai miei primi riporti e cercavo di farmi un'idea sui secondi riporti.
Quando si mette in piedi un processo strutturato che funziona, uno si costringe a farlo. L'amministratore delegato non deve entrare in azienda ogni giorno chiedendosi chi sarà il suo successore, ha certamente ben altro a cui pensare; ma se ha in agenda che il giorno X si riunisce con il direttore del personale e ha davanti a sé un computer con tutte le posizioni da analizzare alla fine lo fa. È costretto a farlo, per effetto del processo che egli stesso ha messo in piedi.
Questo approccio al succession planning potrebbe essere applicato anche nel caso di un imprenditore, che sia anche anuninistratore delegato della sua azienda?
Il problema della successione generazionale è ancora diverso.
Tra le varie cose che ho fatto nella mia vita, ho fatto anche il presidente degli industriali di Venezia, in quell'associazione il tema della successione appassiona molto. Avevo, allora, trovato un libro pubblicato nel 1885 a Leeds in cui si parlava della successione nelle aziende familiari; lo usavo per dimostrare che il problema era stato affrontato molto tempo prima dagli inglesi, che hanno avuto la rivoluzione industriale duecento anni prima di noi.
Il "sugo del brodo" era che la successione familiare non c'era, salvo rarissime eccezioni.
L'imprenditore quando compie cinquant'anni comincia a pensare come far evolvere l'azienda in un'istituzione, cioè qualcosa che va avanti senza di lui. È da questa visione che può nascere l'idea della quotazione, di far entrare nuovi azionisti, ad esempio fondi di private equity, di creare consigli di amministrazione più strutturati con amministratori indipendenti.
Facciamo il caso di un'azienda che produce 100 di utile, ed è un'azienda familiare gestita dal sig. Rossi, l'azienda varrà, poniamo, 1.000. Ora pensiamo alla stessa azienda gestita, però, dal sig. Bianchi, che è un manager: Bianchi sarà meno in gamba di Rossi,
quindi produrrà solo 70 di utile, ma l'azienda varrà 1.400. Perché? Quando uno compra l'azienda gestita da Bianchi, si compra anche Bianchi, quando si compra l'azienda gestita da Rossi, Rossi va via e con lui va via il goodwill. La morale è che: uno crea valore se non c'è bisogno di lui, perché se c'è bisogno di lui, che valore ha creato? Quando esce il valore non c'è più. Gli imprenditori che vogliono far evolvere la loro azienda in un'istituzione devono lavorare per smettere di essere indispensabili.
Quindi, la norma per chi è stato un imprenditore di successo è cercare di costruire delle condizioni per cui la successione familiare non ci sia, non perché ci sia. Se poi, ha un figlio che è il più gran fuoriclasse del mondo, appassionato al mestiere, fuori da comune: allora uno può dire: proviamo il passaggio generazionale.
La controprova di questo ragionamento è che tutte le aziende che conosciamo sono nate familiari, anche la Coca Cola, l'IBM, la Microsoft, ma ora non lo sono più; perché? Perché la parte del mondo industriale che questi problemi se li è posti duecento anni fa è arrivata alla conclusione che chi vuole rimanere ricco smonta l'azienda familiare.
Quindi è sempre meglio che il CEO sia non familiare?
Uno dovrebbe partire dicendo: sono stato un imprenditore di grande successo, voglio che la mia creazione diventi un'istituzione, qualcosa, cioè, che viva a prescindere da me e dalla mia famiglia. La famiglia resta come azionista.
Cosa deve fare una famiglia per essere un buon azionista?
Come prima cosa deve prendere un amministratore delegato bravissimo. Secondo: contribuire a scegliere un CFO bravissimo e le altre figure chiave. Terzo: formare un board, in cui siede il capofamiglia, naturalmente, l'amministratore delegato, nessuno o pochissimi membri della famiglia, e amministratori indipendenti con idee e visioni forti senza timori reverenziali verso la famiglia, con uno spirito libero, che esprimano opinioni strutturate ma non vincolate a schemi precostituiti e che si impegnino a portare un contributo concreto.
Il passaggio logico successivo è, di solito, chiedersi perché uno dovrebbe possedere il 100% di quest'azienda e non magari, il 30% e poter diversificare parte del patrimonio in investimenti più liquidi. Nel momento in cui la famiglia decide di fare solo più l'azionista, scendere nel capitale, cercare nuovi soci, quotarsi è immediato. Questo spesso avviene in occasione di operazioni straordinarie, ad esempio acquisizioni che impongono ingenti investimenti. È così che sono nate le public company, mica le imprese nascono "public", anzi, nascono "very private": questo è il processo, non è possibile succeda il contrario.
Nei casi in cui la famiglia non sia un buon azionista semplicemente perde, prima, il controllo dell'azienda e, poi, perde la ricchezza. Questo mi sembra giusto; sono della teoria che i ricchi devono diventare poveri e i poveri devono diventare ricchi. Se non creiamo un ascensore sociale, il sistema capitalistico diventa uno dei sistemi più iniqui che ci siano e come iniquo verrà spazzato via. In quest'ottica focalizzata sull'analisi economica non ho particolare simpatia per chi ha ereditato ed ho, invece, grande simpatia per chi si è creato la sua fortuna.
Nel nostro Paese esiste poi un'ulteriore specificità di questo processo: una famiglia che vende significa una multinazionale straniera che compra. Questo crea un sentimento di perdita di una certa sovranità nazionale. La verità è che succede perché prima l'imprenditore non ha creato l'istituzione; è rimasto attaccato al 51%, non ha fatto acquisizioni, non è cresciuto. In Francia, ad esempio, in un settore dove il Made in Italy ha avuto qualcosa da dire, Arnault e Pinault hanno insegnato come si cresce creando grandi gruppi multinazionali in settori in cui noi siamo più forti.
La prima regola per una famiglia che vuole essere un buon azionista è prendere un amministratore delegato bravissimo. Quali caratteristiche deve avere? Sono diverse da quelle di un AD/CEO di un'azienda ad azionariato diffuso?
Non è possibile generalizzare, ogni azienda ed ogni famiglia hanno la loro storia e le loro peculiarità. Nel mio caso, conoscevo la famiglia Rocca da sempre, da ben prima che lavorassi con loro, da giovani abbiamo abitato nella stessa casa, avevamo dei rapporti per cui ero quasi come un fratello.
Gli azionisti erano il padre, la sorella gemella del padre, più circa un centinaio di altri azionisti. Quindi, la famiglia aveva la maggioranza e la responsabilità ma doveva render conto a un gran numero di azionisti di minoranza.
I tre ragazzi, i figli di Roberto, avevano circa la mia età e non si sentivano azionisti.
Il caso di un azionista di maggioranza che ha una responsabilità verso gli azionisti di minoranza, esula dalla logica della public company. Quale rapporto si era instaurato tra l'azionista di maggioranza e gli altri azionisti?
Ho vissuto questa situazioni in due casi molto diversi: prima con la famiglia Rocca e poi, nei casi ENEL ed ENI, con il governo.
Per quanto riguarda la Techint, che non era una public company, Roberto Rocca prendeva le decisioni in modo estremamente professionale e per nulla familistico. Lo faceva per mentalità e cultura, ma certamente anche per la responsabilità che sentiva verso gli azionisti di minoranza. Le cose poi sono andate sempre così bene che era naturale per gli azionisti di minoranza essere più che soddisfatti.
Nella mia esperienza all'ENEL ed all'ENI, i vari governi di destra e di sinistra che si sono succeduti sono sempre stati estremamente rispettosi del mercato e delle sue regole, quindi non hanno mai deciso nulla sul piano operativo. Il ruolo è sempre stato quello dell'azionista di riferimento: decidere le nomine al momento dell'assemblea. Come è logico e naturale che sia: ogni tre anni gli azionisti valutano e decidono sul management ed in questo processo l'azionista più grande ha più peso. Nel mio caso, mai una volta in dodici anni, ho avuto input, sollecitazioni o tentativi di incidere su qualche decisione che riguardasse l'operatività aziendale; salvo quel tipo di sollecitazione che avrei ricevuto anche fossi stato alla FIAT o in un'altra grande azienda e cioè l'ambito sociale come ad esempio: la chiusura degli stabilimenti. In questo caso, la sollecitazione era fatta nel ruolo politico del governo e non nel ruolo di azionista di riferimento, e ne è prova il fatto che lo stesso tipo di sollecitazione viene fatta anche ad imprese in cui il governo non è azionista.
Nel momento della quotazione la famiglia azionista ha di solito una visione di lungo termine, come va coniugata con le possibili aspettative di breve termine del mercato?
Questo lo raccontano gli imprenditori, ma non è vero. Nelle public company, gli investitori fanno gli stessi ragionamenti che farebbe una famiglia: anche loro sono interessati al lungo termine, voglio sapere quanto si sta investendo in ricerca e sviluppo, etc. Non è che le aziende familiari abbiano una visione più a lungo termine di una multinazionale ad azionariato diffuso. In generale direi proprio di no.
Quale deve essere il rapporto del CEO con i familiari?
Il mio caso con la famiglia Rocca è particolare: io ho conosciuto la famiglia ben prima di andare in Techint. Rincontrai dopo la Bocconi, Agostino Rocca quando avevo ventisei anni, entrambi iniziavamo a lavorare in McKinsey. Cercavo casa a Milano e lui mi affittò un appartamento vicino al suo.
Come si cambia/evolve un'azienda che ha un forte DNA?
Le cose sono molto semplici. La differenza tra il manager e il professional è che il professional fa, il manager fa fare. Un avvocato, ad esempio, deve fare; un amministratore delegato fa fare tutto agli altri. Le caratteristiche che bisogna avere nei due ruoli sono completamente diverse.
Primo, chi deve far fare deve avere una strategia semplice delle cose che vuole; la deve poter spiegare in un minuto, se ci deve mettere un quarto d'ora è già sbagliata. La deve saper spiegare a sua moglie in modo semplice.
Secondo, intorno a questa strategia deve coagulare il consenso della macchina organizzativa. Senza non va da nessuna parte: la gente di livello non lavora perché gli dai ordini, lavora perché l'hai convinta.
Terzo, devi scegliere le persone assicurandoti che non si creino attriti tra loro, ma che lavorino con sufficiente armonia, che non creino cordate o parrocchie, che siano tutti motivati. Tutti devono avere le idee chiare sulla strategia aziendale da perseguire e su quel pezzetto che devono fare loro per eseguire la strategia. In ENI, il mio sogno era che il più giovane ingegnere impiegato nella nostra filiale in Angola conoscesse la strategia dell'azienda e sapesse come lui doveva fare l'ingegnere per dare il suo contributo alla strategia complessiva
Questo è un lavoro di maieutica, di convincimento, di comunicazione, di scelta, di motivazione e di coordinamento delle persone. Quindi non è che uno deve essere intelligente, per assurdo può anche non esserlo molto, ma deve avere queste capacità di gestione della macchina organizzativa
Come si crea la strategia?
Uno deve avere quel minimo di pazienza per conoscere il mestiere e per farsi le proprie idee. Naturalmente porta con sè le sue esperienze ed i suoi pensieri, che lo aiutano a leggere la realtà che osserva Si tratta, poi, di disegnare una strategia in tempi relativamente brevi, due/tre mesi, di essere in grado di spiegarla in quattro e quattr'otto, di ripeterla ossessivamente, e di spezzettarla per dare a ciascuno la sua fetta all'interno della strategia generale.
Cosa si fa in quei due/tre mesi?
Uno studia, si fa spiegare, si fa le sue idee. Spesso si ragiona per analogie. Quando poi uno ha avuto la possibilità di lavorare M McKinsey, ha acquisito sin da giovane una notevole capacità di analisi, strutturazione di problemi complessi e problem solving. Conta molto l'esperienza e le cose che si sono fatte nella vita.
Si fanno interviste internamente, scendendo di un paio di livelli nell'organizzazione. Magari in qualche riunione si trova qualcuno più junior che ha qualcosa di interessante da dire. Si possono usare dei consulenti per comprendere meglio alcuni aspetti.
Nella sua storia come lo ha fatto?
Ogni capitolo fa storia a sé. In Techint il "name of the game" è stato: creiamo una gamba europea. Nel 1985 la Techint era sconosciuta in Italia, era concentrata in Sud America. Noi siamo partiti dalla Techint spa, una piccola società di ingegneria, per fare un programma di crescita in Europa. Io fui assunto per quello, ma non decisi io il piano. Fu quello l'inizio del percorso che ha fatto di Techint quello che vediamo oggi in Europa.
Il caso Pilkington era, invece, un turnaround ed io fui scelto perché mi avevano visto all'opera in SN, un'azienda vetraria che andava molto male di cui Pilkington divenne socia.
L'ENEL è il caso più singolare: in quei tre anni mi sembra di aver fatto tutto giusto, e fare tutto giusto non capita praticamente mai; almeno a me non è mai capitato tranne nel caso di quei tre anni. Tutto è culminato con la vendita di Wmd. Il mercato me l'ha riconosciuto: sono entrato che il titolo valeva meno di 5,E e sono uscito che ne valeva 8E. Ho avuto una strategia molto semplice: volevo riportare l'ENEL a fare il suo mestiere e cioè l'elettricità, tutte le altre attività che non erano core, dovevano essere cedute. Ad esempio, quando arrivai l'ENEL aveva sparse per l'Italia mille persone che facevano i cedolini paghe; era stata creata una società che faceva cedolini paghe per ENEL e per terzi. C'erano altri casi di questo tipo. Il risultato era un disastro: i cedolini paghe costavano 100 e li vendevi a 18 per rispettare il mercato; inoltre, una struttura interna è la negazione di chi va a vendere sul mercato. Decisi che preferivo avere duecento persone che lavoravano e ottocento esuberi ma non mi sarei messo a fare attività imprenditoriali in settori fuori dal mio per dar lavoro alla gente che avevo. Preferivo, quindi, dedicare il mio tempo ad ottimizzare la dimensione della forza lavoro, ma non inventarmi un mestiere nuovo, che l'azienda non sapeva fare e non aveva mai fatto.
L'ENI andava molto bene quando sono arrivato, si trattava, e non era facile, di cercare di fare ancora meglio. Nei miei nove anni il patrimonio netto è raddoppiato e nel frattempo l'azienda ha generato cassa per distribuire 28 miliardi di dividendi. Posso essere stato fortunato, può essere stato il prezzo del petrolio, etc; mediamente credo, comunque, di aver fatto piuttosto bene.
Quale ruolo deve avere l'amministratore delegato e quale il presidente?
Partiamo dal presidente. Il presidente può essere di tanti tipi, ma è anche necessario capire che l'ordinamento italiano si basa sul principio del presidente non esecutivo. Il presidente, per esempio, dell'ENEL non è il presidente dell'ENEL, è il presidente del consiglio di amministrazione dell'ENEL il suo compito è gestire il consiglio di amministrazione. Quindi non deve fare altro, e già così ha un compito delicato e complesso.
L'amministratore delegato deve gestire la società nel limite amplio delle deleghe che ha ricevuto e rispondere al consiglio, presieduto dal presidente della società.
Il Chairman di Pilkington, quando arrivai, mi disse: "Here at Pilkington the chairman runs the board and the CEO runs the company"; in questo modo mi fu chiaro che non dovevo interferire nella sua gestione del Consiglio di amministrazione.
Quando in azienda le cose vanno bene fare il presidente non esecutivo richiede due giorni la settimana. In casi di crisi è di solito richiesto un impegno diverso sia in termini di tempo che di livello di intervento. Sono, però, casi particolari e, sperabilmente, passeggeri; al di fuori di questi, un presidente non esecutivo che si presenta in azienda cinque o sei giorni alla settimana finisce per pestare i piedi all'amministratore delegato, per generare dubbi sui ruoli e per confondere il management.
Per spiegare la differenza dei ruoli tra presidente non esecutivo e l'amministratore delegato in modo inusuale, Vi racconto la storia del mio barbiere a cui sono molto affezionato. Quando vivevo in Inghilterra, addirittura aspettavo di tornare a Milano per tagliarmi i capelli. Quindi possiamo concludere che, senza dubbio, io sono molto legato al mio bar-, biere. Lo voglio per me una volta al mese; se lo avessi che mi tagliuzza i capelli tutti i giorni lo odierei. Credo che lo stesso si possa dire del rapporto tra presidente non esecutivo ed amministratore delegato.
Il nostro ordinamento ha preso ispirazione da quello inglese. Nella mia esperienza inglese alla Pilkington, il presidente non aveva neppure un ufficio alla Pilkington e quando veniva, usava la sala riunioni. Il presidente della BP va in ufficio due giorni la settimana. Nel caso in cui un presidente faccia il contrario, non fa meglio il presidente, lo fa magari per più ore, ma peggio e rischia di fare danni.
Questo deriva anche dall'ordinamento cui ci siamo ispirati, se avessimo scelto l'impostazione all'americana e alla francese dove è previsto il P.- D.G., il presidente e aiuministratore delegato, avremo un sistema diverso; non so dire se migliore o peggiore. Avendo scelto l'impostazione generale inglese, dobbiamo rispettarne la logica il presidente è presidente del consiglio di amministrazione non della società. Fare il presidente è un lavoro complesso e delicato, quando poi le cose vanno male diventa anche un lavoro che assorbe molte energie e tempo. La più importante caratteristica di un presidente deve essere l'autorevolezza, le parole del presidente in consiglio devono essere come pietre, quando uno parla e dice sempre solo cose giuste, dopo un po' tutti tendono ad ascoltare con grande attenzione la sua opinione.
Un Imprenditore o il capo di una Famiglia Imprenditoriale Le chiede un consiglio per scegliere bene un Amministratore Delegato. Quale consiglio gli dà?
È un tema che ho affrontato tante volte. La prima domanda che faccio è: tu cosa fai adesso? "il capo azienda". Bene, io ti trovo un amministratore delegato, tu cosa fai? Se la risposta è "vado alle Bahamas", fantastico; ma se mi dice "vado in ufficio tutti i giorni", allora gli faccio notare che lui non cerca un amministratore delegato, cerca un assistente. Quindi la prima condizione da chiarire è: cosa farà l'imprenditore? Nel caso lo scenario sia "andare alle Bahamas" allora bisogna trovare un capo azienda vero, che sia una persona affidabile
con l'autorevolezza e l'autorità di sostituire l'imprenditore. Questo amministratore delegato non sarà mai bravo come l'imprenditore, perché l'imprenditore è il più bravo di tutti per definizione, lui ha pensato, creato e gestito l'azienda; ma sarà la prova che l'azienda può evolvere in un'istituzione che sopravvivrà al fondatore.
In questo contesto, l'imprenditore e i suoi successori possono andare in azienda qualche volta al mese.
Un giovane e bravo manager a cui lei è molto affezionato sta per andare a lavorare in un'azienda familiare, quale consiglio gli dà?
Lo considero un errore se la famiglia si occupa dell'azienda. Primo, uno deve avere possibilità di carriera infinite, se il capo azienda deve essere uno di famiglia, e non vuole sposare la figlia del padrone, non è l'azienda giusta in cui esprimere il proprio talento. Secondo, in azienda è particolarmente demotivante avere figli, nipoti, cugini che fanno più carriera di te solo perché sono parenti. Terzo, le aziende familiari, specie in Italia, non arricchiscono il tuo curriculum vitae; è molto meglio aver lavorato in Microsoft e in Google rispetto ad averlo fatto alla Trampolini srl e alla Giovannetti & C.
Questo vale specialmente all'inizio della carriera lavorativa, che mette dei pilastri nel tuo curriculum.
Credo che la costruzione del curriculum sia un elemento chiave di chi vuole fare un mestiere manageriale, perché in questo mestiere si deve mettere in conto di poter perdere in qualsiasi momento il posto di lavoro, perché il capo lo caccia, perché l'azienda va male, per una ragione qualsiasi. Nel caso in cui uno abbia un curriculum vitae ben costruito, gli sarà relativamente facile trovare un altro lavoro, nel caso, invece, in cui il curriculum vitae non sia ben costruito, gli sarà molto difficile trovare un nuovo lavoro.
Quale consiglio dà ad un giovane membro di una famiglia imprenditoriale che vuole continuare l'attività di famiglia?
L'unico modo in cui una successione familiare può aver senso è se il giovane molla completamente gli ormeggi dalla famiglia, separandosene per davvero; sapendo che non tornerà o che forse tornerà se con il tempo avrà avuto successo in quello che ha deciso di intraprendere e, a quel punto, il padre, ormai stanco, lo avrà richiamato implorandolo di tornare.
I casi in cui si prendono i figli e li si mandano a fare un po' di esperienza, in una grande società di consulenza o in una banca d'affari, non hanno speranza. Si perde l'essenza dell'esperienza che è avere una spinta a far carriera, a voler aver successo. Il giovane che passa qualche anno in consulenza o in banca non combina niente; aspetta di finire il periodo come se fosse uno stage. Intorno a lui ci sono altri giovani per cui quel lavoro è la vita, che devono essere più bravi dei loro colleghi, dimostrare di meritare il prossimo passaggio di carriera, prendere il bonus annuale per ripagare parte del debito contratto per fare l'università.
Il giovane di una famiglia imprenditoriale deve davvero mollare gli ormeggi. Il padre deve dire al figlio: qui non ci metterai mai piede, vai pure dove vuoi; se poi sette anni dopo il giovane è stato un fulmine ed ha fatto benissimo, sarà il padre, a quel punto stanco ed acciaccato, che lo implorerà di tornare. È l'unico tipo di successione che può, davvero, funzionare.