Culture
"Barbari & digitali" la visione di Giampiero Beltotto
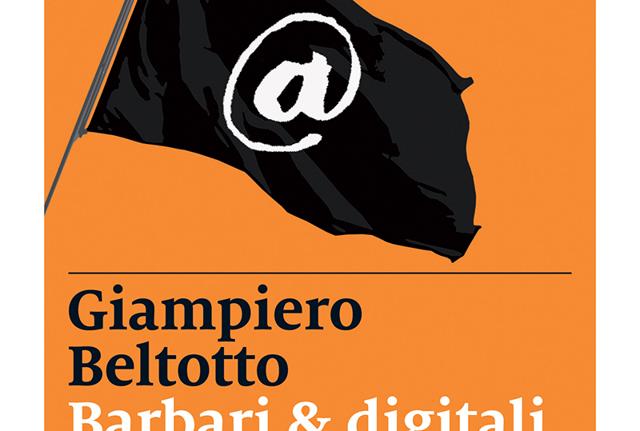
Giampiero Beltotto arriva in libreria con "Barbari & digitali" - cronache dal fronte di una guerra in corso - Tra vita vissuta e cronaca sociale, un appello a non smarrire la propria umanità, esercitando la memoria personale e collettiva.
Siamo immersi in un «tutto digitale». Qualsiasi impresa sembra alla portata di chiunque: il mondo ci offre la facilità come segno distintivo del consumo digitale. Ma siamo ancora in grado di spiegarci le trasformazioni che stiamo vivendo? Possediamo una memoria capace di risalire alle origini di quanto accade oggi?
In queste pagine Giampiero Beltotto, uomo di comunicazione, pone con forza la necessità di riflettere sulle forme del nostro vivere quotidiano per non lasciarsi sopraffare da quella che definisce una cultura «barbara», cioè «di altra stirpe», «che ha trovato nel digitale uno strumento e un varco». La sfida - sostiene Beltotto - «non consiste nell’aprire una stagione di neoluddismo per distruggere gli strumenti del digitale, così come negli anni settanta non si trattava di bruciare le fabbriche perché avevamo scoperto che la cultura fordista spazzava via la sapienza contadina per edificare il “tutto fabbrica”».

Bisogna, invece, attrezzarsi per tornare a «vivere in un mondo a misura di ciò per cui siamo nati, la bellezza». Da qui prende avvio un percorso, personale e sociale insieme, che dal ’68 conduce alla Silicon Valley. Molti i temi affrontati: la tirannia del «politicamente corretto», che tende ad assuefarci all’idea che il pensiero unico sia anche l’unico possibile; la necessità di una classe dirigente e di una scuola - il liceo classico - che serva a formarla; la messa in discussione dell’attuale sistema di selezione e diffusione delle notizie; il rapporto con il cibo e il modo di concepire la guerra. Il filo ideale del ragionamento è sorretto e accompagnato dalla rapsodia dei ricordi: la passione per il giornalismo e il grande cinema, un mondo non ossessionato dall’horror vacui, i maestri e i testi di un percorso formativo imperniato sulla vocazione sociale al Bello.
Oggi come ieri, infatti, è il Bello la forma di resistenza da opporre alla nuova barbarie, dove «barbaro» è tutto ciò che cerca di farci dimenticare che l’uomo è figlio innanzitutto di quella scintilla divina che lo rende unico e irripetibile.
Giampiero Beltotto milita da decenni nella comunicazione nazionale. Si divide per lavoro tra Venezia, Roma e Milano. Varie pagine di questo libro sono state scritte su un tablet, a cui è molto grato. Per Marsilio ha pubblicato Silenzio amico (2012, due edizioni). Altri suoi titoli: Ho intervistato il silenzio (Città Armoniosa 1979), Onorevole Galateo (Terra Ferma 2001) e, con Giancarlo Giojelli, I nuovi poveri (Piemme 2007) e Farmacopoli (Piemme 2008).
«Con queste pagine vorrei dare un mio personale contributo a vivere in un mondo a misura di ciò per cui siamo nati, la bellezza. Lungi da me suggerire un programma di resistenza luddista agli utilissimi strumenti del digitale. Sommessamente, mi piacerebbe che alla luce di questo libro qualcuno ricominciasse ad alzare gli occhi al cielo, cercando di non rimanere con un pugno di fango tra le mani». Giampiero Beltotto
Come anticipazione del bel libro di Beltotto, ecco il capitolo sul Fodd, tanto celebrato, mna a volte criticato.
Masterchef. no pasaran!
Ma come si arriva al porno food? E, intanto, di che si tratta?
Lo spiega bene in un intervento sul sito spaghettilocomotion,
Nicola Perullo, intellettuale del cibo, che insegna a Pollenzo,
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sita nelle
Langhe: «Il porno food è un moltiplicatore di immagini che ha
dato origine a un vero e proprio voyeurismo gastronomico: un
onanismo del cibo che si rivolge anche ai modi di preparazione
e al consumo di piatti sempre più complessi e sofisticati. Piatti
che trovano nelle foto e nei video il loro primo linguaggio descrittivo».
Facciamo l’esempio del «giardino di carne»: un terrazzamento
di carne di vitello alla brace con tanto di rose ottenute da
sottofiletto, terriccio di battuta al coltello e tulipani di salsicce.
A margine, un articolo di Gabriele Peroni lo racconta. Con
immagini oscene e terrificanti sequenze iconografiche di una
pompa che, intanto, innaffia la mostruosa composizione con litri
di succoso Jack Daniel’s. Alla fine, si contano 81.140 calorie, di
cui quattro chili e mezzo soltanto di grasso.
Il piacere della pietanza è sostituito da un piano immateriale
che cancella il cibo prima ancora che un boccone sia entrato in
bocca. Un’orgia che nulla ha più a che vedere con l’esigenza di
nutrirsi, e nemmeno con il simbolico del cibo. È, appunto, puro
e semplice onanismo.
Se parliamo di onanismo, giocoforza entra in campo Nigella
Lawson, il cui approccio è, generalmente, «stasera ho voglia di
fare una porcata».
Come: chi è Nigella? È la regina delle giornaliste che si sono
trasformate in conduttrici di programmi dedicati alla cucina.
Almeno cinque i titoli televisivi e milioni di lettori per i suoi
libri. In Italia cinque volumi tradotti con successo. Ma Nigella
è molto di più.
Ah! Nigella, che ti fa ingrassare e pensare sporco. Nigella che
porta il sesso in cucina. La moracciona teorizza l’emozione genitale
come suo primo ingrediente. Nigella, sogno erotico di ogni
nonnastro che all’ora di Nigella si piazza davanti allo schermo
incurante del valore Lhd di ostriche e bistecche al sangue e risveglia
antichi desideri. Lawson è la stella di un richiamo televisivo
potente che porta il cibo a diventare esclusivamente advertising
e doppio senso sessuale.
Nigella diventa l’imperatrice dai cui lombi, ancora sodi, derivano
tutti i lombi televisivi. Lei è la Rachele della cucina in
tv, la Sara di una cultura un tanto al chilo, la Ester che mescola
piacere a piacere, la Giuditta che si prende cura della tua gola.
Il segreto del successo globale tributato alla cucina onanistica
è l’idea di fondo ormai accolta dalla comunità mediatica: il cibo,
nella sua concretezza, deve scomparire per trasformarsi, come
accade con l’autoerotismo, in fantasia immateriale, oppure in
spettacolo, prima televisivo, poi editoriale, poi social; la digestione
lo porta a diventare prodotto pubblicitario, identità che al
mondo dei social piace infinitamente.
Così come scompare, sotto i cieli del cibo di plastica, l’ospitalità,
sostituita dalle mossette e dalle finte gaffe della tondeggiante
patrona di Rai 1 Antonella Clerici, una sorta di Moira Orfei
del grande circo enogastronomico.
Il cibo scompare, ma non la potenza dell’altro messaggio, sempre
presente sui giornali che si prendono cura del tuo aspetto: se
mangi sei colpevole, perché «il mondo è allo stremo e tu ti ingozzi»;
se ci si abbuffa, il colesterolo impoverisce la società e «non ci
possiamo permettere i malati»; e poi, è chiaro che essere perennemente
sovrappeso impoverisce esteticamente il pianeta, in quanto,
come si nota su ogni copertina di magazine, «grasso è brutto».
In compenso, il cibo è spalmato ovunque: nella pubblicità,
nei film, nei libri, sui giornali, nelle rubriche, come metafora,
come ossimoro, come analogia.
Ormai da tempo, nelle top ten dei libri più venduti, tre o
quattro sono dedicati al cibo.
Ma quando nasce la liturgia televisiva legata al cibo?
In Italia, l’origine della faccenda è ascrivibile a Corrado
Mantoni, il popolare presentatore televisivo che, appena approdato
alla corte di Berlusconi, s’inventò la prima sciagura gastrocatodica,
Il pranzo è servito, andata in onda dal 1982 al 1990. Ma
la vera Shangri-La della cucina virtuale è MasterChef, un format
televisivo trasmesso dalla Bbc per la prima volta nel 1990. Gli
autori ci rimisero seriamente mano nel 2005: e deflagrò come
un’epidemia. Il mondo si mise a cucinare davanti alle telecamere
a ogni ora del giorno e della notte. In Italia la prima edizione è
andata in onda, trionfalmente, il 21 settembre 2011.
Il format si compone di tre professionisti del fornello che
massacrano dilettanti volontariamente piegati a un’inspiegabile
forma di masochismo. Tre cuochi e duecentoventimila follower,
un esercito di dilettanti allo sbaraglio.
Ormai la cucina è un enorme set televisivo, anzi, potremmo
dire che, se non cucini in televisione, non cucini affatto. Cucinano
tutti, bene, male, così così. Una pletora di apprendisti alle
prese con fornelli, sughi, grassi e necessari accostamenti con vini
di varia origine e natura. Il risultato, in genere, si trasforma in
un volume di ricette che entra di lì a poco nella top ten di tutte
le classifiche.
Dunque, il cibo vero, quello fatto di gusto e profumi, scompare,
e all’incauto popolo occidentale si propongono ricette che
sappiano globalizzarne le tendenze. Esotismo, internazionalismo
e vere e proprie scemenze coprono l’antica cultura del cibo.
Le nostre figlie non sanno più fare la spesa ma conoscono
l’indirizzo del miglior kebabbaro su piazza.
Pensate al successo della nouvelle cuisine o alla cosiddetta e
misterica cucina molecolare, la cucina, si fa per dire, che vuole
soppiantare la cultura della nonna sostituendola con quella che
definisce «una vera e propria scienza». Come i futuristi proposero
il loro Manifesto della Cucina Futurista, questi scienziati
hanno redatto Il Manifesto della Cucina Molecolare Italiana. Il
profeta del movimento è lo spagnolo Ferran Adrià, che, a dire
il vero, preferisce alla dizione «molecolare» quella di «tecnoemozionale».
Ferran ha portato in cucina l’azoto liquido e ha
inventato il gelato-polenta.
Dice di sé: «Non sono un cuoco raffinato: preferisco leggere
che cucinare. Ma vuoi mettere una marmellata pachistana o una
birra analcolica irachena?».
Nel 2010, la ferale notizia: elBulli, il ristorante di Adrià,
avrebbe chiuso per sempre. El mejor cocinero de o mundo si
sarebbe dedicato esclusivamente alla sua fondazione. Una scelta
sofferta, ha dichiarato. Forse c’entrava anche il mezzo milione
all’anno che la reggia del profeta perdeva e che l’azoto liquido
non contribuiva a recuperare.
Insomma, il cibo come business. Una delle chiavi per comprendere
l’Expo.
Provate a immaginare, al tempo dell’Expo tricolore, un mondo
senza Carlo Petrini e orbo di Oscar Farinetti, i dioscuri che
ci stanno aiutando a resistere alla barbarie in cucina.
Impossibile, vero? Sono due giganti, di vita e di pensiero,
che hanno annusato un’esigenza reale e vi hanno posto rimedio.
Sapete qual è la necessità cui i due hanno dato una risposta, convincente
e reale? L’incapacità degli italiani di credere in se stessi
per davvero. Del resto, anche se nessuno se lo ricorda, siamo una
nazione che, da sempre calpesta e derisa, è vittima di eterni rancori
familistici, ha perso la guerra che bisognava vincere dopo
averne vinta una che sarebbe stato conveniente non combattere.
Siamo capaci di dare il meglio di noi stessi in isolate azioni
eroiche, ma il governo di una nazione non fa per noi: che cosa si
può pensare di un popolo che nel corso di un centinaio di anni
è riuscito a tradire sempre quelli con cui si era alleato?
Insomma, noi siamo l’alfa e l’omega dell’ipocrisia.
Quando Giuliano Soria, patron del Grinzane Cavour, denunciò
il meglio del meglio della patria cultura come compagnia di
ineffabili scrocconi, si levarono grasse risate, le stesse che, suppongo,
si udivano nella locanda dei Thénardier, i carcerieri della
povera Cosette nei Miserabili di Hugo.
In questo caso, più che Cosette sono emerse le imprese di
quelli che al mattino sfilano con la Cgil e di sera sono accusati di
eludere il fisco per depositare il bottino su conti offshore.
Prima che con i reati, conviviamo con l’ipocrisia.
Anche sul cibo, che pure per noi è una ragion d’essere che il
mondo ci copia con successo per tanti motivi, siamo indecisi a
tutto: istituzioni che non sanno salvaguardare i prodotti nazionali
perché il ministro del Nord difende a spada tratta la polenta
taragna, e quello del Sud il friariello; perché le nostre organizzazioni
devono sostenere le prebende dei propri dirigenti e sono
disinteressate a fare sistema; perché i Comuni vogliono la denominazione
comunale ma non maneggiano le regole dell’Unione
europea, che è l’unica ad avere ancora soldi; perché i nostri emigranti
hanno insegnato al mondo a fare il parmigiano, la salsiccia
e il vino come si faceva a casa loro prima di partire. E oggi il
mondo prova a fare a meno di noi, nel produrre vini e specialità
d’eccellenza. Siamo «calpesti, derisi, perché non siam popolo,
perché siam divisi». Novaro e Mameli ci conoscevano bene.
E non siamo popolo perché l’unica comunità che riconosciamo
è quella dei cugini, non dei fratelli, che consideriamo avversari
di una sempiterna eredità contesa.
Per non parlare dei padri e dei maestri, che azzanniamo a
ogni piè sospinto.
Conosciamo, amiamo e utilizziamo, invece, la consorteria di
vicinato, cioè la copia violenta della famiglia. La consorteria, ossia
quella specie di mafia che costringe il passante a pagar dazio
se attraversa la via che occupiamo e che consideriamo l’unica
nostra patria. L’unico valore per il quale combattere.
Le consorterie sono innumerevoli: giornalisti e tassisti, farmacisti
e notai, artigiani e militari. Persino i precari, dopo un po’
diventano consortili.
Va detto anche che tali consorzi di interesse, quando hanno
potuto lavorare alla luce del sole, hanno fatto grande in passato
anche il nostro comparto alimentare. Nel mondo globalizzato
sarebbero invece costretti a far sistema e imparare ad applicare
le regole che hanno sostituito i bizantinismi. Oggidì vince
il meglio organizzato e il più tecnologicamente attrezzato. Noi
soccombiamo.
In Australia producono il Parmesan, una specie di formaggio
assai somigliante al Parmigiano. Il fatto ci incollerisce, ma
il mondo ride del nostro tentativo di scandalizzare il Far East
perché c’è chi copia.
Nel mondo dove il numero delle connessioni supera quello
degli umani, miliardi di uomini, donne e bambini di ogni colore
e credo religioso se ne fregano allegramente se c’è chi copia il
Made in Italy alimentare. Caro vecchio Artusi, difenditi se e come
puoi, si dice là dove ci si ammazza per un algoritmo.
In questo contesto nascono le ideologie di Carlo e di Oscar.
I nostri due giganti, meglio, i due capi del cibo a chilometro
zero, hanno capito il mondo nel quale vivono e soprattutto lo
hanno saputo interpretare a beneficio di una nazione che coccolano
nei suoi tic nevrotici e nelle ambizioni male organizzate.
Oscar e Carlo, dunque, ci danno esattamente quel che stavamo
cercando, e così ci siamo scoperti grazie a loro una nazione
di osti e di salumai, viviamo un orgoglio di fratellanza attorno al
migliore amico dell’uomo che, in Italia, senza dubbio è il maiale;
concepiamo una superbia intellettuale fondata sul Puzzone di
fossa e sul cappero di Pantelleria.
Guai al prodotto industriale, vituperio per la massaia che cerca
alle sette di sera al supermercato l’insalatina fresca, anatema
per la mela stralucida che vuole farci dimenticare la straordinaria
narrazione di quella meluccia racchietta un po’ incolore e a malapena
saporita che viene dall’orto assolutamente e integralmente
bio cui necessariamente attingiamo per la nostra cambusa.
Non parliamo poi di scienze e ogm.
Petrini, ideologicamente, va oltre. Ci vuole a tavola per ore, ad
assaggiare il cioccolato ecuadoregno al trecento per cento composto
da Cacao Meravigliao, la banana della Costa Rica lunga sei
centimetri e un po’ ammaccata ma libera dai veleni yankee, e ci
impone Vandana Shiva, l’economista indiana antiogm, antidogma,
antindustriale e internazionalista.
Il mondo va così, ma bisogna aver pure un po’ di memoria
e ricordarsi del tempo, ahinoi non lontanissimo, in cui idolatravamo
il vino avvelenato del contadino e i cibi sulla cui qualità
non avevamo alcun controllo. Fa bene ricordare i decenni in cui
eravamo ostaggio di osti disonesti e nulla sapevamo della catena
alimentare. Non eravamo né consumatori né cittadini, ma ignari
viaggiatori nelle mani di chi, acquattato nelle nebbie, tendeva
trappole sanguinose alle nostre ulcere e ai nostri palati.
È un dovere ricordare il 17 marzo 1986, quando deflagrò in
Italia lo scandalo del metanolo, una sostanza velenosa che era
stata malamente mischiata con il vino. Si contarono a decine i
morti e coloro i quali portarono per sempre sulla loro carne gli
effetti di un modo criminale di lavorare il vino.
Vorrei rammentare che di questa scandalosa truffa si sapeva
già tutto almeno da due anni, ma, fino ai morti, nessuno era
intervenuto. Era appena una manciata di anni fa.
L’Italia del vino, travolta dallo scandalo, andò in rovina.
Ci vollero anni per riuscire a risollevarsi, per diventare una
vera e propria corazzata mondiale del settore. Dobbiamo quella
resurrezione ad alcuni straordinari imprenditori, ma anche a un
signore che si chiamava Luigi Veronelli, che, con rigore e con
ostinazione, predicò la necessità di coniugare prodotto, territorio
e cultura.
È dai suoi lombi che arrivano Oscar e Carlo, con tutti i loro
gigionismi e le loro furbizie. Ma anche con un evidente, impareggiabile
genio.
È anche grazie a questi personaggi e a pochi altri, che hanno
imparato a usare la comunicazione e il mondo della rete, se oggi,
quando apro una bottiglia di vino o assaggio un formaggio, posso
dire con voi, be’, grazie a Dio sono italiano anche io.
Marsilio Editori – Collana I nodi
ISBN 978-88-317-2283-4
pp. 208; € 16.00 ; ebook €9.99
In libreria dal 5 novembre



