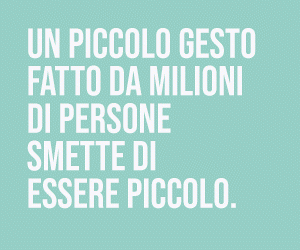Culture
Splendori e miserie del «piuttosto che»
Splendori e miserie del «piuttosto che»
SE stilassimo una classifica delle parole, espressioni e modi di dire - il più delle volte errati - che suscitano maggiore fastidio nelle persone dotate di una certa sensibilità linguistica, piuttosto che usato in funzione disgiuntiva al posto di o sarebbe al primo posto, o quanto meno nella zona alta della classifica. Chi faccia una ricerca in rete troverà decine di siti e pagine web in cui si manifesta insofferenza per l'uso di cui qui si tratta; su Facebook un gruppo intitolato Aboliamo l'uso improprio del »piuttosto che» piace a un cospicuo numero di naviganti; di Carlotta, che nell'ottobre del 2011 ha lanciato su YouTube una videocrociata contro il piuttosto che disgiuntivo, hanno parlato, e bene, radio, televisioni e giornali; il nostro collega Giuseppe Antonelli e Cristina Faloci, conduttore e curatrice del programma La lingua batte di Rai Radio3, ci segnalano che fra gli ascoltatori l'insofferenza nei confronti del piuttosto che è altissima.
Oltre che nel vasto mare della rete, la locuzione incriminata ha vari persecutori nel mondo della letteratura, della musica e della carta stampata. Edoardo Nesi, vincitore del Premio Strega 2011 con Storia della mia gente (Bompiani, Milano 2010), in un'intervista a «D-la Repubblica» del 2 giugno 2012 l'ha definita un'espressione che «nel migliore dei mondi possibili» andrebbe abolita; sulla stessa rivista, poco più di un mese dopo, il 7 luglio 2012, gli ha fatto eco Vinicio Capossela, musicista noto e apprezzato in tutta Europa, che ha detto, senza troppi giri di parole, di odiarla. Stefano Bartezzaghi, che l'ha collocata nella prima pagina del suo libro dedicato ai tormentoni (Non se ne può più, Mondadori, Milano 2010), l'ha definita una sgrammaticatura «a prezzemolo».
Sembra nutrire profondo disprezzo nei confronti di piuttosto che anche Gianrico Carofiglio, che nel romanzo Le perfezioni provvisorie (Sellerio, Palermo 2010) non perdona al nevrotico, malinconico, autoironico avvocato Guerrieri un non c'è problema che gli è scappato di bocca: «Non c'è problema? Ma come parli, Guerrieri? Sei impazzito? Dopo non c'è problema ti rimangono tre passaggi: un attimino, quant'altro e piuttosto che nell'immonda accezione disgiuntiva.
A quel punto sei maturo per andare all'inferno, nel girone degli assassini della lingua italiana». Molti nemici molto onore, potrebbero ribattere i consumatori abituali del piuttosto che in funzione disgiuntiva. Fra costoro, il primo posto spetta di diritto a Michela Vittoria Brambilla, ministra del Turismo dall'8 maggio 2009 al 16 novembre 2011 nel quarto governo Berlusconi: non c'è quasi intervento pubblico che Brambilla non abbia decorato con un piuttosto che usato al posto dì o, indipendentemente dall'argomento trattato, dall'Expo 2015 («Intendiamo sfruttare gli eventi sportivi piuttosto che le celebrazioni dei 150 anni, l'Expo 2015, tutto quanto può essere importante per portare un incoming dal mondo nel nostro paese», convegno Destinazione Italia 2020, Torino, 31 gennaio 2009) al pericolo comunista («La sinistra, in varie forme, sono mesi e mesi che continua per interesse di parte e di partito a cercare di gettare fango sulla nostra grande Italia. lo ricordo le pagine dell"Herald Tribune' acquistate in pieno G8 dall'Italia dei Valori per parlare di mancanza di democrazia in Italia, piuttosto che dichiarazioni antiitaliane contro Italia e contro italiani», L'ultima parola, 7 maggio 2010) via via fino alle battaglie animaliste («La necessità di abolire la vivisezione piuttosto che la caccia e quant'altro», La vita in diretta, 12 dicembre 2012).
Le malelingue potrebbero sostenere che questa passione per il piuttosto che sia da attribuire a uno scarso dominio delle strutture dell'italiano. In effetti, l'ex ministra ha dimostrato qualche difficoltà con la grammatica anche in altre occasioni: per esempio quando, nel corso della puntata del 7 maggio 2010 de L'ultima parola, ha chiesto a Gianluigi Paragone di poter proseguire il suo discorso con uno stupefacente «Mi facci concludere».
E tuttavia, se riconducessimo il successo di piuttosto che al posto di o alla pura e semplice ignoranza delle regole dell'italiano, faremmo un torto sia a Brambilla sia al piuttosto che, perché ormai questa espressione la adoperano un po' tutti: giornalisti, conduttori televisivi, medici, avvocati, stilisti, politici e professori universitari. La crescente ostilità che ha suscitato è il segno evidente del suo dilagare: chi mai se la prenderebbe con il vezzo linguistico di pochi?
Chi ha ragione? Quelli che lo adoperano con disinvoltura o addirittura loostentano o quelli che non lo sopportano e se ne tengono a distanza, quasi a evitare di esserne contaminati?
Piuttosto che è un'espressione dalla storia nobile e antica. Si può ben dire che sia nata e cresciuta con la nostra lingua: compare nei testi più remoti della nostra tradizione scritta, risalenti addirittura al Duecento, e consolida la sua presenza nell'italiano dei secoli successivi. Il primo esempio a noi noto di piuttosto che s'incontra in una versione toscana del Tresor (1260-1266) di Brunetto Latini, il celebre intellettuale fiorentino ricordato da Dante nella sua Commedia: «Ora è quella forza nell'uomo ch'alcuno li tolga più tosto rettorica che no Ili concedesse filosofia» (cioè: c'è nell'uomo quella capacità per cui gli si negherebbe più facilmente la conoscenza della retorica di quanto si ammetterebbero le sue conoscenze di filosofia).
Piuttosto che si presenta come un'espressione ecumenica, nella quale più parole si combinano nell'unica funzione d'introdurre una comparazione. in origine, peraltro, le parole non erano due (piuttosto e che), ma addirittura tre: più, tosto e che. Piuttosto, infatti, nacque dall'incontro di due termini originariamente distinti e separati nella scrittura: più e tosto. La grafia unita (piuttosto) ha prevalso nettamente su quella separata (più tosto) solo a partire dal Settecento, e l'ha soppiantata completamente solo nel Novecento, visto che qualche occorrenza di più tosto si trova ancora nelle opere di Gabriele D'Annunzio (per esempio ne Le novelle della Pescara, 1902: «I mendicanti pativano la fame più tosto che mangiare la carne cotta in quelle pentole») e in quelle di Luigi Pirandello (per esempio, ne II fu Mattia Pascal, 1904: «Procurerò di farmela più tosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli»).
Qual è l'origine e il significato delle due componenti di piuttosto? Più, il cui valore di comparativo di maggioranza è ben noto, proviene dal latino plus, che oggi qualche anima bella anglicizza pronunciando riprovevolmente plas; tosto, per parte sua, è un avverbio che significa «presto». Alla sua origine c'è tostus (participio passato del verbo latino torrere, «tostare»), che al significato originario di «tostato», «essiccato» (e quindi «sodo», «duro») aggiunse, per probabile mediazione dell'antico francese tost, quello di «pronto», «rapido»: di qui il significato di «rapidamente», «presto» assunto dall'avverbio; un significato che possiamo facilmente individuare in un esempio tratto dalla versione toscana del famoso Milione di Marco Polo (ca. 1298), in cui il grande viaggiatore veneziano parla di un vino migliore da bere di qualunque altro; un vino «chiaro e bello», che «inebria più tosto ch'altro vino» (cioè: che ubriaca più rapidamente di qualunque altro vino). Dal significato di «più presto» a quello di «molto più» il passo fu relativamente breve; e così, più tosto divenne una variante rafforzata di più, e più tosto che (diventato in seguito piuttosto che) assunse la funzione comparativa che tuttora ha nell'italiano corretto. La Grammatica italiana di Luca Serianni (Utet, Torino 2010, la più autorevole tra quelle in circolazione) segnala esclusivamente due usi di piuttosto che: uno comparativo e uno avversativo. In funzione comparativa, piuttosto che equivale a più che (come nell'esempio a); in funzione avversativa, piuttosto che equivale ad anziché (come nell'esempio b).
a) «C'è qualcosa nella selva dei circuiti del cervello che trae profitto dal diradamento, piuttosto che dalla concentrazione dei pensieri» (Edoardo Boncinelli, «Corriere della Sera», 6 gennaio 2013).
b) «Intanto, molti di noi conoscono giovani che si sono laureati brillantemente a Roma, ma poi hanno deciso di lavorare a Londra o New York, metropoli sempre a caccia di talenti, piuttosto che rassegnarsi a impieghi sottoqualificati e sottopagati in Italia» (Enrico Marro, «Corriere della Sera», 31 dicembre 2012).
Le indicazioni offerte da Serianni non costituiscono un esempio isolato nel quadro della nostra grammaticografia. Non c'è libro di grammatica antico o moderno, scolastico o non scolastico, per italiani o per stranieri che contenga il benché minimo accenno all'uso di piuttosto che col significato di o: assenza giustificata, perché quest'uso è sostanzialmente estraneo alla storia della nostra lingua. Inutile cercarne esempi non solo in Machiavelli, Alfieri o Manzoni ma anche - se ci è consentito l'accostamento un po' spericolato - in Mazzantini, Starnone o Veronesi. I vocabolari si spingono anche più in là delle grammatiche: alcuni dei più recenti, particolarmente attenti alle novità provenienti dall'uso, considerano il piuttosto che con valore disgiuntivo un modo di dire «improprio» (Zingarelli, Treccani), «ambiguo» (Sabatini-Coletti), che crea «confusioni» (Garzanti).
Quando e dove ha cominciato a diffondersi questa tossina grammaticale? La linguista Ornella Castellani Pollidori, che giustamente la colloca fra i tratti costitutivi del cosiddetto «italiano di plastica», l'ha considerata una moda proveniente dall'Italia settentrionale, «sbocciata in un linguaggio certo non popolare e probabilmente venato di snobismo» a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. I primi a intercettare golosamente questa infelice novità lessicale furono - precisa - i conduttori e i giornalisti televisivi. Dalle loro bocche il piuttosto che disgiuntivo è passato con irresistibile ascesa a quelle degli altri, contaminando linguisticamente un po' tutti. Noi lo condanniamo senza appello, per tre buoni motivi.
Il primo motivo è che quest'uso è in contrasto con la tradizione grammaticale della nostra lingua.
Il secondo motivo è che il piuttosto che abusivamente equiparato a o crea ambiguità nella comunicazione. Mangerò carne piuttosto che pesce: da che italiano è italiano, una frase di questo genere ha indicato una scelta; una o travestita da piuttosto che indica l'esatto contrario di una scelta, e cioè la possibilità di un'alternativa.
Il terzo motivo è che, come direbbe Stefano Bartezzaghi, non ne possiamo più, così di questa come di altre sciatterie linguistiche.
Vogliamo precisare, però, che non ci infastidiscono allo stesso modo tutti gli errori, né ci infastidiscono allo stesso modo gli errori di tutti. Come ha giustamente scritto Valerio Magrelli, è ingiusto infierire contro i parlanti di umile estrazione, di cui si ride in tanti stupidari. Invece, è utile e istruttivo (e, lo confessiamo, anche divertente) fare le bucce a chi di comunicazione vive e vegeta.
Forti di questa convinzione, nelle pagine che seguono abbiamo raccolto un consistente numero di errori fatti da chi, per ruolo o estrazione socioculturale, non dovrebbe permettersi di farli: giornalisti, politici, personaggi del mondo dello spettacolo e così via. Gli autori degli scivoloni riportati non ce ne vogliano: essere citati in un libro che aiuta a evitare gli errori li riscatterà dalle brutte figure e li aiuterà (forse) a non ripeterli mai più.