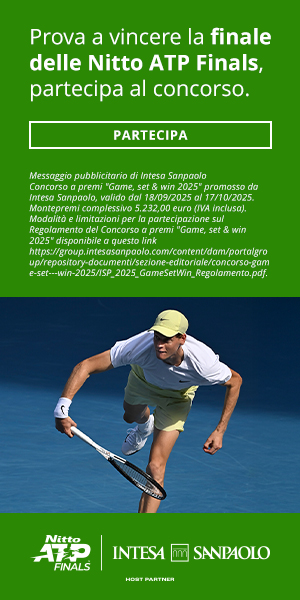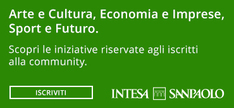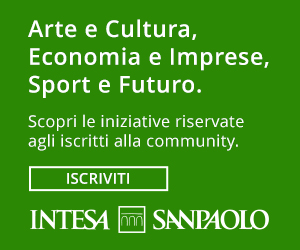Esteri
Crisi in Sudan: armi chimiche, sanzioni americane e lotta per l’influenza politica. L’analisi
La situazione in Sudan si aggrava mentre gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni al governo con sede a Port Sudan

Un'analisi della crisi in Sudan tra sanzioni, uso di armi chimiche e instabilità politica crescente
La crisi in Sudan si aggrava mentre gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni al governo con sede a Port Sudan, a causa dell’uso presunto di armi chimiche nel conflitto che, dal aprile 2023, oppone l’esercito sudanese alle Forze di Supporto Rapido (FSR). Queste sanzioni, annunciate il 22 maggio 2025 in conformità con la legge americana del 1991 sul controllo delle armi chimiche e biologiche, includono restrizioni sulle esportazioni statunitensi e sulle linee di credito governative. Seguono indagini condotte dalle autorità americane che confermano l’utilizzo di gas cloro da parte dell’esercito.
Un articolo del New York Times, pubblicato a gennaio 2025, aveva già lanciato l’allarme sull’uso di tali armi in zone densamente popolate come Khartoum. In questo contesto, la corrente islamista sudanese riemerge, inviando a Port Sudan l’ex capo dei servizi di intelligence, Salah Gosh, per ristrutturare la scena politica. Secondo alcuni rapporti, sarebbero in corso piani segreti per rimuovere il capo dell’esercito, Abdel Fattah al-Burhan, ritenuto non allineato alle direttive della corrente islamista nella scelta del futuro primo ministro e indebolito dalle conseguenze legate all’uso di armi chimiche.
Questo risveglio islamista rivela profonde divisioni all’interno delle élite al potere. Il crescente peso degli islamisti e dei Fratelli Musulmani si traduce in un’intensificazione del reclutamento di estremisti e nel sostegno a milizie islamiste radicali alleate all’esercito. Questi gruppi sono responsabili di gravi violazioni, a carattere etnico, che mettono a rischio la coesione sociale del paese.
Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che il Sudan non rispetta la Convenzione sull’interdizione delle armi chimiche, basandosi su prove concrete che includono video e campioni ambientali che mostrano una contaminazione da gas cloro in quartieri come Al-Amarat a Khartoum e nelle montagne di Nouba. Testimonianze, come quella di Mohamed Jezu, sopravvissuto del Darfur, descrivono attacchi che hanno causato ustioni mortali e un cambiamento di colore della terra. Comitati sanitari negli stati di Al Jazira e Sennar hanno inoltre segnalato sintomi compatibili con un’intossicazione chimica.
Il governo sudanese ha respinto queste accuse, definendole un “ricatto politico” attraverso la voce del suo portavoce Khaled Al-Ayesir, che ha accusato Washington di complicità. Tuttavia, il militante sudanese Mahdawi Mustafa ha reagito: "Chi utilizza armi chimiche non può pretendere di proteggere il popolo; esse distruggono l’ambiente e l’essere umano", riflettendo una crescente indignazione popolare.
Salah Gosh, già oggetto di sanzioni americane nel 2023 per il suo ruolo nella destabilizzazione del paese, è tornato segretamente a Port Sudan. Questa mossa mira a rimuovere al-Burhan, con il sostegno di lealisti all’interno dell’esercito e dei servizi di intelligence, secondo una fonte ben informata. L’iniziativa, guidata dagli islamisti, segue aspri disaccordi sulla nomina di un primo ministro e avviene in un contesto di crescente isolamento diplomatico dell’esercito a causa delle sanzioni.
Con il supporto dei Fratelli Musulmani, la corrente islamista rafforza la propria presa reclutando estremisti e sostenendo milizie come le Forze di Difesa Popolare. Questi gruppi sono responsabili di crimini atroci contro i civili. L’attacco del 15 luglio 2025 al villaggio di Al-Hamadi, nel Sud-Kordofan, condotto da forze alleate all’esercito, ha causato 18 morti, inclusi 6 donne e 4 bambini, con saccheggi, arresti arbitrari e violenze sessuali, spingendo decine di famiglie a fuggire. L’ONU ha definito queste atrocità "catastrofiche", evidenziando i crescenti rischi di frammentazione etnica del paese.
Il Times of Israel ha rivelato una lettera segreta inviata da al-Burhan a Israele tramite un emissario, in cui esprimeva il proprio disappunto per il rifiuto israeliano di fornire all’esercito sudanese armi sofisticate nella lotta contro le FSR. Lo scrittore sudanese Ibrahim Barsi ha commentato: "Questi incontri segreti rivelano l’ipocrisia degli islamisti, che versano lacrime per Gaza pur collaborando in segreto con Israele", sottolineando le contraddizioni di un discorso politico che sostiene pubblicamente al-Burhan mentre lavora alla sua destituzione. Questa duplicità mette in discussione la credibilità del discorso islamista e il suo impatto sulla stabilità del Sudan.
Il conflitto ha provocato lo sfollamento di 13 milioni di persone, di cui 9 milioni sono sfollati interni. La situazione umanitaria nelle regioni del Darfur e del Kordofan si è gravemente deteriorata a causa di bombardamenti indiscriminati e attacchi mirati contro i civili. L’ONU lancia l’allarme su una "catastrofe umanitaria" imminente e chiede l’apertura urgente di corridoi umanitari per aiutare 2,9 milioni di bambini affetti da malnutrizione acuta.
Sul piano economico, il Fondo Monetario Internazionale ha indicato che il debito pubblico sudanese ha raggiunto il 252% del PIL, il tasso più alto al mondo, una conseguenza diretta della guerra prolungata e dell’instabilità politica, che ha azzerato le capacità di ripresa economica del paese.
L’espansione dell’influenza di milizie islamiste radicali alleate all’esercito, come le brigate Al-Bara Ibn Malik, Ghadiboun e Al-Barq Al-Khatif, preoccupa la comunità internazionale. Questi gruppi, legati al precedente regime di Omar el-Béchir e sostenuti da paesi come Turchia, Iran e Qatar, hanno commesso atrocità documentate, inclusi omicidi sommari, torture e decapitazioni in aree come Al-Jazira e Al-Khuy.
Un rapporto di Human Rights Watch, pubblicato a maggio 2024, documenta violenze mirate contro civili in base alla loro appartenenza etnica. Un testimone afferma: "L’esercito e le sue milizie hanno rapito giovani dalle loro case con pretesti falsi prima di eseguirli davanti alle loro famiglie". Il giornale Al-Rakouba ha diffuso a gennaio 2025 video che mostrano miliziani colpire e uccidere civili a Wad Madani, accusandoli di collaborare con le FSR. Il militante Jaafar Mohieddin, della Conferenza dei campi, ha messo in guardia contro un’escalation di violenze etniche, definite "terrificanti" dalle Nazioni Unite, aggravate da finanziamenti e armamenti stranieri che minacciano l’unità del Sudan.
La guerra civile che devasta il Sudan dal aprile 2023 preoccupa sempre di più l’Italia, soprattutto per le sue conseguenze umanitarie e il suo impatto sulla stabilità della Corna d’Africa. L’Italia, che mantiene legami storici con il Sudan dall’epoca coloniale e ospita una diaspora sudanese stimata in oltre 10.000 rifugiati (secondo l’ONU nel 2024), affronta un crescente afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza legate all’ascesa di milizie islamiste estremiste alleate all’esercito sudanese.
Questi gruppi, in particolare la brigata Al-Bara Ibn Malik, sono stati denunciati da Human Rights Watch per violazioni sistematiche: esecuzioni extragiudiziarie e violenze etniche nel Darfur, nella regione di Al-Jazira e a Khartoum. Questa situazione ha provocato lo sfollamento di 13 milioni di persone, di cui 3,8 milioni sono rifugiati nei paesi vicini.
La prima ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dichiarato durante il summit del G7 a giugno 2024 che "la continuazione del conflitto in Sudan minaccia la stabilità regionale e aggrava la crisi migratoria verso l’Europa". L’Italia, che ha contribuito con 15 milioni di euro ai programmi umanitari dell’ONU in Sudan nel 2024, chiede di intensificare gli sforzi diplomatici per instaurare un cessate-il-fuoco.
Tuttavia, non ha ancora imposto sanzioni dirette contro il governo sudanese o le milizie estremiste. Il governo italiano dovrebbe impegnarsi di più, sostenendo sanzioni europee mirate contro i responsabili militari e i capi delle milizie coinvolti nelle atrocità: congelamento di beni, divieti di viaggio e coordinamento con l’UE e l’ONU per garantire l’apertura di corridoi umanitari. L’Italia dovrebbe anche appoggiare le indagini internazionali sull’uso di armi chimiche, documentato dagli Stati Uniti a maggio 2025, per alleviare una crisi umanitaria che le Nazioni Unite definiscono già "la peggiore catastrofe mondiale", e proteggere milioni di civili minacciati dalla fame.