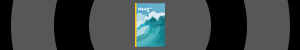Culture
Intervista al giornalista e scrittore Fabio Luppino: “Quei giorni torneranno”
Il giornalista di HuffPost Italia racconta i grandi temi di attualità attraverso la voce delle donne
Esce oggi in libreria Quei giorni torneranno, il nuovo romanzo del giornalista di HuffPost Italia Fabio Luppino, edito da Santelli. Una serie di racconti in cui ad essere protagoniste sono le donne, forze motrici di quasi tutte le grandi questioni di attualità.
Fabio Luppino è un esperto giornalista che da tempo svolge questo mestiere con passione e ha potuto vedere dall’interno i meccanismi delle redazioni più importanti del Paese: venticinque anni a L’Unità, poi Il Secolo XIX, Corriere della Sera e ora HuffPost Italia. Dopo alcune opere che hanno ottenuto un ottimo riscontro, è tornato ora a raccontare la nostra società e i suoi scottanti temi di attualità nelle pagine del nuovo romanzo Quei giorni torneranno, che esce proprio oggi in libreria per Santelli Editore. Si tratta di una raccolta di racconti tenuti insieme da un filo logico e dal fatto di avere come protagoniste le donne: caparbie, coraggiose, intelligenti, talvolta fragili ma sempre pronte a combattere per ciò in cui credono. Dunque uno dei pochissimi libri femministi nel panorama della narrativa contemporanea che porti la firma di un uomo.
Giulia, Caterina, Giovanna, Ginevra e altre sono le voci e i punti di vista attraverso cui Luppino ci mostra senza veli, né peli sulla lingua, cosa accade dentro le mura di una redazione, nel comitato di un movimento studentesco, tra le aule delle scuole o durante una notte d’amore. All’autore interessa entrare nel cuore delle questioni più animate e scottanti del nostro tempo, ripercorrendone la storia e soffermandosi in particolare su due parabole “evolutive”: quella del giornalismo italiano e quella della politica. Affaritaliani.it ha incontrato Fabio Luppino nel giorno di uscita del suo Quei giorni torneranno (Santelli Editore) e lo ha intervistato, vista anche la particolarità dell’approccio femminista che finalmente, per una volta, viene adottato da un uomo.

Fabio, come mai questa scelta di volere solo donne come protagoniste dei tuoi racconti? Tenaci, impavide, con le idee chiare e sempre un passo avanti rispetto agli uomini.
“È una decisione legata all’esperienza di vita che ho avuto, sia sul piano lavorativo che personale. Quello che ho notato nelle donne è, senza voler generalizzare, la capacità di sapersi muovere in maniera originale in situazioni complicate, di porre nuovi temi di discussione, ma anche di assumere ruoli di responsabilità con più coraggio, innovazione e volontà di andare fino in fondo a fronte di una reale convinzione rispetto alla maggioranza degli uomini nelle stesse posizioni; oltre a una diversa interpretazione delle cose del mondo, volendo uscire dall’ambito lavorativo. Non è quindi un caso se gli uomini dei miei racconti sono quasi tutti senza nomi, dal momento che non si dimostrano all’altezza delle loro colleghe e ancor meno delle loro partner. Detto ciò, sottolineo il fatto che non intendo dare una valutazione definitiva di genere, ma riporto semplicemente la mia esperienza”.
Nonostante i buoni propositi, però, molte di queste donne devono scontrarsi con un mondo ancora maschilista che non è pronto ad accettarle, né in ambito professionale né sentimentale. Ecco, allora, che alcune di loro finiscono per diventare vittime del sistema.
“Purtroppo è così. Ad esempio Giovanna, la protagonista del primo racconto, è una donna innamorata che chiede una scelta definitiva e quindi un'assunzione di responsabilità, ma il suo partner, pur essendo travolto da un grande desiderio per lei, non ha la capacità di riconoscere l’importanza di quel sentimento e di conseguenza lo lascia andare. Tutto ciò provoca a Giovanna un grande dolore. Ho voluto raccontare anche questi aspetti della vita privata delle mie protagoniste perché a volte un'enorme forza, ad esempio in ambito lavorativo, può convivere con una certa fragilità emotiva, oppure l’essere idealista e il credere fortemente in un mondo giusto si può scontrare con la fatica quotidiana di dover essere sempre in prima linea a difendere valori che forse non troveranno mai compiutezza. A un certo punto ad alcune di queste donne scorre davanti agli occhi un’esistenza intera di impegno, passione e costanza, che però alla resa dei conti mostra loro la cruda verità: hanno cambiato poco e sofferto tanto. Volevo che le mie figure femminili fossero realiste e calate nel contesto contemporaneo, altrimenti sarebbero state delle wonder women che non esistono. Pur trattandosi di personaggi di immaginazione, sono stato attento a renderle verosimili e credibili”.
Questo è un libro in cui la politica impregna tutte le pagine, a cominciare dal fatto che racconti la storia di un giornale di partito, ma al tempo stesso non parli mai apertamente di politica. Affronti, piuttosto, i grandi temi della nostra epoca.
“Lo si deve al fatto che ho scelto la forma narrativa del racconto e non del saggio o dell’analisi politica. Uso spesso i virgolettati per far emergere il punto di vista delle donne, ad esempio su ciò che dovrebbe essere la scuola attraverso l’esperienza diretta di un’insegnante che crede nel proprio mestiere, ma è costretta a prendere atto di quanto il suo approccio la pone in una condizione di marginalità. D’altra parte, è difficile portarsi dietro i colleghi quando si hanno delle idee importanti, rivoluzionarie e magari scomode, in questo come in altri luoghi di lavoro. Nel libro racconto in particolare due disillusioni: quella per il giornalismo e, per l’appunto, quella per la politica. Tra i tanti, ne è un esempio calzante il movimento studentesco della Pantera, che io seguii come giornalista e che prese vita come protesta contro la riforma Ruberti: di fatto, ciò che i giovani ci hanno insegnato allora è che i politici non avevano idea di come fosse strutturata l’università in quegli anni. Un gruppo di ragazzi che non voleva essere accomunato ad altri precedenti lottò per un’università pubblica dignitosa, eppure a distanza di decenni siamo ancora lì, allo stesso punto, con gli studenti costretti a mettersi in tenda per protestare. Spiace constatare, insomma, che a distanza di trent’anni non è cambiato niente, in questo settore come in molti altri. È per questo che sono critico nei confronti di tutta la politica e non soltanto di certi partiti”.
Il titolo mi ha molto colpito, perché esprime nostalgia e al contempo speranza. Come lo hai scelto? Puoi dirci qualcosa in più anche in merito alla foto in copertina?
“Il titolo si avvera nelle ultime parole del libro. Ho grandissima fiducia nei ragazzi che oggi hanno meno di trent’anni, purtroppo carichi di angosce lasciate in eredità dalla mia generazione, ma pieni di forza interiore per lottare e per migliorare questo mondo. Sono idealisti, eppure hanno la capacità di applicare alla realtà gli studi teorici che hanno fatto. Il nostro compito è quello di guidarli, di aiutarli, ma soprattutto di fare un passo indietro per lasciare loro spazio. Il titolo è in contrasto e al contempo si connette idealmente alla foto scelta, scattata da Alberto Pais: la trovo molto bella sia per i contenuti che per la grafica. È stata realizzata durante una manifestazione a Roma di trent’anni fa, immortalando dei giovani finiti vittime inconsapevoli di una protesta in piazza che avrebbe dovuto essere pacifica. Dimostra, secondo me, al pari del titolo del libro, che non siamo mai alla fine della storia, molto può ancora succedere e cambiare. Tuttavia, a differenza dell’immobilismo e della calma che tendono a consigliare alcune persone dall’alto dei loro pulpiti dorati, le cose non si sistemeranno da sole, perciò se davvero vogliamo salvarci questo è il momento di agire, di fare e di realizzare”.

Seguendo la storia de L’Unità, il tuo libro è anche il racconto di come si sia evoluto il giornalismo in questi anni. A che punto siamo?
“Non a un buon punto, direi, ma non è soltanto colpa della rivoluzione tecnologica o dei social media. Se i giornalisti avessero avuto l’assillo di occuparsi delle cose che accadono nel mondo e fossero andati a viverle in prima persona invece di rintanarsi dietro i propri desk, oggi probabilmente vivremmo un periodo molto meno critico di quello attuale. Avremmo dovuto avere la forza di scegliere di più, specie dove ho lavorato io, senza inseguire l’ambizione di essere una testata generalista; a un certo punto tutti i giornali avevano questa voglia di omologarsi al tema del giorno stabilito da altri, mentre ognuno avrebbe dovuto continuare a percorrere la propria strada e differenziarsi. Oggi, invece, il grande demone è la frenesia dei click e dei like che caratterizza il giornalismo online e fa perdere la visione d’insieme: l’algoritmo conta più della reale importanza di un tema o di un fatto, facendo venire meno le basi del giornalismo stesso”.
Si parla tanto di intelligenza artificiale. Pensi che potrà sostituire il mestiere del giornalista e molti altri?
“Dal mio punto di vista non sostituirà completamente la figura del giornalista e neppure quella di altri professionisti. Se utilizzata in modo utile potrebbe essere senza dubbio una risorsa, ma se il discorso di partenza è il risparmio perché consente di spendere meno, non bisogna dimenticare ciò che la storia ci ha insegnato: chi investe meno, nel medio o lungo termine muore; il che significa – nel caso specifico – che se decidi di fare un giornale con venti figure professionali in meno non andrai nel futuro”.
Tu hai vissuto in prima persona anche la guerra, in particolare quella dell’ex Jugoslavia come inviato de L’Unità. Ne parli nel capitolo finale del tuo libro. Qual è il più grande insegnamento che hai acquisito da questa esperienza?
“Penso di aver compreso che per raccontare bene una guerra occorre ricordarsi sempre i principi fondamentali del giornalismo: questo valeva ieri e vale anche oggi. Intendo dire che bisogna raccontare le cose esattamente come si stanno compiendo nel luogo in cui si è stati inviati dalla propria testata. Questo non è sempre facile, perché spesso i conflitti, specie quelli più cruenti e ideologici, sono blindati e non è consentito ai giornalisti accedere alle informazioni che vorrebbero senza mettere a repentaglio la propria vita. È però importante non limitarsi ad accogliere la storia ufficiale che ci viene fornita, ma entrare nella cultura del posto, capirne le dinamiche e studiare le motivazioni che stanno dietro alle guerre: spesso esse risalgono a molti decenni prima e non sempre corrispondono a ciò che il mainstream vuole imporre. Basti pensare alla guerra in Iraq, il cui pretesto era la presenza di armi di distruzione di massa, all’epoca realtà accettata da tutti come inconfutabile. Venendo all’oggi, ciò che contesto del modo di raccontare il conflitto tra la Russia e l’Ucraina è il fatto che – al netto della chiara esistenza di un aggressore e di un aggredito – ci si dimentica per quanto tempo si è lasciato fare alla Russia il bello e il cattivo tempo, fingendo di non vedere. Dal mio punto di vista gli analisti più avveduti sono quelli capaci di porre domande e non di fornire soluzioni definitive, inequivocabili, o bianche o nere. È stato così anche per la guerra in ex Jugoslavia, quando dopo anni di uccisioni e ingiustizie si è deciso di intervenire solo a fronte di eccidi a ripetizione. Spesso la geopolitica è cattiva consigliera, per questo i giornalisti più bravi e utili sono coloro che vanno sul campo, talvolta autonomamente, e mostrano ciò a cui assistono senza filtri né ideologie”.