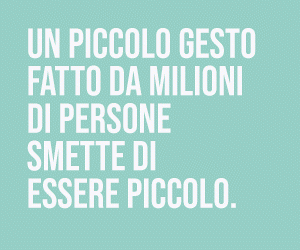Economia
Dazi, difendere l’Italia dalle tempeste geopolitiche si può
Con il ritorno dei dazi americani e la fine dell’illusione di una globalizzazione a costo zero, l’Italia rischia grosso sul fronte dell’export. In un’Europa costretta a svegliarsi, serve una strategia industriale all’altezza della nuova geopolitica econom

Il ritorno della guerra dei dazi: come difendere l’Italia tra tempeste geopolitiche e nuovo pragmatismo economico
C’è un’aria pesante che aleggia sui mercati globali. Non è solo il fardello dell’inflazione che rialza la testa o la persistente instabilità energetica alimentata dalle guerre in corso. C’è qualcosa di più strutturale che minaccia la crescita europea e italiana: il ritorno aggressivo del protezionismo statunitense, formalizzato con l’inasprimento dei dazi commerciali. Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, ha aperto il secondo tempo della sua battaglia contro il multilateralismo economico, imponendo barriere doganali che colpiscono in particolare il cuore produttivo del Vecchio Continente. E l’Italia, paese manifatturiero ed esportatore, rischia di essere tra le vittime principali.
Nonostante questo quadro, l’Italia ha saputo reggere negli ultimi anni l’urto delle crisi globali grazie anche alla prudenza e al rigore della politica economica nazionale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha mantenuto salda la tenuta dei conti pubblici, ha lavorato per garantire credibilità internazionale al sistema Paese e ha cercato – pur tra mille vincoli – di costruire condizioni stabili per gli investimenti. È una base solida da cui ripartire. Ma oggi serve fare un salto.
Il compromesso raggiunto tra Bruxelles e Washington, che prevede dazi medi del 15% su un ampio paniere di beni europei esportati negli Stati Uniti, ha evitato una tariffazione ben più elevata – paventata al 30% – ma non ha impedito effetti reali pesantissimi sull’economia reale. Per l’Italia si parla di un impatto potenziale negativo sull’export pari a 8-10 miliardi di euro nel 2025, con ricadute particolarmente forti in settori simbolo del made in Italy come vino, agroalimentare, moda, meccanica di precisione. E in un contesto dove il dollaro si è già indebolito di oltre il 10% nei confronti dell’euro, il danno è doppio: le imprese italiane vedono i propri prodotti più cari e meno competitivi sui mercati nordamericani.
Questo fenomeno avviene in una congiuntura già fragile. Il PIL italiano cresce poco – lo 0,6% stimato per il 2025 – e l’export, che tradizionalmente ha rappresentato una delle principali fonti di dinamismo economico, rischia di passare da motore a zavorra. Con una BCE più prudente, un’industria che fatica a riprendersi pienamente dagli shock pandemici ed energetici, e un credito che resta selettivo, la minaccia di una “recessione silenziosa” è più di un’ipotesi accademica.
Non è un caso che il dibattito economico stia cambiando tono. Il realismo strategico è tornato al centro. È finita l’epoca delle illusioni sulla globalizzazione a costo zero, e anche l’Europa sembra iniziare a prenderne atto. Il compromesso sui dazi, per quanto indigesto, ha avuto almeno il merito di risvegliare le cancellerie continentali. Francia e Germania discutono ora di politiche industriali comuni, mentre in Italia si torna a parlare – con maggiore pragmatismo – di interventi selettivi per rafforzare il tessuto produttivo, tutelare le filiere strategiche e sostenere le PMI esportatrici. E la parola “compensazione”, fino a ieri relegata al lessico della diplomazia commerciale, entra nell’agenda politica interna: se i dazi colpiscono l’agroalimentare, la meccanica, il lusso, bisogna creare strumenti per reggere l’urto e per rilanciare l’export su altri mercati.
Il governo italiano ha già annunciato contromisure: sostegni fiscali, fondi di garanzia per l’internazionalizzazione, un’accelerazione del PNRR e incentivi per la diversificazione. Ma serve di più. Serve una strategia. Serve una visione. Perché questa non è solo una crisi congiunturale. È l’annuncio di un nuovo paradigma. Trump interpreta il protezionismo non solo come leva economica ma come strumento di potere.
Dietro la retorica dell’“America First” c’è un messaggio molto chiaro: l’ordine multilaterale postbellico è finito, e ogni paese deve tornare a difendere i propri interessi. La sfida americana ai dazi si accompagna infatti a un secondo messaggio: gli alleati devono diventare clienti (soprattutto nel settore dell’energia e della difesa). In altre parole, più acquisti di gas e armi americane in cambio di minori ritorsioni commerciali. È una logica che inquieta, e che richiede risposte non ideologiche, ma strutturate.
L’Italia, in questo scenario, può scegliere tra due approcci: l’adattamento passivo o il posizionamento attivo. Il primo significherebbe limitarsi a rincorrere le decisioni di altri, cercando di mitigarne gli effetti. Il secondo impone un salto di qualità: rafforzare la propria proiezione internazionale, negoziare filiere critiche con i partner europei e asiatici, coordinare i piani di resilienza con una logica produttiva e non solo redistributiva, promuovere un nuovo patto tra sistema industriale, istituzioni finanziarie e politica estera.
È in questo contesto che il ruolo della politica economica deve mutare pelle. Non si tratta più solo di redistribuire risorse o di tenere in equilibrio i conti pubblici. Si tratta di definire una strategia nazionale – ed europea – di difesa degli interessi economici. In altre parole, fare politica industriale, ma con una testa geopolitica. Coordinare l’export con le ambasciate e le missioni diplomatiche, rafforzare l’intelligence economica, sostenere attivamente le imprese nei mercati internazionali, difendere le eccellenze nei consessi multilaterali. Il ritorno della guerra dei dazi ci impone di guardare al commercio internazionale non più come uno spazio neutro, ma come una vera e propria arena di potere.
LEGGI ANCHE: Dazi, Trump esulta per gli accordi ma gli americani piangono: fare la spesa costa già molto di più
L’Italia ha risorse e competenze per farlo. La qualità dei suoi prodotti, la reputazione internazionale delle sue imprese, la sua capacità di dialogare tanto con Washington quanto con Pechino o Delhi, sono asset da valorizzare. Ma serve una regia. Serve un “delivering” politico e tecnico capace di parlare sia ai ministeri che alle imprese, sia alle regioni che alle multinazionali. E serve, soprattutto, una nuova cultura della responsabilità strategica: non serve cedere, ma nemmeno illudersi. Serve una linea chiara, condivisa, che sappia reagire con serietà ai colpi che arrivano da fuori. Non è il tempo delle frasi ad effetto. È il tempo di risposte sobrie, forti e coordinate. Se l’Italia riuscirà a trasformare questa crisi in una prova di maturità istituzionale ed economica, allora – senza proclami – sarà già un primo passo nella direzione giusta