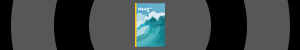Culture
Ecco il Dostoevskij italiano. Andrea Piva racconta "L'"Animale notturno"
Scrivere per gioco, giocare per scrivere: la storia di Andrea Piva nelle orme del suo "Animale notturno" braccato dalla vita






L'INTERVISTA/ Sembra un personaggio dell'Ottocento, invece è uno dei narratori moderni più attrezzati e interessanti.
Scrivere per gioco, giocare per scrivere: la storia di Andrea Piva nelle orme del suo "Animale notturno" braccato dalla vita.
Schivo ma non troppo, solitario ma non solo. Lo scrittore barese (di adozione) si racconta ad Affaritaliani.it. "Sono uno di quelli che se nessuno se li calcola soffrono per il non essere stati calcolati, poi però se si parla bene di loro stanno male uguale perché temono di non essere all’altezza. Non ci posso fare niente, ho la guerra in testa".

ROMA - Sembra un personaggio dell'Ottocento russo, uno di quei maledetti "a loro insaputa" che si muovevano nei suoi romanzi Fëdor Michajlovic Dostoevskij: un nome che solo a pronunciarlo ti cresce la barba, uno scrittore che a leggerlo si impara a distinguere l'universo dalle fesserie. E Andrea Piva in comune con Dostoevskij ha proprio questa barba un po' profetica un po' astratta, ma soprattutto un romanzo che l'autore russo ha pubblicato nel 1866 (Il giocatore) e che il nostro narratore avrà letto a metà degli anni Ottanta. Ma a scanso di equivoci, val la pena di chiarire - fin da subito - che Andrea Piva è un giocatore vincente, uno che i soldi li ha portati via dal tavolo. D'accordo, qualche volta li avrà pure lasciati, ma l'impressione è che la bilancia penda nettamente in suo favore. A metà gennaio ha pubblicato L'animale notturno (Giunti, 368 pagine, 16 euro), romanzo accolto con grande attenzione da critici e colleghi scrittori ma soprattutto un libro che pare destinato a (ri)tracciare una specie di don't cross the line tra la sincera maledizione del giocatore e quella presunta dello scrittore. Più che a una separazione delle carriere, il romanzo racconta la storia di una normale perdizione, di una serena deprevazione, di una perfida attrazione erotica. Verso i soldi. "Fare un sacco di soldi, a tutti i costi. Vittorio (Ferragamo, il protagonista del libro; NdR) non ha dubbi: è questo l’unico modo di sfuggire al grigiore della sua vita attuale - recita la sinossi dell'opera -. Sceneggiatore appassionato e idealista, a soli trent’anni è già riuscito sia a sfondare che a clamorosamente fallire; d’altronde l’avere rotto il naso al regista con cui lavorava con profitto non è certo un bel biglietto da visita per i produttori, e oggi la sua carriera è decisamente in stallo". Essendo stato recensito da chi può permettersi di parlare di libri senza scadere nell'ovvio, Affari Italiani invece ha intervistato Piva avvicinandosi a lui con la curiosità con cui ci si avvicina a una categoria umana complessa, certamente non ostile (Andrea come sui fratello Alessandro, di mestiere regista e autore dell'indimenticato cult in salsa barese Lacapagira, è un uomo molto spiritoso che fa discreto esercizio di autoironia) ma al tempo stesso "per niente facile" (come direbbe Ivano Fissati). Ecco cosa gli abbiamo chiesto.
La solitudine del giocatore assomiglia a quella dello scrittore, quale delle due è più facile da raccontare?
"Credo quella del giocatore, perché quella dello scrittore è stata già molto indagata, al punto da destare un certo sospetto, oggi, quando raccontata ancora. Del resto quasi sempre la prima cosa che fa lo scrittore in erba è parlare di uno scrittore, com’è pure naturale: senza una vita dietro, raccontare della tua voglia di raccontare è fisiologico. È vero che in effetti anche il giocatore, da un paio di secoli a questa parte, per lo meno da Dostoevskij in poi, è stato molto raccontato, ma io ho avuto la straordinaria opportunità di dirne in modo nuovo, perché negli ultimi anni con l’azzardo siamo arrivati a un bivio di portata storica, questa essendo la prima epoca in cui, grazie alla teoria dei giochi, ci si può approcciare alle carte professionalmente, con aspettative di guadagno concrete nel lungo periodo. Se un tempo al tavolo si portavano più che altro sottosuolo e fantasmi, oggi ci si può sedere con atteggiamento maggiormente consapevole, e cavarne soldi non meno dignitosamente che con qualsiasi altro mestiere. Non è una professione facile, per niente, ma, ecco, il punto è che è diventata almeno potenzialmente una professione. Fatto tutto nuovo".
Quasi undici anni tra un romanzo (Apocalisse da camera, Einaudi 2006) e l'altro (L'animale notturno, Giunti 2017). Un tempo infinito, che in altri Paesi depone in favore della qualità ed è garanzia soprattutto per i lettori. Ma che in Italia viene vissuto come un'assenza, come una colpa da espiare. Come l'ha vissuta invece Andrea Piva?
"Oh, guarda, il mio rapporto con la scrittura e il mondo della cultura è sempre stato molto conflittuale, e sebbene siano quasi trent’anni che non faccio altro che pensare a cosa e come scrivere, alla fine scrivo pochissimo, o per lo meno pochissimo di quello che faccio ottiene l’imprimatur della mia censura personale. Faccio fatica a trovare storie degne di essere raccontate, che possano potenzialmente rimanere, e il mettermi a inguacchiare la pagina tanto per non è cosa che mi diverta fare. So benissimo come tanti grandi abbiano sostenuto che se non ci si scontra con il foglio bianco con abnegazione e anche una buona dose di cieca disciplina si rischia di lasciare incompiuto anche il grande talento, ma io nel mio piccolo la penso in modo diverso. Secondo me quando ci si forza a scrivere poi nel risultato si vede subito, tranne che per qualche raro caso di rapimento in corsa. Vale qui, almeno per me, il sempiterno monito di mio padre, che da buon salernitano mal sopportava gli “strunz cacat a forza”, in ogni loro espressione. In generale comunque io intendo la letteratura come un dialogo da portare avanti più con i grandi del passato che con la comunità culturale mia contemporanea. Per definizione, nella contemporaneità c’è tutto un rumore di fondo che la storia non ha ancora filtrato, e troppe stelle cadenti ci paiono magnifici soli destinati a durare. In altre parole cerco di farmi influenzare il meno possibile dagli scrittori e dalle tendenze del momento, soprattutto perché ho paura di guardare nel luogo sbagliato. Non che non mi informi e legga e dibatta il più possibile, e qualche amico pure influente nel mondo delle lettere ce l’ho anch’io, ma la mia ambizione è trovare lo spirito del tempo che vivo attraverso la digestione di esperienze fatte più per strada che alle conferenze, e anche per questo abbraccio sempre con passione altre discipline, anche lontanissime dalla letteratura, come per esempio il poker. Sono i miei serbatoi d’ispirazione. Non ho niente contro i simposi e i circoli culturali ma semplicemente non penso che sia quella la mia via di mettere a fuoco le idee. La mia è soprattutto quella di fare nuove cose, anche e soprattutto cazzate, e farle fino in fondo. Poi, a posteriori, vedo cosa posso trarne. Nelle lettere come nella vita. Che da noi pubblicando e comparendo poco si tenda a essere presto dimenticati me ne sono accorto sulla mia pelle, ma cosa farci, sono fatto così, sono un solitario, sono un sognatore. E non mi piace apparire. Non mi piace dire pubblicamente la mia su questa cosa o quell’altra, non credo che lo scrittore debba necessariamente avere un’opinione autorevole su tutto solo perché pubblica un romanzo di finzione ogni santo Natale".
Chiunque chieda a suo fratello, il regista Alessandro, chiarimenti circa la vostra alchimia creativa, riceve da lui sempre la stessa risposta: "Quando sono certo di essere arrivato a un buon punto di un soggetto o di una sceneggiatura, arriva mio fratello e ci mette le mani... e quella che sembrava una buona cosa diventa all'improvviso una cosa straordinaria; possiede un dono di natura, capire quando è il momento di spaccare una storia, quando è il momento di introdurre la straordinarietà all'interno della normalità". E' davvero così? Si sente addosso questo dono naturale?
"Be’, senz’altro è la cosa che di me e della mia cifra stilistica più mi piace sentir dire, però sospetto che qui ci sia l’amor fraterno a metterci lo zampino. Di certo sono uno poco convenzionale nel modo di attaccare le storie, ho sempre accudito con amore la parte di me adolescente con la cresta e il punk rock in cuffia che vuole mettere disordine nell’ordine, in tutto, dalla morale alla narrativa. Trovo il disordine e lo spirito di contraddizione molto creativi. Per me si deve provare sempre altre cose prima di accettare l’ottimità di quelle in atto. Sono uno scettico per indole, e credo che uno scetticismo consapevole e metodico sia il dono più grande di un artista, ma non solo di un artista. Occhio però che non intendo qui lo scetticismo aprioristico di chi non crede in niente alla maniera contemporanea, quello di coloro ai quali puoi dimostrare scientificamente qualsiasi cosa e per loro non è vero mai niente se non corrisponde alla prima opinione magari falsa e balorda che si sono formati in modo totalmente fortuito chissà quanti anni prima e in quali circostanze. Io parlo dello scetticismo nella sua accezione più nobile, quello che è stato a ben guardare il vero motore della nostra indagine sul mondo come specie. Dico lo scetticismo metodologico, quello che sta alla base della scienza più nobile. Quello che mette in discussione ogni forma di dogma. Io li odio, i dogmi. Che cosa insensata. E foriera di quanto male. Nella vita come nell’arte. Se mi si parla di atti di una sceneggiatura mi viene subito voglia di spaccare qualcosa".
Commentando le uscite dell'anno in corso, uno dei padri dell'Editoria italiana contemporanea, Alberto Rollo (per oltre vent'anni direttore letterario Feltrinelli, oggi stesso ruolo a Baldini&Castoldi), l'ha definita "un talento puro". Mica male come complimento, soprattutto se viene da uno che l'Editoria l'ha scritta e riscritta come pochi altri.
"Guarda, che Alberto Rollo abbia detto una cosa così mi emoziona e mi imbarazza. Tanto più che lui è pure uscito da poco per Manni con un libro di rara bellezza poetica. Sono uno di quelli che se nessuno se li calcola soffrono per il non essere stati calcolati, poi però se si parla bene di loro stanno male uguale perché temono di non essere all’altezza, di creare troppa aspettativa, e si chiedono sempre quale sia il fraintendimento di fondo che ha fatto apprezzare le proprie povere cose a terzi tanto autorevoli. Non ci posso fare niente, ho la guerra in testa. Con questo libro ho avuto tutta una serie di momenti così, in cui mi si diceva bene della mia scrittura e io soffrivo. Per dirti, anche il direttore editoriale di Giunti, Antonio Franchini, altro grande padre della nostra editoria contemporanea, ogni volta che ci sentiamo parla del mio libro come di una cosa alta, e io ogni volta non so dove mettere la faccia, né più né meno che se me ne avesse parlato come di un’impresentabile schifezza. È come quando a un esame hai studiato pure bene e però sei insicuro su tutto perché in fondo sei un povero pazzo maniaco, poi il professore ti mette il bel voto e tu pensi di avere operato in qualche modo una forma di truffa ai danni dell’ordinamento. È un modo di difendersi dalla gratificazione. La nemesi dei perfezionisti. Non ci vai mai bene niente. Peggio ancora se si è isolati come me. Uno esce per strada pronto a difendersi dai fantasmi con cui ha dialogato tutto il giorno, e quando non li trova quasi si spiazza. Ma come, ti dici, non eravate tutti pronti a saltarmi al collo? Cosa sono questi sorrisi?".
Lei ha condiviso sogni e libri con Nicola Lagioia, attuale direttore del Salone internazionale del Libro di Torino. Che ricordi ha di quegli anni? E' in quel periodo che ha maturato quella specie di sana ossessione per i soldi? Intendo dire, è quando non si hanno soldi che uno tende a realizzare il desiderio (più che la necessità) di possederli?
"Quando nei Novanta io e Nicola Lagioia abbiamo iniziato il nostro percorso insieme avevamo pochissimi soldi e condividevamo a Milano un appartamentino ai limiti dell’abitabilità, eravamo i classici fuorisede squattrinati, ma stavamo bene, e, contrariamente a quanto succede di solito, lo sapevamo pure. Avevamo le lettere, noi. Era tutto quanto ci serviva, perché ne avevamo una vera e propria malattia, non pensavamo ad altro, proprio materialmente pensavamo solo a quello. E cosa c’è di più bello nella vita di vivere in una grande città da stranieri con l’amico del cuore che condivide con te la più bruciante delle passioni? Passavamo le notti a leggere i classici, a mandare a memoria le poesie, a fare giochi su chi riconosceva più libri prendendone brani a caso. Poi le presentazioni, il teatro quando costava poco e le giornate passate nei parchi e nelle librerie – senza mai comprare niente, va da sé. Tempi meravigliosi. Certo c’era l’incertezza sul futuro, e la consapevolezza di avere scelto un campo in cui guadagnare bene è proprio difficile, ma noi ci sentivamo gli unici esseri viventi rimasti al mondo quando leggevamo i classici insieme, e com’era possibile che la gente non vedesse scritto nei nostri occhi quello che di grande avremmo di certo fatto di lì a poco? Insomma no, niente ossessione: il pensiero del denaro c’era, ma era più volto al principio di sopravvivenza che altro. Poi le cose cambiano, nella vita, e i soldi diventano sempre maggiormente una componente essenziale nelle nostre esistenze, ma Nicola è rimasto così, non è certo diventato uno che vede nei soldi il fine ultimo dell’esistenza, e per fortuna neanche io. Tieni pure presente che l’ossessione per i soldi del mio personaggio è sì in molta parte un’ossessione concreta ma è anche una specie di provocazione, sia sua che del suo autore. È il meccanismo che ho messo a punto al fine di articolare una riflessione sul denaro e su tutta la contemporanea malattia del fare a tutti i costi tanti soldi nella vita. I soldi come valore assoluto. Vittorio è uno che non ha mai badato troppo al denaro, lo si capisce dagli accenni che fa al suo passato, ma per tutta la sua vita da adulto ha avuto a che fare con gente che per il denaro avrebbe fatto qualsiasi cosa, anche in arte, e da questo gli sono venuti grandi problemi, quindi a un certo punto si dice, provocatoriamente, che sì, che cazzo, anche lui proverà a pensare solo ai soldi, nella vita, per vedere cosa può succedere, se anche lui è capace di farne. E soprattutto per vedere se è vero, come sembrano pensare tutti, che con i soldi in banca la vita è una passeggiata di piacere.
Che cammino augura a "L'animale notturno"? Bastava solo tornare a raccontare e a raccontarsi, o la grande accoglienza che ha ricevuto è solo il prologo di un percorso di ulteriori soddisfazioni che il romanzo (tra l'altro) meriterebbe?
"Quando uno pubblica con una certa consapevolezza si augura sempre più che altro di ricevere le attenzioni che crede di meritare nel discorso contemporaneo delle lettere, magari anche solo l’attenzione di quei due critici in croce che ancora affrontano la cosa con serietà. Poi il successo commerciale e i premi sono un po’ un piacevole quanto improbabile surplus, soprattutto dati i tempi. Non è mai impossibile, ma è sempre visto come una cosa residuale, che se succede succede, ma poi non succede mai. Io la vedo così, come dici tu per un verso mi basta mettere a registro storico la mia versione dei fatti. A Nicola Lagioia è successo, però, no? Il suo ultimo libro, che è molto letterario e non certo semplice, ha anche venduto davvero tanto. Evidentemente, impossibile non è. Io personalmente non mi faccio nessuna illusione e penso solo a cos’altro fare adesso, se un film, un romanzo, un campionato di poker o uno di biliardo, hai visto mai che il Dio Nenè Gomez non venga prima o poi a visitarmi in sogno per regalarmi il suo tocco magico con la stecca".
Giocando si bara, lei lo faceva spesso? E uno scrittore lo fa secondo lei, riesce a barare senza farsi sorprendere dal lettore? E una volta scoperti, chi rischia di più: il giocatore o lo scrittore?
"No, per la verità io non ho mai barato in vita mia. A poker si bluffa, quello sì. Senza sapere bluffare al momento giusto non si può diventare buoni giocatori di poker. Ma il bluff di chi conosce la matematica del poker è cosa molto meno romantica di come la si immagina da fuori. Semplicemente si bluffa quando studiando le azioni del nostro avversario si stima che il suo range di mani possibili non contenga un numero di punti forti sufficiente a fare della nostra mossa una mossa a valore atteso negativo nel lungo periodo. Ma certo chi bara c’è, sia a carte che in letteratura. In entrambi i casi, le possibilità di essere scoperti dipendono dalla bravura tecnica di chi mette in atto il trucco e da quella di chi sta dall’altro lato del tavolo. Contro un giocatore davvero forte difficilmente riesci a barare più di una volta senza che qualcosa non gli suoni veramente strano. Così come col lettore scafato il trucchetto narrativo che abbindolerebbe il lettore di bocca buona non passa facilmente. Poi a rischiare di più è senz’altro il baro a carte. Di bari letterari è pieno il mondo e ai bari della scrittura non succede mai niente, tranne forse negli Stati Uniti, dove se fai cazzate la tua carriera può finire in un secondo, che peraltro a me pare eccesso dal lato opposto, incomprensibile quanto il nostro atteggiamento troppo permissivo. Ma al tavolo da gioco non ti finisce solo la carriera. Può finire facilmente la tua salute fisica".
Di notte, quando non riesce a prendere sonno, quali sono i demoni che la vengono più frequentemente a trovare: giocatori, scrittori, sceneggiatori o straordinari nullafacenti. Insomma Piva, a parte se stesso... chi ha veramente paura di incontrare a questo punto della sua vita?
"I soldi".