Economia
Giuseppe Scognamiglio ed eastwest: la rete economico-finanziaria come motore di crescita
eastwest facilita il dialogo tra imprese e istituzioni, trasformandolo in crescita stabile e sostenibile.

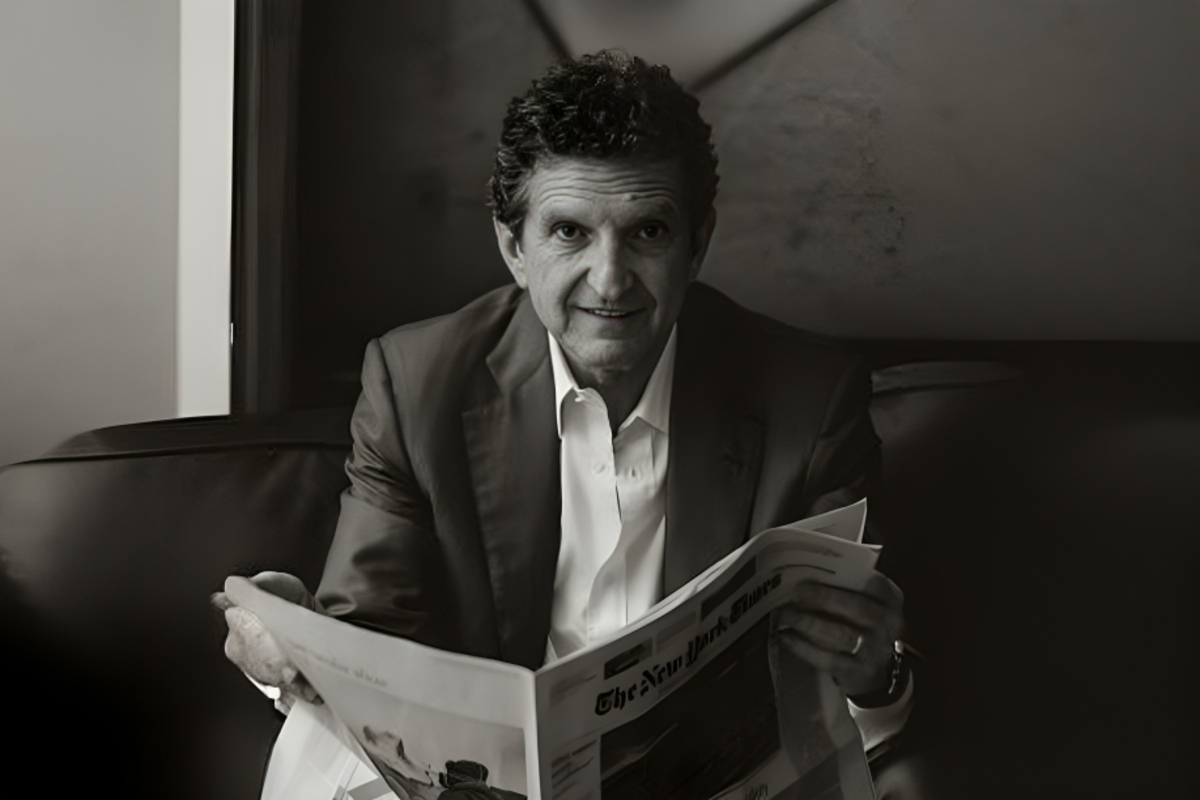
eastwest sta crescendo e si muove con autorevolezza sia nel mondo diplomatico-istituzionale sia in quello delle relazioni industriali. Qual è oggi la vostra missione e come si articola il vostro lavoro?
«eastwest nasce con una missione chiara: connettere imprese, istituzioni e cultura con strumenti di diplomazia pratica e analisi strategica. In vent’anni abbiamo consolidato una presenza in oltre 50 Paesi e siamo l’unica rete italiana di diplomazia economica privata in grado di offrire consulenza strategica, istituzionale e finanziaria lungo tutta la filiera decisionale — dall’analisi di scenario al problem solving operativo nei contesti più complessi.
Siamo un centro indipendente di ricerca, formazione e informazione con prospettiva europea e vocazione internazionale. Nato nel 2004 con il lancio dell’omonimo magazine — distribuito in oltre 50 Paesi e tra i pochi in Europa dedicati alla geopolitica — promuove il dialogo tra culture, elabora analisi strategiche sui grandi temi globali e forma le nuove generazioni di cittadini e professionisti internazionali, coniugando approfondimento accademico e sguardo multidisciplinare.
Quale modello proponete alle aziende che decidono di lavorare con voi?
«Applichiamo un modello di diplomazia strategica: accompagniamo le imprese nella comprensione dei contesti politici, economici e regolatori in cui operano, traducendo l’analisi geopolitica in leve operative. Il nostro approccio è pragmatico e multilivello — dal posizionamento istituzionale alla gestione del rischio paese, fino alla costruzione di partnership pubblico-private. Non offriamo consulenza standard, ma soluzioni su misura che uniscono intelligence economica, relazioni istituzionali e visione di lungo periodo.»
Avete nel vostro portafoglio clienti aziende non solo di rilevanza nazionale, ma di rilevanza strategica per il paese. Può dirci come le supportate nel loro settore?
«Operiamo come interfaccia qualificata tra impresa e sistema pubblico, presidiamo i tavoli decisionali e anticipiamo gli snodi regolatori. Affianchiamo i vertici nelle fasi sensibili — investimenti, autorizzazioni, supply chain, reputazione — allineando obiettivi industriali e interessi istituzionali. Il risultato è un perimetro di sicurezza operativa e posizionamento che consente di competere in mercati complessi.»
Ci nomini delle attività svolte che possano essere di stimolo per tutte le aziende che cercano realtà come la vostra?
«Abbiamo maturato esperienze rilevanti in contesti diversi, sempre con un obiettivo concreto: trasformare complessità geopolitiche e regolatorie in opportunità operative per le imprese. In diversi casi abbiamo supportato aziende italiane ed europee nell’accesso a mercati esteri complessi, costruendo i presupposti istituzionali e regolatori per l’avvio di partnership sostenibili. In altri, abbiamo accompagnato grandi player industriali nella gestione di fasi sensibili — da processi autorizzativi a situazioni di tensione reputazionale — garantendo stabilità, chiarezza nei rapporti con gli stakeholder e continuità operativa.
Ci sono poi progetti legati a programmi europei e investimenti transnazionali, dove il nostro ruolo è stato quello di connettere imprese, istituzioni e finanza in un linguaggio comune, assicurando coerenza e velocità decisionale. In sintesi, il successo per noi si misura nella capacità di rendere gestibili scenari complessi, facilitando il dialogo tra pubblico e privato e producendo risultati tangibili in termini di posizionamento, sicurezza operativa e reputazione.»
Negli ultimi tempi siete cresciuti molto, che obiettivi avete?
«Consolidare la rete internazionale, rafforzare la capacità analitica e formativa, e scalare progetti ad alto impatto per imprese e istituzioni. Puntiamo a essere il punto di riferimento italiano nella diplomazia economica privata, con delivery rapido, standard metodologici elevati e una pipeline di iniziative che generino valore condiviso e stabilità nei contesti in cui operiamo.»
Negli ultimi giorni, il conflitto israelo-palestinese ha vissuto una svolta con l’annuncio della fine della guerra e l’avvio di un cessate il fuoco. Come legge questa fase e che ruolo riconosce alla diplomazia?
«Siamo in una fase delicata e fluida. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato conclusa la guerra a Gaza contestualmente a un accordo che ha previsto lo scambio degli ultimi ostaggi vivi con detenuti palestinesi e un cessate il fuoco sostenuto da mediatori (Egitto, Turchia, Qatar) e da un piano in più punti per la stabilizzazione. Resta tuttavia ampio scetticismo sulla tenuta dell’intesa: nelle ore successive, violenze e accuse reciproche di violazione della tregua hanno dimostrato quanto sia fragile il quadro operativo. In parallelo si discute di nuovi assetti di governance a Gaza e di disarmo di Hamas, con posizioni molto distanti sul terreno.
Ciò detto, ogni cessate il fuoco è una buona notizia quando serve a salvare vite civili. La diplomazia — spesso invisibile — ha costruito i corridoi negoziali, ha orchestrato scambi complessi e ha gestito garanzie sequenziali tra attori che non si riconoscono. È importante ricordare il contesto storico: la traiettoria del conflitto è lunga e stratificata, come documentano da anni centri di ricerca indipendenti. La ricostruzione analitica resta un prerequisito per qualsiasi accordo serio.
La linea di principio è semplice: una pace giusta — basata su sicurezza, diritti e prospettive economiche per entrambe le comunità — è l’unica pace sostenibile. Il compito dei diplomatici, oggi, è trasformare una tregua reversibile in un processo verificabile, con meccanismi di monitoraggio e tempi certi su accesso umanitario, governance e sicurezza. È un lavoro di fino, ma è l’unico che evita di tornare al punto di partenza Devo riconoscere a Donald Trump due meriti: il primo è aver riconosciuto un ruolo politico ad Hamas, come si fa in tutti i conflitti quando ci si vuole sedere ad un tavolo negoziale. Il secondo è utilizzare un vecchio metodo del negoziatore business: mettere il carro davanti ai buoi, cosa che Donald ha fatto quando ha annunciato pubblicamente l’intesa raggiunta a Doha, spiazzando così gli altri attori (leggi: Nethanyau). La stessa abilità non sta funzionando con una diplomazia molto più “scafata”, come quella russa.»
Riguardo al conflitto fra Russia e Ucraina, invece, si parla di un confronto tra Trump e Putin, con perplessità per la possibile esclusione di Zelensky. Qual è la sua lettura?
«Il teatro russo-ucraino è strutturale per la sicurezza europea. Non esiste un cessate il fuoco consolidato e la linea del fronte resta dinamica, con rischi di escalation e pressioni militari continue. In questo quadro, l’ipotesi di un vertice Trump–Putin (è appena saltata l’ipotesi Budapest)— con forte esposizione mediatica e logistica complessa — apre un dossier negoziale tanto potenzialmente utile quanto politicamente sensibile. Nelle ultime settimane sono circolate ipotesi di un incontro bilaterale senza il Presidente Zelensky, che ha però dichiarato disponibilità a partecipare qualora invitato; sullo sfondo, avvertimenti europei per la gestione dei transiti e dei mandati di arresto internazionali che complicano le trasferte del leader russo. Questo conferma che il processo è aperto e in evoluzione, e che la legittimità del tavolo dipenderà anche dall’inclusività.
Sul merito, l’Europa ribadisce che Kyiv deve sedersi al tavolo nella posizione più forte possibile e che i confini non si modificano con la forza. Think tank e osservatori militari segnalano che, allo stato, non ci sono le condizioni per un cessate il fuoco stabile: ogni iniziativa diplomatica deve essere agganciata a verifiche sul terreno e sostenuta da garanzie multilaterali. Detto in termini pratici: servono formali negoziali robusti, sequenziamento delle misure, monitoraggio terzo, incentivi e leverage credibili.
In ogni caso, la diplomazia istituzionale sta lavorando per costruire finestre di de-escalation e cessate il fuoco locali che possano diventare architettura di pace. È un tragitto fatto di micro-risultati verificabili: accesso umanitario, scambi di prigionieri, protezione delle infrastrutture critiche, controlli sulle catene di approvvigionamento bellico. È qui che si misura la qualità di un negoziato.»
C’è chi sostiene che alcune di queste accelerazioni siano funzionali alla propaganda. Come risponde a questa obiezione?
«La diplomazia non ragiona per propaganda, ma per output misurabili: cessazione delle ostilità, riduzione delle vittime civili, garanzie di sicurezza e roadmap attuabile. È comprensibile che vi sia scetticismo sulla durata di alcune tregue o sull’agenda comunicativa di determinati attori; tuttavia, se una finestra negoziale salva vite, va aperta e allargata. Quello che serve è una governance della pace: meccanismi di verifica, condizionalità, sanzioni automatiche in caso di violazioni, e coinvolgimento di istituzioni terze. Solo così una tregua fragile diventa pace giusta.»
«La diplomazia non è un esercizio retorico ma un’infrastruttura critica delle nostre democrazie. Senza diplomazia non c’è sicurezza, non c’è sviluppo, non ci sono investimenti. Attraverso eastwest stiamo costruendo un ecosistema in cui imprese e istituzioni condividono dati, mappe di rischio e strumenti di negoziazione, per andare oltre l’emergenza e creare stabilità. Lavoriamo ogni giorno perché cessate il fuoco e soluzioni negoziali diventino risultati consolidati, nella consapevolezza che una pace giusta è l’unica che chiude davvero un conflitto. È un processo, non un evento: si scrive con pazienza, responsabilità e coraggio di sedersi allo stesso tavolo. Certo, il coraggio deve essere sostenuto da realismo: nelle relazioni internazionali, il diritto internazionale vale se le posizioni di forza siano comparabili. Altrimenti, per raggiungere la cessazione delle ostilità, bisogna anche fare delle concessioni politiche, che forse potevano essere fette prima (leggi la non adesione alla NATO).»




