Libri & Editori
“Di spalle a questo mondo”: Premio Campiello e dozzina dello Strega per Wanda Marasco
Neri Pozza pubblica un’opera-mondo che sfida la narrativa contemporanea e restituisce alla letteratura la sua vocazione più profonda: scavare nell’anima umana
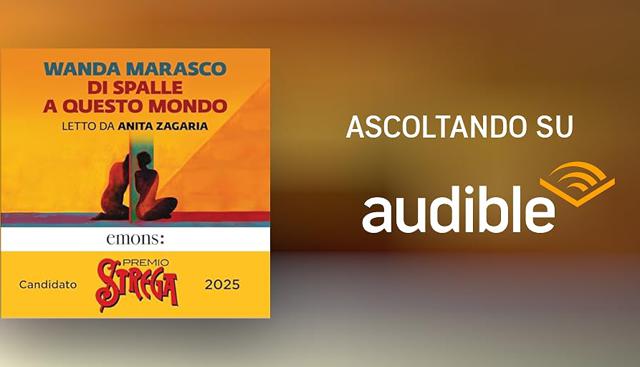
“Di spalle a questo mondo”: Premio Campiello e dozzina dello Strega per Wanda Marasco
Chi ha paura della profondità? Chi osa oggi affrontare con rigore, delicatezza e ferocia la complessità del dolore, dell’amore e della follia? Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco, pubblicato da Neri Pozza, è il grido sommesso ma ineludibile di una scrittrice che non teme il rischio del baratro, e proprio per questo conquista, persuade, resta. Vincitore del Premio Campiello 2025 e nella dozzina dello Strega, il romanzo non si limita a raccontare una storia, ma ne genera una nuova: quella della lingua che si fa corpo, della memoria che si fa carne.
Il libro è ascoltabile anche su Audible, letto da Anita Zagaria: occorre tuttavia un po’ di tempo e pazienza, in quanto dura circa 14 ore e mezzo. Realizzato da Emons Audiolibri, è presente nella sua versione integrale e la Zagaria, già lettrice di molti altri titoli di Audible, riesce a restituirne il giusto tono.
Al centro di questa narrazione, ambientata in un Ottocento teso tra dissoluzione borbonica e vagiti dell’Italia unita, si stagliano due figure tragiche e abbaglianti: Ferdinando Palasciano, medico realmente vissuto, precursore della Croce Rossa, e Olga Pavlova Vavilova, nobildonna russa, sua moglie, creatura dolente e claudicante che dona voce e anima al romanzo. La loro vicenda è una parabola sull’imperfezione, sulla fedeltà al dolore, sull’ostinazione dell’amore. Non un amore salvifico, ma quello che “quando accade, accade all’infinito”, come dice la stessa autrice in un’intervista a Minformo.

Marasco orchestra il suo romanzo con una costruzione musicale, quasi partendo da una partitura: il racconto si snoda in forma di spirale, alternando la voce narrante di Olga – a tratti diaristica, a tratti epistolare – alle visioni frammentate e deliquescenti di Ferdinando. La linearità cronologica viene abbandonata in favore di un tempo interiore, ferito, irregolare. Come ha dichiarato l’autrice sempre alla testata Minformo, a cui è particolarmente legata essendo campana: “Il tempo è il protagonista del romanzo. Non poteva essere lineare perché è il tempo della memoria soggettiva, del sentimento e delle pieghe della psiche. Fatto di schegge, frammenti, onde”.
L’inizio del romanzo coincide con i momenti che si avvicinano alla fine: è il 2 novembre 1887 quando Olga decide di far internare il marito, ormai smarrito nei suoi deliri. Ma da quel momento, invece di chiudersi, il racconto si apre. Si schiude come una ferita che non guarisce, che pulsa nel lettore e lo costringe a una lettura lenta, sacrale, mai passiva.
Nel costruire la figura di Ferdinando Palasciano, Marasco non redige una biografia, ma scolpisce un’icona tragica. Uomo “carico del dolore del mondo”, incapace di distinguere tra amico e nemico quando si tratta di salvare una vita, Ferdinando si vota a un’idea assoluta del Bene che, inevitabilmente, lo conduce alla follia. «Il veleno del mondo è all’origine di ogni esistenza», si legge nel romanzo, e Palasciano lo beve fino all’ultima goccia.
Accanto a lui, Olga. Zoppicante per una ferita infantile eppure lucida nella sua fragilità, è la figura che regge il romanzo come Atlante. È lei che ama, che perdona, che accompagna Ferdinando nel buio senza mai abbandonarlo. La sua claudicanza, fisica e simbolica, diventa paradigma dell’umano: “tutti, in fondo, claudichiamo” scrive Marasco. “La zoppia non si cura, ma si abita”. Olga è il personaggio che porta in sé la tenerezza del disincanto, la sacralità della sopportazione. In lei l’autrice ha confessato di aver “prestato parte della mia psiche”, costruendo un’identità che si muove tra le assenze e le epifanie dell’universo femminile.
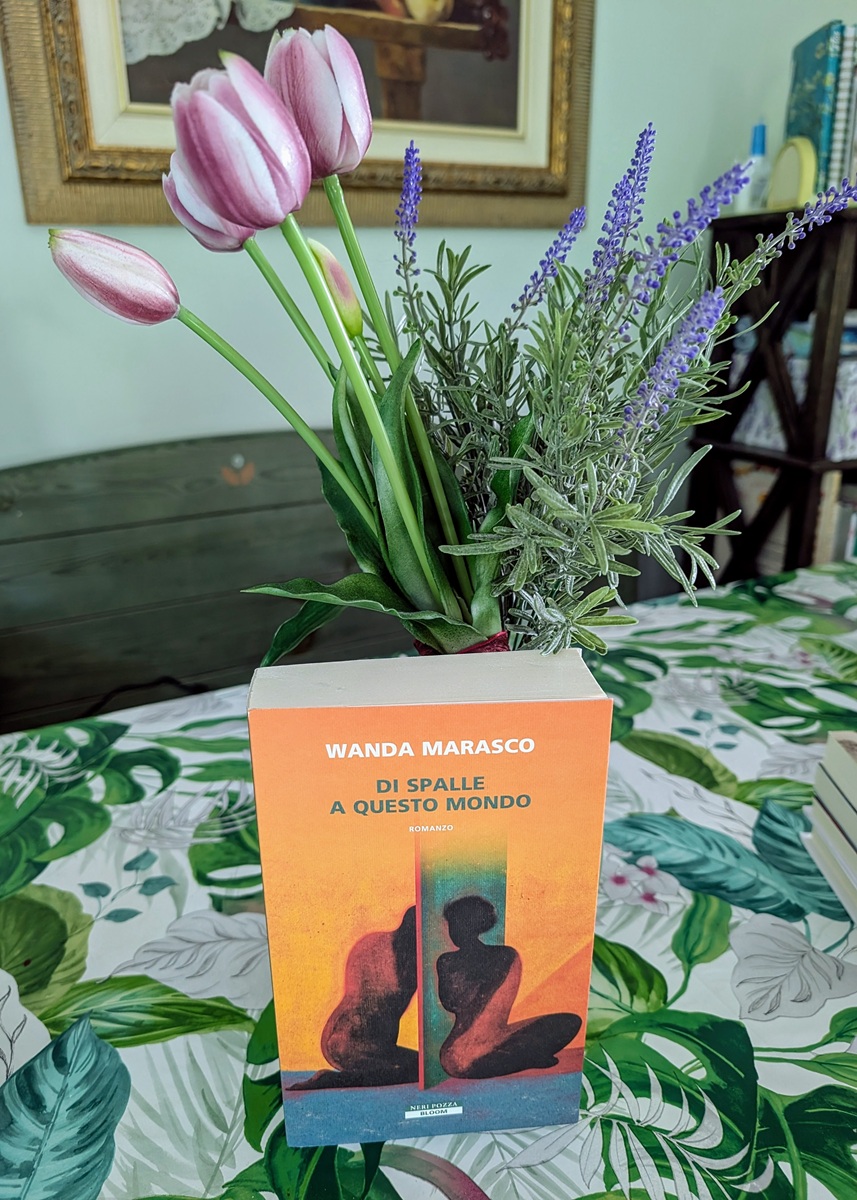
Ambientato nella Torre Palasciano, vera dimora storica sulla collina di Capodimonte, il romanzo trasforma lo spazio in un simbolo: un luogo verticale, prossimo al cielo, in cui la realtà e il delirio si fondono. Napoli, mai folcloristica, mai cartolina, diventa una città dolente, “alta”, “smarginata”, un corpo che respira. “Napoli è un inferno animato dall’idea del paradiso da distruggere” ha detto l’autrice a Il Manifesto, e questa definizione sembra racchiudere l’intera visione del romanzo.
Il tratto distintivo dell’opera è senza dubbio la lingua. Marasco unisce il dialetto napoletano, la lingua materna, alla poesia colta, alla precisione della terminologia medica, al barocco di una sintassi imprevedibile. “La lingua – dice – è il primo personaggio del romanzo”. È una lingua che vibra, sanguina, consola e ferisce. Come ha scritto Cesare Segre: “In Wanda Marasco colgo almeno due tratti decisivi: la raffinatezza della scrittura […] e lo slancio drammatico che dà ai personaggi uno stacco e un dinamismo straordinari”.
Non è dunque un caso che Giulia Ciarapica, nel proporre l’opera al Premio Strega 2025, abbia motivato così la sua scelta: «Marasco parte dal corpo, e in primo luogo quello dei due protagonisti, per far sì che proprio questo strumento umano si trasformi in uno strumento di scrittura, […] con una lingua che non ha altri punti di riferimento se non sé stessa, un lavoro di artigiano raffinatissimo che unisce più dimensioni: la lingua di appartenenza, quella delle madri, quella d’origine casalinga; quella imparata, […] e quella della poesia, grazie a cui Marasco, con pochi termini sontuosi e tuttavia terreni, riesce a dare parola e sostanza all’invisibile che rincorriamo ogni giorno».
Marasco affronta i temi più ardui – la malattia mentale, la morte, l’ingiustizia, l’amore assoluto – con uno sguardo che oscilla tra pietà e visione. La follia di Ferdinando è letta non come patologia, ma come iper-lucidità, come incapacità di reggere il peso dell’empatia. È l’amore per l’umanità che lo annienta. La fedeltà, in questo contesto, non è una scelta morale ma un atto poetico. Voltarsi “di spalle a questo mondo” diventa un gesto di fedeltà alla propria verità, all’idea dell’Assoluto.
La critica ha accolto il romanzo con entusiasmo e rispetto. Molti ne hanno riconosciuto la densità filosofica, la forza evocativa, il coraggio linguistico. “Un romanzo difficile e generoso – scrive Daniela Marra – che non urla, ma resta”. Altri hanno parlato di “prosa poetica che merita tutti i premi”, di “opera perfetta” che riscrive il romanzo italiano contemporaneo.
Napoletana, poetessa e drammaturga, Wanda Marasco è autrice di romanzi che hanno lasciato il segno: L’arciere d’infanzia, vincitore del Bagutta Opera Prima; Il genio dell’abbandono (finalista Strega 2015); La compagnia delle anime finte (finalista Strega 2017). Diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica, ha una formazione teatrale che traspare nella costruzione scenica dei suoi testi. La scrittura, dice, è per lei “una casa”, “un attraversamento”.
Di spalle a questo mondo è un romanzo che esige tempo, silenzio, concentrazione. Un romanzo che non si consuma, ma si deposita. Che non si legge, ma si vive. È un libro che ci chiede di essere vulnerabili, che ci costringe a guardarci nell’abisso dell’imperfezione. E ci suggerisce, con discrezione, che forse la bellezza non sta nella guarigione, ma nella ferita stessa.





