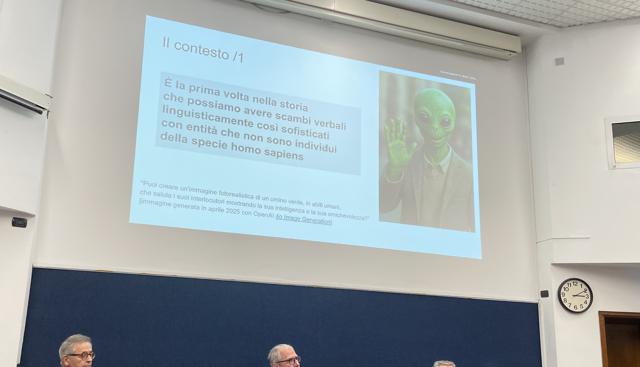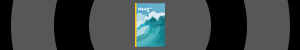Blog AI
FONDI E PROGETTI EUROPEI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ETICA, LOTTA ALLE GUERRE
In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. E’ attivo un servizio...