Culture
L'Italia? Non tutta va a rotoli. Ecco il libro che la salva. Intervista


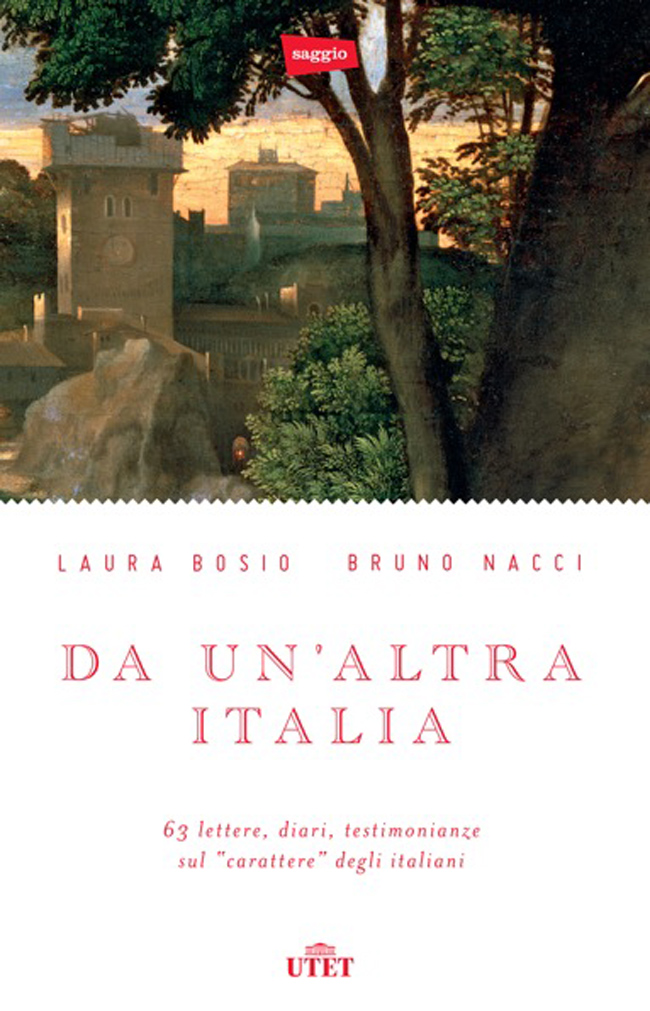

Esiste un’altra Italia, è sempre esistita. Questa, poco nota ai più, è quella proposta con analisi non sociologiche o antropologiche da Laura Bosio e Bruno Nacci che nel nuovo libro "Da un'altra Italia" (UTET) danno voce, attraverso documenti in prevalenza privati, a un “carattere” italiano poco rappresentato. Mentre dilagano i ritratti, infatti, spesso grotteschi, dei difetti nazionali come la cialtroneria, lo scarso senso dello stato e della collettività, l’individualismo sregolato, il familismo, il cinismo gaudente, il lamento perenne, in queste pagine emerge un “carattere” che non solo nel passato, glorioso e irripetibile, ma anche nel presente rivela una diversa tempra morale degli italiani, una serietà e una tenacia che non di rado si trasforma in abnegazione, nel lavoro, negli affetti, nell’impegno politico, nei gravi momenti dell’emergenza ma anche della quotidianità. Un lavoro che nasce dal desiderio di opporsi alla diffusa rassegnazione per pensare a come sia ancora possibile fare affidamento sulla tenuta di un popolo migliore di quello che crede (o vogliono fargli credere) di essere.
INTERVISTA AGLI AUTORI
Come vi è venuta l'idea di questo libro?
Dalla volontà di dare voce a un "carattere" italiano poco o per nulla rappresentato. Prevalgono i ritratti grotteschi, le maschere dei difetti "congeniti" dell'italianità: cialtroneria, tendenza ad accodarsi al vincitore, scarso senso dello stato e della collettività, individualismo sregolato, familismo, cinismo gaudente, insomma quello che potremmo chiamare l'albertosordismo, tragicamente fotografato dal grande attore e, nel suo stadio finale, da film come La grande bellezza.
E invece?
E invece esiste, è sempre esistito, un altro "carattere" dove si manifesta una diversa tempra morale, una serietà e una tenacia che non di rado si trasforma in abnegazione, nel lavoro, negli affetti, nell'impegno politico, nei gravi momenti dell'emergenza ma anche della quotidianità. Ed è questo "carattere" di cui abbiamo cercato esempi, soprattutto nelle lettere, dall'Unità al Novecento, scegliendo quelle che ci parlavano di più, con la scommessa che potessero parlare a molti italiani.
E pensate di averli trovati?
Crediamo di sì. Ci eravamo detti che il libro sarebbe nato soltanto se avessimo trovato quegli esempi, e così è stato. Abbiamo letto e passato in rassegna molti epistolari - le lettere hanno un'immediatezza rivelatrice - privilegiando, prima degli autori, i testi, la loro forza, la limpidezza, il coraggio, sui temi più vari, non soltanto politici. Leggerli di volta in volta ci commuoveva, ci infiammava, ci sorprendeva, anche quelli che conoscevamo già. Era come vederli in un'altra luce.
Quale, tra i personaggi citati, volete "raccontare" ai lettori di Affaritaliani.it e perché?
La risposta più precisa e più spontanea sarebbe "tutti", da Mazzini a La Farina, a Anna Maria Mozzoni, Carlo Michelstaedter, Alberto Savinio, Vittorio Foa, Eugenio Colorni, Alberto e Giovanni Pirelli, Tersilla Fenoglio Oppedisano, Cristina Campo, Tommaso Di Ciaula, Cesarino Branduani, Giorgio Ambrosoli, soldati, emigranti senza nome… Raccontiamo di Ranuccio Bianchi Bandinelli, uno dei maggiori studiosi europei di archeologia e antichità classiche. Nel 1938, di fronte a un incredulo ministro della pubblica istruzione, rifiutò un prestigioso incarico in Grecia per non dover subentrare un collega allontanato in forza delle leggi razziali. Nel 1944 lasciò l'insegnamento all'Università di Firenze per non fingere, dopo l'8 settembre, una neutralità pilatesca: "Noi abbiamo il dovere di parteggiare". E a chi obiettava che se tutti ne fossero andati l'università sarebbe rimasta vuota, ribatteva che non si trattava di conservare un'istituzione, un guscio vuoto, ma di far sì che sopravvivesse la sua essenza etica.
Come si può definire l'"altra Italia" di cui parlate?
Un testimone scomodo del periodo tra le due guerre, Walter Binni, in vecchiaia avrebbe confessato: "Io che ho visto un'altra Italia". Le voci di questi uomini e queste donne - noti o sconosciuti, letterati, artisti, operai, emigranti, soldati, di qualsiasi fede politica o religiosa - a volte sembrano venire da una realtà quasi non più comprensibile. Ma quella realtà, quell'"altra Italia" è qui, c'è sempre stata e continua a essere presente anche se viene raramente rappresentata.
Non è un'indagine sociologica, quindi…
No, non ne avremmo avuto i mezzi né era nostra intenzione. Volevamo esprimere, attraverso parole di altri, parole sincere e frutto di storie autentiche, l'insofferenza, che non è soltanto nostra, per la diffusa rassegnazione o peggio.
Perché proprio in questi giorni è importante che arrivi questo "lato" dell'italiano?
Perché siamo convinti che in questi tempi di babele delle lingue, e non solo quelle della politica, sia ancora possibile fare affidamento sulla tenuta di un popolo migliore di quello che crede, o vogliono fargli credere, di essere.
Avevate in mente un modello?
Sì, gli Uomini tedeschi di Walter Benjamin, modello inarrivabile. In tempi ben diversamente tragici, l'unica forma di ribellione e di dignità possibile a Benjamin sembrò quella di far parlare i grandi tedeschi del passato. Come lui, non abbiamo però cercato solo esempi "alti" ma anche voci di anonimi cittadini, uomini e donne, che potevano riferirsi a circostanze private e apparentemente di poco conto, ma secondo noi esemplari.
Con questo libro allora avete voluto parlare dei nostri tempi?
Non è un libro rivolto al passato, nostalgico o pessimista, né acriticamente ottimista. In queste pagine però c'è fiducia, che deriva dalla constatazione realistica, concreta, al di là di idee acquisite o ideologie. In molte lettere si evidenzia un tratto che ci sembra fondamentale: la volontà, appunto, di parteggiare, di non sottrarsi all'impegno, che sia politico o che riguardi il lavoro o gli affetti. Questo libro potrebbe favorire anche una migliore coscienza storica degli italiani… chissà, ce lo auguriamo. Gli italiani, ha scritto Le Goff, portano con sé un grande peso: la consapevolezza di essere un popolo vecchissimo, il sentimento di una decadenza fra la gloria delle origini e lo stato attuale e l'inquietudine di esistere come stato, come popolo, solo da poco tempo e in modo precario. Una combinazione di elementi esplosiva.
E cioè?
È la fiducia in quel "carattere" italiano che qui si testimonia: serietà, sacrificio, estro e ironia non disgiunti dalla fermezza. Da non credere, eppure…
Leggendo la lettera di Giaime Pintor si ha il ritratto di una gioventù molto motivata, concreta, matura. Oggi come sono i giovani italiani?
I giovani di oggi non sono né peggiori né migliori di quelli di ieri, ma, per citare un famoso passo di Conrad, aspettano di attraversare la loro linea d'ombra... Saranno le circostanze a dire chi sarà riuscito e chi no. Certo nuoce alla loro formazione una specie di paternalismo pietoso e pessimista (sono bamboccioni, non troveranno mai lavoro, stanno troppo in famiglia ecc.), mentre se ne incontrano di ottimi, facce pulite, schiene diritte, teste lucide, e ovunque, tra gli studenti e i laureati o i ragazzi che lavorano. Un trentenne, qualche sera fa, commentando l'ennesimo giudizio catastrofico sull'Italia e gli italiani ha esclamato: adesso vogliono dare a tutti la colpa delle porcherie che hanno fatto in pochi, sempre gli stessi. Io lavoro tutto il giorno e spesso anche la notte, pago le tasse, mantengo la famiglia, e sono italiano, c.!, ma non sono un ladro né un fallito, né un mantenuto...



