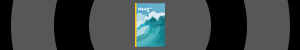Politica
Riforma costituzionale e premierato. Cronaca di un fallimento annunciato

L’unico precedente storico è di cattivo auspicio: il fulmineo disastro israeliano
Riforma costituzionale e premierato italiano
Quest’estate, dal palco del vertice ONU sui sistemi alimentari, la presidente Giorgia Meloni citava Cicerone e gli riconosceva il merito di aver lasciato ai posteri grandi insegnamenti sull’importanza dell’agricoltura.
Quando si tratta di riforme costituzionali, però, agli italianissimi Cicerone e Machiavelli, per i quali la storia è «maestra di vita e delle nostre azioni», palazzo Chigi sembra preferire il francogenovese Valéry, e «la storia diventa la scienza delle cose che non si ripetono».
Et voilà: il premierato. La nuova forma di governo che il Consiglio dei Ministri propone per risolvere i problemi atavici della politica italiana: instabilità degli esecutivi, trasformismo parlamentare, la presunta carenza democratica insita nell’altrettanto presunta mancanza di corrispondenza tra risultato delle urne e nome del capo del governo.
Un solo precedente storico: il premierato israeliano. Durata dell’esperimento: cinque anni, dal 1996 al 2001, praticamente il tempo di una singola legislatura. Elezioni in un quinquennio: tre. Presidenti del Consiglio avvicendatisi in un quinquennio: tre. Se avevano ragione Cicerone e Machiavelli, siamo spacciati.
Il “premierato” israeliano (1996-2003)
Nel 1992, Israele decise di mettere un punto alla frammentazione partitica e alla conseguente paralisi politica sperimentate negli anni Ottanta. La soluzione si chiamava “premierato”: una sorta di presidenzialismo contenuto entro l’architettura fondamentale di una repubblica parlamentare (quali sono Israele e Italia), con un capo dello Stato dotato di poteri di rappresentanza e il vincolo di fiducia parlamentare.
Cardini del premierato israeliano erano:
- elezione diretta e a suffragio universale del primo ministro, ossia del capo del governo, contestuale e contemporanea all’elezione per il rinnovo del Knesset (unica Camera del Parlamento israeliano);
- doppia scheda elettorale: su una era possibile votare il primo ministro, sull’altra il partito o la coalizione preferita per il Knesset, con conseguente possibilità di voto disgiunto;
- impossibilità di governi “tecnici”: il primo ministro doveva essere eletto anche come parlamentare;
- obbligo per il primo ministro eletto di ottenere, prima del suo insediamento, il voto di fiducia del Knesset e di mantenerne la fiducia per tutta la legislatura: il Knesset poteva votare la “sfiducia” al primo ministro in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta (50%+1) dei propri componenti;
- “aut simul stabunt, aut simul cadent” (insieme staranno o insieme cadranno): il voto di sfiducia del Knesset al primo ministro avrebbe comportato automaticamente lo scioglimento della Camera, così da portare a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi (con alcune eccezioni, come la morte o le dimissioni del primo ministro).
Obiettivi dichiarati del “premierato” israeliano erano:
- governi più forti e capaci di portare a termine la legislatura, grazie alla legittimazione ricevuta dal mandato popolare diretto del primo ministro;
- governi possibili solo come espressione del voto popolare, e non di colpi di mano parlamentari;
- riduzione del numero dei partiti e del potere di ricatto dei micropartiti, sia nella formazione dei governi sia nelle decisioni sull’allocazione delle risorse finanziarie.
Risultato: un disastro, non solo per la durata dell’esperimento ma anche e soprattutto negli esiti politici. Nessuno degli obiettivi fu raggiunto, anzi:
- nessun governo “premierale” si rivelò capace di portare a termine la legislatura, al contrario aumentò l’instabilità: tre primi ministri (Netanyahu, Barak e Sharon) e due legislature del Knesset in sei anni e otto mesi di premierato (prima del ritorno al vecchio sistema elettorale nel febbraio 2003), a fronte di otto diversi primi ministri nei quasi cinquant’anni precedenti;
- il numero di partiti nella maggioranza aumentò, in media, invece di diminuire: le coalizioni a sostegno di Netanyahu e Barak contavano otto partiti, quelle a sostegno dei due governi precedenti tre;
- la proliferazione di nuovi partiti, decisivi per le sorti dell’esecutivo, favorì un’inefficiente allocazione delle risorse finanziarie, costringendo i governi ad aumentare le spese per soddisfare istanze “particolari”, causa l’eterogeneità di posizioni interne alla maggioranza, e paralizzò l’azione dell’esecutivo nell’affrontare sfide fondamentali ma divisive come il processo di pace israelo-palestinese;
- le elezioni del 2001 registrarono l’affluenza più bassa nella storia del Paese.
Un fallimento che si potrebbe definire, senz’enfasi, epocale, tant’è che negli ultimi vent’anni decine sono state le nuove costituzioni approvate (e riformate) in giro per il mondo e in nessuna di queste si è tentato di riproporre un sistema simile. Almeno fino a oggi.
Il disegno di legge costituzionale italiano
Il disegno di legge costituzionale approvato dall’ultimo Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, come abbiamo visto, persegue esattamente gli stessi obiettivi che Israele aveva fatto propri nel 1992 (stabilità, lotta al trasformismo e legittimazione democratica del premier) e intende farlo con una soluzione non solo omonima ma anche molto simile a quella israeliana.
Il disegno di legge costituzionale italiano, infatti, introduce:
- l’elezione diretta e a suffragio universale del Presidente del Consiglio, per cinque anni, contemporanea e contestuale a quella per il rinnovo delle Camere, su scheda elettorale unica;
- un sistema elettorale basato sui principi di governabilità e rappresentatività che garantisca alla coalizione a sostegno del primo ministro eletto il 55% dei seggi in entrambe le Camere;
- nuovi meccanismi nel sistema di fiducia parlamentare, che resta sempre necessaria sia per l’insediamento del Governo sia per la prosecuzione del mandato, ma disciplinata secondo il principio del simul stabunt, con un’unica eccezione: in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può decidere se riassegnare l’incarico al premier dimissionario o incaricare un altro parlamentare della stessa maggioranza (in caso di fallimento, elezioni in entrambi i casi);
- obbligo di avere un primo ministro “politico”, in quanto necessariamente eletto anche come parlamentare.
Quale destino per il premierato italiano?
Le analogie con il premierato israeliano sono evidenti. Saranno causa di un destino comune? Chi si augura il contrario può sperare nelle sottili (ma non necessariamente irrilevanti) differenze tecniche e nelle più consistenti differenze sociologiche tra elettorato italiano ed elettorato israeliano.
Per gli analisti, le principali cause del fallimento israeliano furono tre:
- il mantenimento di una legge elettorale proporzionale (che assegna a ogni partito un numero di seggi proporzionato ai voti conseguiti) e la mancata adozione di una legge elettorale maggioritaria (che sacrifica la rappresentatività della composizione parlamentare per assegnare un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene più voti);
- il mantenimento del vincolo di fiducia tra l’organo legislativo, il Parlamento, e quello esecutivo, il Governo, che permette sempre al primo di tenere “in ostaggio” il secondo, anche se il capo del governo è stato eletto direttamente dal popolo;
- la grande frammentazione, ora come allora, della società israeliana, che a fine anni Novanta sperimentò, per giunta, l’ingresso nel Paese di più di un milione di ebrei russofoni provenienti dall’ex Unione Sovietica (su una popolazione totale che all’epoca contava poco più di sei milioni di abitanti).
Con ordine.
Primo: se è vero che le principali cause tecniche del fallimento del premierato israeliano furono il mantenimento del proporzionale e il voto disgiunto, il Governo Meloni risponde inserendo il maggioritario e la scheda unica addirittura in Costituzione e garantendo almeno il 55% dei seggi alla coalizione vincente. A ben vedere, però, anche il secondo governo premierale israeliano, quello a guida Ehud Barak, era sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare (75 parlamentari su 120). I problemi vengono (e vennero, anche in quel caso) non all’inizio, durante la luna di miele elettorale, ma dopo un po’, quando serpeggia il malcontento, si moltiplicano le istanze e le coalizioni iniziano a sfaldarsi. Il 55% dei seggi al Senato italiano equivale a una maggioranza di venti voti, cioè quanto può conseguire, con l’attuale sistema elettorale, un partito che ottenga anche meno del 10% delle preferenze. La Corte costituzionale, poi, l’ha già detto nel 2014: il maggioritario va bene sì, ma con moderazione, fintanto che non produce storture eccessive nella rispondenza della composizione del Parlamento rispetto agli esiti del voto (che è principio fondamentale dell’ordinamento italiano, la cui violazione può invalidare anche norme costituzionali). Anche la scheda unica è una soluzione che va valutata alla prova dei fatti: certo, può prevenire il voto disgiunto ma non può impedire a più di due candidati di correre per Palazzo Chigi e creare una situazione simile a quella del 2013, che non potrebbe essere stravolta in sede di ripartizione dei seggi.
Secondo: il vincolo di fiducia parlamentare resiste anche nella proposta di riforma italiana. Anzi, mentre la sfiducia del Knesset al primo ministro israeliano esigeva i voti della maggioranza dei membri dell’assemblea, la sfiducia italiana è approvata con la maggioranza semplice dei soli votanti. Anche la riforma italiana, poi, prevede un’eccezione al simul stabunt: la possibilità per il capo dello Stato di proporre un primo ministro diverso da quello eletto. Il requisito che tale nuovo soggetto debba appartenere alla stessa maggioranza politica del premier dimissionario, in un panorama politico composito e cangiante quale è quello italiano, è un presidio antiribaltone destinato a cadere dopo qualche appello alla responsabilità, come le mura di Gerico all’ultimo squillo di tromba israelitica.
Terzo: chi spera nel successo del premierato italiano dovrà forse fare affidamento sulla sociologia, più che sul diritto costituzionale, perché è vero che la riuscita di una forma di governo e di un sistema elettorale dipendono, in larga parte, dalla compatibilità degli stessi con l’assetto sociopolitico dell’elettorato e con la realtà storica della nazione. E, da questo punto di vista, le differenze tra Italia e Israele sono tante e importanti.
Israele è demograficamente condannata (se di condanna si può parlare) al proporzionalismo e al pluripartitismo da una società assai composita ed etnicamente disomogenea, in cui convivono ebrei aschenaziti (di provenienza centroeuropea), sefarditi (di provenienza nordafricana), sionisti laici e un milione di haredim ultraortodossi, più di un milione di russi (e russofoni) di origine ebraica e quasi due milioni di arabi. Quasi tutti riunitisi in un territorio tanto circoscritto in epoca storicamente recente. Nessuna di queste culture è maggioranza assoluta nel Paese e anzi i rapporti numerici cambiano nel tempo, grazie alla maggiore prolificità delle minoranze araba e ortodossa.
La popolazione italiana è sei volte quella di Israele, ma anche una delle più culturalmente omogenee, in Occidente e nel mondo: una sola lingua (l’italiano), una sola cultura religiosa dominante (quella cattolica), quasi il 90% degli abitanti appartenente a un solo ceppo etnico-culturale: quello italiano (combinazione di ascendenze diversissime ma oggi unito e praticamente indistinguibile, a differenza – per esempio – del Belgio di fiamminghi e valloni, del Canada o della Spagna). Sono solo politiche le differenze che portarono alla guerra civile nel ’43, economiche quelle che separano oggi Nord e Sud del Paese. Prova ne sia che l’unico partito regionale nella storia del Paese capace di conquistare una certa rilevanza politica, la Lega, ha dovuto assumere vocazione nazionale per non sparire.
L’Italia, poi, a differenza di Israele, non è circondata da nazioni, popoli o Stati che ne negano l’esistenza e ne anelano la distruzione. Tutto questo ha senz’altro un peso sull’assetto costituzionale.
Eppure se la vocazione maggioritaria dell’elettorato italiano è durata un battito di ciglia, un motivo ci dovrà pur essere. L’unico a non vedersi ente unitario, infatti, sembra proprio il popolo italiano: le divisioni politiche ne hanno percorso la storia tanto da degenerare prima in guerra civile, poi negli Anni di piombo e in quello che Almirante voleva definire “stato di guerra interno”.
«Chi non conosce la storia è destinato a ripeterla», sosteneva Santayana. «E quelli che la studiano sono destinati a vedere come la storia si ripeta per colpa di quelli che non la studiano» gli risponde oggi una simpatica vignetta sul web.
Il premierato israeliana non è riuscito nel raggiungimento dei suoi obiettivi, dice la storia. Quello italiano? Chissà.
Un’ultima differenza è però certa e fondamentale: Israele non ha mai avuto una costituzione formale e quindi, riconosciuto il fallimento, si è sbarazzata del fardello in men che non si dica. In Italia, per abbandonare il premierato, bisognerebbe rimettere mano alla carta costituzionale e attendere i tempi di un’altra riforma costituzionale, di un’altra maggioranza qualificata o di un altro referendum …