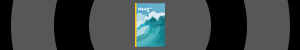Politica
"Senato delle Regioni antidoto al caos. Riforme, che cosa insegna il Covid"

Intervista di Affari al costituzionalista Morrone: "Sarebbe una garanzia anche per il governo". E sull'ultimo Dpcm: "E' venuto meno il requisito di legalità"
La pandemia da Covid 19, oltre a mostrare la debolezza e l’affanno del sistema sanitario, almeno nei primi mesi di diffusione del contagio, ha evidenziato anche tutti i limiti di uno scarso e farraginoso coordinamento tra i livelli di governo che esistono nel nostro Paese. Da un lato i decreti e i Dpcm e dall’altro le ordinanze regionali e comunali, non sempre in linea con le decisioni prese a livello centrale, che hanno innescato una lunga teoria di ricorsi al Tar. Fino al paradosso, che è emerso proprio con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 18 ottobre. Il provvedimento stabilisce la possibilità di chiudere strade o piazze nei centri urbani dopo le ore 21, ma senza specificare a chi spetta la disposizione di questa chiusura. In un primo momento era stata ipotizzata, infatti, in capo ai sindaci. Salvo, poi, fare marcia indietro di fronte all’alt dei primi cittadini e al loro rifiuto di vedersi scaricare sulle proprie spalle la responsabilità di un “coprifuoco”. Insomma, si è passati dalle accuse di decisioni troppo centralizzate al rifiuto di spazi di autonomia. Una situazione che Andrea Morrone, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Bologna, definisce “paradossale”. Intervistato da Affaritaliani.it, il costituzionalista sottolinea proprio come “siamo alla commedia degli errori, sembra quasi il teatro dell’assurdo perché un Paese che si proclama federalista si trova a dover affrontare situazione in cui i primi soggetti dell’autonomia, appunto i sindaci, rifiutano spazi di autonomia che il governo riconosce loro”.
Professore, il Covid ha creato il cortocircuito tra i vari livelli di governo in Italia oppure l’emergenza pandemica ha solo accentuato la confusione?
Io credo che questa situazione metta in evidenza tre paradossi. Il primo riguarda la contraddizione tra uno stato d’emergenza, una situazione di assoluta o relativa non conoscibilità degli eventi, e l’esigenza del Paese di essere razionalmente in grado di riprogrammare se stesso per fronteggiarla, con i mezzi più opportuni.
Una contraddizione ad oggi ancora in essere oppure il governo è adesso in grado di farvi fronte?
Probabilmente si può dare una risposta positiva. Nel senso che il tempo trascorso dai primi focolai dovrebbe aver consentito al governo, con il supporto del Comitato tecnico scientifico, di avere dati e informazioni sufficienti per impostare risposte adeguate.
Passiamo al secondo paradosso, allora.
Riguarda proprio la dialettica tra centro e periferia, tra un centralismo delle decisioni, che una emergenza globale come quella attuale richiede, e l’esigenza di tutelare e rispettare le autonomie territoriali. Ma non finisce qui.
Continui.
Il terzo paradosso riguarda, infine, il rapporto tra le misure centrali e la loro applicazione sui territori. Un paradosso emerso in tutta la sua evidenza proprio dopo l’ultima conferenza stampa del premier Conte durante la quale il presidente del Consiglio annunciava poteri d’intervento dei sindaci su strade e piazze dei propri centri urbani. Peccato che, poi, nel testo del decreto sia scomparso ogni riferimento al soggetto che può adottare misure anti-assembramento. E questo è un elemento che preoccupa.
Per quale ragione?
Perché viene meno il requisito della legalità degli atti amministrativi. Il requisito minimo di un provvedimento amministrativo affinché sia legale è, infatti, che predetermini il soggetto competente ad adottare l’atto. Nel testo, invece, si parla genericamente del potere di chiudere strade e piazze. La classica toppa peggio del buco. Alla fine della storia, comunque, ci ritroviamo con una norma senza soggetto: non si sa chi possa disporre queste misure, se l’autorità pubblica di sicurezza, e quindi i prefetti, se i questori, se i sindaci o i tavoli locali deputati.
Tra Dpcm e ordinanze della Protezione civile, delle Regioni e dei Comuni, chi decide in Italia?
C’è una premessa da fare e cioè che nessuna Costituzione può permettersi di non avere in sé i rimedi per fronteggiare situazioni d’emergenza che potrebbero portare alla sua stessa distruzione e a quella dello Stato. Da qui discende la catena normativa e cioè tutta quella serie di atti che da questo principio della sicurezza o salute della Repubblica ne consegue. In sintesi, c’è una rete di centri potere che parte dal centro e poi si dirama nelle periferie, attraverso le Regioni e fino ai Comuni. Il problema casomai è il coordinamento.
Prima di affrontare questo nodo, riusciamo a ricostruire la catena normativa?
Oltre alla Costituzione, che non può - lo ripeto - non contemplare la propria salvezza, nel nostro ordinamento abbiamo un’ottima legge sulla Protezione civile, un impianto normativo che è il risultato di una lunga esperienza storica nel fronteggiare i terremoti e secondo il quale la gestione delle emergenze spetta al governo e alla presidenza del Consiglio dei ministri.
In che modo?
Proprio attraverso una serie provvedimenti a partire dal decreto che dichiara lo Stato d’emergenza e fino alle ordinanze di attuazione.
Oltre alla legge sulla Protezione civile, la nostra legislazione su cosa ha fatto affidamento?
C’è la legislazione sull’emergenza sanitaria, che stabilisce poteri d’ordinanza in capo al ministro della Salute, alle Regioni e ai sindaci come autorità sanitaria locale. Senza dimenticare il decreto legge di marzo che ha ridefinito questo quadro. Da qui sono discesi i Dpcm, lo strumento più utilizzato, e le varie ordinanze dei singoli ministri, dei presidenti di Regione e infine dei sindaci.
Una catena normativa legittima?
L’impianto normativo è stato seguito sia per proclamare lo stato d’emergenza, sia per la nomina del commissario straordinario e sia per legittimare le ordinanze. Le misure sono perfettamente all’interno del quadro costituzionale. Altra cosa, poi, è discutere della legittimità delle singole misure.
In che senso?
Non è che nell’emergenza sia legittima qualunque norma. Occorre fare un’analisi caso per caso, in base ai criteri di proporzionalità, valutando se si incorra in un eccesso di misura, ma anche di temporaneità. Considerando, infine, se le misure applicative corrispondano al criterio generale fissato dal governo (che ha previsto ora solo interventi selettivi e per ambiti delimitati e non più un lockdown generalizzato). Ecco perché il coordinamento è necessario.
Affrontiamo questo nodo.
E’ vero che c’è un’emergenza in gran parte ancora oggi sconosciuta nei suoi effetti e nella diffusione, ma è altrettanto vero che abbiamo settimane alle spalle che dovrebbero averci convinto della necessità di tenere insieme l’intera rete di comando. La corsa a fare i primi della classe in una Repubblica delle autonomie non è tollerabile. In uno Stato regionale non si può accettare che le autonomie procedano per proprio conto o, viceversa, che un governo non tenga conto delle diverse realtà territoriali.
Galeotta la riforma del Titolo V?
La questione delle autonomie e del rapporto centro-periferie è più antica. È il problema irrisolto della storia della Repubblica italiana. Le Regioni sono nate quasi per caso. Sono state, poi, depotenziate nella morsa localismo-centralismo. La riforma del Titolo V puntava a rivalorizzarle, attraverso il criterio più competenze-più autonomia-meno Stato. In realtà, questa riforma ha generato conflitti tra Comuni, ex Province, Regioni e Stato. Conflitti che sono stati malamente risolti dalla giurisprudenza e non dalla legislazione.
E che ora, con il virus da fronteggiare, sono venuti ancora di più allo scoperto?
Premesso che c’è stata una lunga catena di errori dalla Costituente ai giorni nostri, credo che nelle situazioni di crisi bisognerebbe avere uno slancio in più. Qui non è in gioco l’autonomia di questa o quella Regione o la tenuta del governo. E’ in gioco il Paese. E uno Stato che si dice democratico e pluralista deve trovare la corretta catena di comando che valorizzi l’unità (di cui il governo è custode), ma anche le autonomie (che hanno le possibilità e i mezzi per conoscere meglio le singole realtà locali).
Ritiene che, a pandemia archiviata, serva intervenire con una riforma costituzionale?
C’era ieri e ci sarà domani l’esigenza di intervenire su alcuni punti. Il problema vero è portare in Parlamento le Regioni. Le Regioni, dotate di così ampi poteri, non possono non avere un luogo nazionale di rappresentanza, che normalmente è la seconda Camera.
Sta dicendo che occorre superare il bicameralismo paritario?
Il bicameralismo paritario non corrisponde a uno Stato regionale come il nostro. Ci vuole un bicameralismo asimmetrico. Con un Senato delle Regioni, presente in diversi altri Paesi, molti problemi di coordinamento sarebbero stati risolti a monte.
In che modo?
Le Regioni avrebbero potuto intervenire per concordare con il governo le misure ed espletare il loro controllo sui Dpcm. E, invece, agiscono da sole, senza rappresentanza nazionale. Questo è il nodo che andrebbe sciolto. Altrimenti il nostro rimarrà un sistema zoppo.
Dovremmo guardare agli Stati Uniti, per esempio. O alla Germania?
Stati Uniti e Germania, intanto, sono Paesi con una forte tradizione federale, con Stati membri e Regioni dotati di ampi poteri di governo territoriale. I Länder tedeschi e gli Stati membri americani hanno un Senato o, come nel caso della Germania, un Consiglio federale in cui le Regioni sono rappresentate. Possono, attraverso il Parlamento, interloquire con il Governo e controllarlo per limitarne l’azione. Non solo.
C’è dell’altro?
I tedeschi hanno stabilito nella loro Costituzione un principio di fedeltà federale. Ciò significa che tutti riconoscono il pluralismo e quindi i diversi livelli di governo, ma quando si tratta di agire, soprattutto laddove ci sono competenze non esattamente delimitate o problemi che trascendono questa o quella realtà locale, istituzioni come appunto il Parlamento bicamerale consentono il dialogo tra tutti.
In sintesi, noi abbiamo un federalismo di facciata?
Il nostro federalismo è un’anatra zoppa. Abbiamo puntato su autonomie e decentramento nel quadro dell’unità della Repubblica, ma autonomie e decentramento non hanno garanzie nazionali. Tra l’altro, a svantaggio dello stesso governo.
Per quale ragione?
Avere un Senato che rappresenti le Regioni è una garanzia in più per l’esecutivo. Farebbe sì che le sue decisioni non fossero isolate, ma prese insieme. Con il consenso di altri comparti dello Stato. D’altronde, la parola federalismo viene dal latino “foedus” che significa alleanza, concertazione.
Una cultura federale, nel senso etimologico del termine, a quanto pare manca in Italia. Non le pare?
La cultura federale nel nostro Paese è stata lacerata dalle lotte politiche. Prima il leghismo, poi la riforma del Titolo V. A seguire la devolution, in risposta alla riforma del 2001. Ognuno si è fatto paladino di una propria idea di federalismo. Senza tenere conto, però, di cosa federalismo significhi davvero.